


Q uattro anni fa, giorno più giorno meno, Barack Obama salutava la sua rielezione a Presidente degli Stati Uniti assicurando agli americani – e un po’ a tutti noi, o almeno così volevamo pensare – che il meglio doveva ancora venire. The best is yet to come, citazione di un brano del repertorio di Frank Sinatra e ultimo di una serie di slogan obamiani improntati all’ottimismo e alla fiducia nel futuro (“Hope”, “Change We Can Believe In”, e naturalmente “Yes We Can”). Parlava della sua presidenza, della prospettiva di altri quattro anni alla Casa Bianca. Ma soprattutto, diceva a una nazione ancora impegnata a leccarsi le ferite dell’undici settembre, due guerre e una devastante crisi finanziaria: non temete. Domani sarà meglio di oggi. I figli staranno meglio dei padri, proprio come i padri sono stati meglio dei nonni, e i nonni molto meglio dei bisnonni. Perché così funziona l’America, così funziona il nostro mondo. No?
Parliamone, sembra dirci adesso un Obama in procinto di lasciare lo Studio Ovale. Date un’occhiata alla lettera aperta che ha scritto per l’Economist, una sorta di passaggio di consegne al suo successore, scritto prima di sapere chi sia. Non che si possa definire Obama “pessimista”, sarebbe l’ossimoro degli ossimori: numeri alla mano, ribadisce che le cose vanno molto meglio di come le descrivono i suoi detrattori, Trump in testa. Ma ammette che qualche nuvola sul futuro c’è. E in un passaggio apparentemente freddo e tecnico, dice una cosa pesantissima, che mina alla base il principale pilastro della fiducia americana (e occidentale) nel futuro: il potere salvifico della tecnologia.
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a progressi tecnologici incredibili grazie a Internet, la banda larga e i dispositivi mobili, l’intelligenza artificiale, la robotica, i materiali avanzati, i miglioramenti nell’efficienza energetica e la medicina personalizzata. Ma per quanto queste innovazioni abbiano cambiato molte vite, non hanno portato a una crescita misurabile della produttività.
Vuol dire più o meno: divertenti gli smartphone, come no. Uno spasso la banda larga, fantastici l’auto che si guida da sola e il kit per sequenziarsi da soli il genoma in bagno. Ma queste cose non stanno creando posti di lavoro, non mettono più soldi in tasca se non a pochissimi eletti, non portano a casa la pagnotta. E non aumentano la produttività del lavoro, che è quello che per anni ci hanno promesso gli evangelisti del digitale. Eppure è soprattutto quello – il fatto che ogni ora di lavoro produca e valga ogni anno un po’ di più – che per decenni ha reso ogni generazione più ricca della precedente. Se quel meccanismo si inceppa, abbiamo un problema.
Quella frase di Obama è l’esempio più recente – e più rilevante, venendo da quello che di solito si considera “l’uomo più potente del mondo” – di uno scetticismo sempre più diffuso verso le tecnologie digitali, e in generale verso la tecnologia di questo primo scorcio di ventunesimo secolo. Tanto più sorprendente perché viene dal presidente digitale per eccellenza, quello arrivato alla Casa Bianca otto anni fa trascinato anche da un sapiente uso dei social network e dei Big Data come strumento per conoscere e raggiungere il proprio elettorato. Obama non lo scrive, ma quel passaggio ha un mandante. Si chiama Robert Gordon, è un economista della Northwestern University, e all’inizio di quest’anno ha pubblicato un lungo saggio, The Rise and Fall of American Growth, subito entrato nei manuali di conversazione della gente che conta. Lawrence Summers (ex rettore di Harvard e già segretario al Tesoro con Bill Clinton) che di Obama è consigliere, ne ha scritto entusiasticamente e lo cita ogni volta che può. I commentatori economici sui quotidiani lo tirano in ballo per spiegare un po’ tutto, dalla crisi di Twitter al motivo per cui alla Federal Reserve Janet Yellen non alza i tassi di interesse.
Il libro raccoglie tesi che Gordon discute da anni, portandole fuori dall’ambito accademico. Ma – come e più dei testi di altri economisti diventati superstar, da Thomas Piketty a Mariana Mazzucato – è un libro scorrevole, accessibile e godibile. Il suo messaggio chiave, però, lo è un po’ meno. Gordon dice in sostanza tre cose, una più sgradevole dell’altra, per le generazioni cresciute a pane e Internet. Uno: la rivoluzione digitale è sopravvalutata. Due: la vera rivoluzione tecnologica, inimitabile e irripetibile, è stata tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, con elettricità, telefono e automobile. Tre: la crescita economica non tornerà più ai livelli stellari resi possibili da quelle innovazioni. Per arrivarci, Gordon parte da una constatazione. Negli ultimi tre decenni e mezzo, la crescita economica (quella cosa che di solito si misura col PIL, e che corrisponde all’aumento della capacità di produrre beni e servizi che hanno un valore per le persone) è stata più lenta rispetto a quella che l’ha preceduta. Questo lo sa più o meno ogni economista, e non vale solo per gli USA. Non è che non si cresca più, ma siamo ben lontani dai picchi degli anni Cinquanta o Sessanta.
E la Grande Crisi (quella iniziata nel 2008 in America per poi contagiare l’Europa, passando da crisi del credito a crisi dei debiti sovrani e dell’euro) non spiega tutto. Perché il pedale sul freno c’era già prima, dalla fine degli anni Settanta. Eppure, proprio allora iniziava un’epoca di trasformazioni tecnologiche velocissime e imprevedibili, nel segno della digitalizzazione, dei computer, poi di Internet. Negli anni Ottanta, dai garage di Bill Gates e Steve Jobs partiva l’era più innovativa della storia umana. Giusto? Non proprio, secondo Gordon, che la prende larga e guarda la big picture. Tanto per cominciare, la crescita economica è di per sé un’invenzione moderna. Da quando esiste l’umanità, non ce n’è praticamente stata fino al 1770. Poi, un secolo di crescita moderata (è la prima rivoluzione industriale, quella dei telai meccanici e della macchina a vapore) ha preparato il terreno a un secolo di crescita straordinariamente rapida tra il 1870 e il 1970.

Cos’è successo dopo il 1870? Parecchio: la nascita delle prime reti elettriche e l’invenzione della lampadina. L’invenzione del telefono. L’invenzione del motore a scoppio. L’invenzione della registrazione del suono. Del cinema. E, in aggiunta e in parte grazie a queste, una serie di invenzioni meno celebrate come i grandi magazzini, i cataloghi postali, i cibi in scatola e il frigorifero, gli ascensori… nel giro di pochi decenni queste innovazioni cambiano, letteralmente, tutto. I capitoli più affascinanti di Gordon sono proprio quelli iniziali, in cui descrive cos’era nel 1870 l’America (e vale per buona parte d’Europa, se è per quello). Là dove oggi ci sono autostrade, grattacieli e ponti sospesi, nel 1870 c’era una distesa di fango, acque malsane ed escrementi. La grande maggioranza delle case non aveva acqua corrente. L’alimentazione era povera e ripetitiva. Il reddito era speso quasi interamente per cibo, casa e vestiti. Il principale mezzo di trasporto era il cavallo, che sarà pure un bell’animale ma impiega giorni e giorni per andare da una città a un’altra, e dissemina le strade dell’una e dell’altra di inequivocabili tracce del suo passaggio, che contribuiscono a una altissima mortalità per malattie infettive.
Solo pochi decenni dopo – lo spazio di un paio di generazioni – le case hanno elettricità, riscaldamento, sono allacciate a reti fognarie separate da quelle dell’acqua potabile (non proprio una banalità), sulle strade le automobili hanno sostituito i cavalli, si può arrivare da una parte all’altra dell’America in una manciata di ore e si può parlare con chiunque in qualunque parte del mondo grazie al telefono. Si lavora in fabbriche organizzate in catene di montaggio. Si fanno acquisti nei grandi magazzini. Si va al cinema – per chi può permetterselo – o si ascoltano dischi. Chi, nato prima del 1870, era ancora vivo nel 1940, faceva fatica a pensare di vivere ancora nello stesso mondo.
Non bisogna aver vinto un Nobel per l’economia per capire che si produce molto di più se si è più sani, meglio nutriti, se si ha una lampadina per lavorare anche dopo il tramonto e se non si deve usare parte della giornata per andare a procurarsi l’acqua alla fonte. Si guadagna di più e si consuma di più. L’economia americana esplode. Non subito in realtà – ci vuole un po’ di tempo prima che quelle innovazioni diano frutti misurabili, e la prima guerra mondiale e il crac del 1929 aggiungono qualche ostacolo. Ma dopo il 1920, negli USA inizia il più spettacolare periodo di crescita economica che Homo sapiens abbia mai conosciuto. La produttività di lavoro e capitale, che nei primi vent’anni del Novecento aumentava in media dello 0,44 per cento l’anno, schizza a un impressionante 1,89 per cento annuo fino al 1970. Non era mai successo. E non è più successo dopo.
Quel dato, infatti, crolla poi allo 0,57 per cento l’anno tra il 1970 e il 1994, per risalire brevemente allo 1,03 per cento tra il 1994 e il 2004 e crollare allo 0,40 per cento tra il 2004 e oggi. Vale a dire che la produttività, oggi, cresce meno di quanto facesse all’inizio del secolo scorso. Arrivati al 1970, spiega Gordon, le Grandi Invenzioni di fine Ottocento avevano ormai dato tutto quello che avevano da dare. Qualche miglioramento a lampadine, automobili o frigoriferi si poteva ancora fare, ma non al punto da incidere significativamente sulla produzione. In compenso, erano arrivati i computer. Era il loro turno di cambiare il mondo. Un capitolo incluso nella seconda parte del libro si intitola “Can the future match the great invention of the past?”. Il fatto che si apra con uno sprezzante esergo del venture capitalist Peter Thiel (“volevamo le auto volanti, invece ci dobbiamo accontentare di 140 caratteri”) fa intuire che la risposta non sarà “sì”.
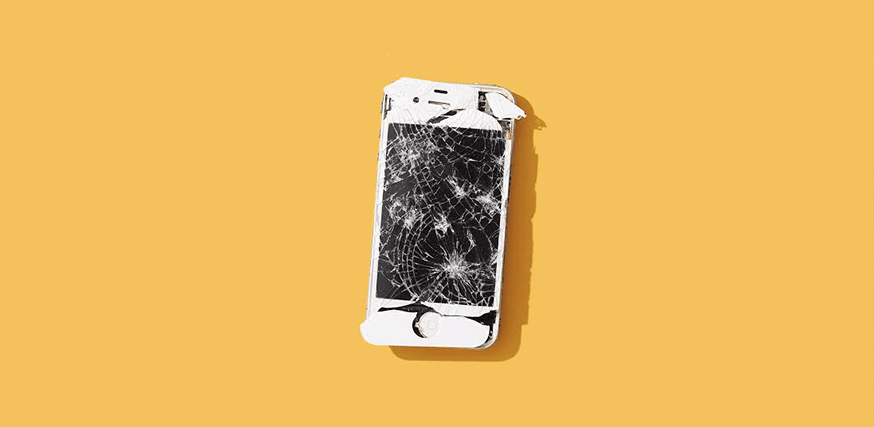
E infatti dopo poche righe arriva la fucilata: la crescita più lenta della produttività misurata dal 1970 in poi, scrive Gordon, è una prova del fatto che la terza rivoluzione industriale associata a computer e digitalizzazione è stata meno importante della seconda, quella di elettricità e motore a scoppio. Gordon cita più volte una famosa frase del 1987 dell’economista e premio Nobel Peter Solow: “L’era dei computer si vede ovunque, meno che nelle statistiche sulla produttività”. Solow lo diceva parecchie versioni di Windows fa, ma Gordon non pensa che la frase sia invecchiata. Anzi.
I suoi capitoli finali mostrano una certa sufficienza nei confronti delle tecnologie digitali, descritte come buoni progressi per l’intrattenimento, il contatto con persone lontane, l’apertura alla concorrenza di settori economici un tempo bloccati. Cose preziose, ma non paragonabili al salto epocale della seconda rivoluzione industriale. Per carità, qualche beneficio per la produttività c’è stato: leggere mail e ricevere telefonate sempre e ovunque, vendere i propri prodotti in tutto il mondo da casa con un sito di e-commerce, sostituire le riunioni con le videoconferenze, recuperare informazioni alla velocità della luce… queste cose valgono. E infatti, tra il 1994 e il 2004 la produttività è tornata brevemente a salire, per poi spegnersi di nuovo. Nel giro di dieci anni, secondo Gordon, il digitale aveva dato all’economia tutto il contributo che poteva dare: l’onda provocata da elettricità e motore a scoppio è durata almeno cinquant’anni, quella dei computer si è esaurita in dieci, e in un fuoco di paglia.
E non è solo in termini di PIL che computer e smartphone perdono il confronto con lampadine, giradischi e cilindri. Il mondo di oggi, si chiede a un certo punto Gordon, sembra così sconvolgente a chi è nato prima del 1950, quanto quello del 1950 sembrava a chi era venuto al mondo ottant’anni prima? La sua risposta è “no”, e almeno su questo è probabile che abbia ragione. Né Gordon vede motivi per cui la tendenza debba invertirsi: a meno di qualcosa di davvero nuovo che al momento non si vede all’orizzonte, dobbiamo prepararci a decenni di poca crescita, e lenta. Accettare il fatto che i libri di storia racconteranno il tanto bistrattato XX secolo come un’irripetibile età dell’oro. E che su quei libri Sears and Roebuck – un catalogo postale corrispondente più o meno al nostro Postal Market, creato nel 1893 e che nel 1900 processava già 100.000 ordini al giorno – sarà ricordato come un’innovazione ben più dirompente di Amazon.
Fare previsioni è difficile, soprattutto sul futuro, come notava Niels Bohr. Gordon potrebbe essere clamorosamente confermato, o altrettanto clamorosamente smentito: se non da noi, dai nostri figli. I suoi colleghi economisti ammirano la portata del libro, ma esitano a schierarsi. Alfonso Gambardella dell’Università Bocconi di Milano ammette di avere amato più la prima parte – la descrizione di quel salto tra la vita e il lavoro del 1870 e quella del 1920 – che non l’ultima, che si avventura nella futurologia ed è “un po’ frettolosa, una presa di posizione più che un’analisi basata sui dati”. Di certo, conferma, nessuno può contestare il calo della produttività negli ultimi decenni. “E in Europa è anche peggio”, spiega,
non c’è stata nemmeno quella breve risalita tra il 1994 e il 2004 che Gordon attribuisce al primo impatto della digitalizzazione. Ed è vero che nel secolo precedente le innovazioni avevano un impatto più ampio, non solo sui settori industriali, ma anche sui beni strumentali e sugli investimenti. L’elettricità o l’automobile non trasformarono un solo settore, ma tutti quanti. Oggi abbiamo innovazioni molto spinte su singoli settori e sui beni di consumo, ma non portano lo stesso miglioramento su salute ed educazione, che sono i veri motori della crescita.
Gordon non è comunque l’unico a spargere pessimismo a piene mani sulle tecnologie digitali. Certo, è normale e fisiologico che si sia affievolito l’entusiasmo evangelico di quando i “nuovi media” (come qualcuno, un po’ comicamente, continua ancora a chiamare tutto ciò che è digitale) erano davvero nuovi. Chi come me aveva vent’anni negli anni Novanta ricorda bene Nicholas Negroponte, il suo Being Digital con quel capitolo finale intitolato, emblematicamente, “The Age of Optimism”. Negroponte scriveva cose come: “la tecnologia digitale può essere una forza della natura, che trascinerà le persone verso una maggiore armonia mondiale” grazie al suo potere “decentralizzante, globalizzante, armonizzante, potenziante”.
Qualche pessimista invero c’era, a contrapporsi all’entusiasmo à la Negroponte. E di un pessimismo spesso altrettanto eccessivo, tendente al catastrofismo. Come il critico e saggista Neil Postman, che nell’ultimo decennio della sua vita assisteva atterrito all’alba di Internet e rispondeva a Negroponte con:
L’informazione sta diventando spazzatura, incapace non solo di rispondere alle domande umane fondamentali, ma anche solo di aiutare a risolvere i problemi quotidiani più scontati. La sottomissione di ogni forma di vita culturale alla sovranità della tecnica e della tecnologia distruggerà la fonte vitale della nostra umanità, portando a una cultura senza fondamenta morali.
Niente di nuovo: la classica dialettica tra apocalittici e integrati descritta da Umberto Eco a proposito della cultura popolare di massa, che si ripropone più o meno tale e quale all’apparire di ogni nuova tecnologia. Negli ultimi anni, però, i tecnopessimisti hanno rialzato la testa, e spostato un po’ il bersaglio. A dare la stura è stato Nicholas Carr, saggista statunitense salito alla ribalta nel 2008 con una cover story su The Atlantic intitolata Is Google making us stupid?.
Carr notava allarmato come motori di ricerca e lettura su web stessero riducendo la sua capacità di pensiero critico, e la finezza della sua scrittura. “Una volta ero un sommozzatore nel mare delle parole. Ora sfreccio sulla superficie, come uno di quei tizi sulle moto d’acqua”. Tutta civetteria, il pezzo era meravigliosamente scritto, come lo sarebbero stati i libri di Carr che ne sono seguiti: Internet ci rende stupidi? (eh già, perché fermarsi a Google?) e La gabbia di vetro, sui rischi che corriamo nell’affidarci troppo all’automazione e alle macchine che pensano al posto nostro.
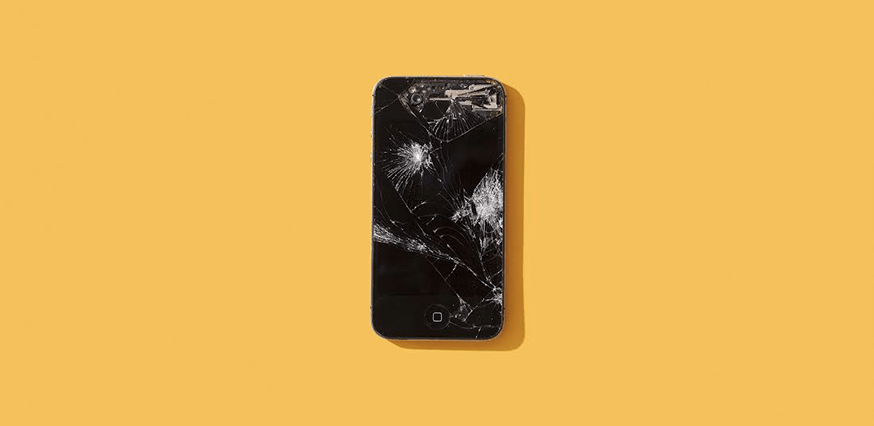
Se parliamo di Internet, il Guastafeste in Capo è però Evgeny Morozov. Giornalista, saggista, blogger e ricercatore bielorusso che nel 2011, mentre si discuteva del ruolo giocato dai social network nelle primavere arabe e mentre da noi si proponeva il premio Nobel per la pace a Internet, pubblicava L’ingenuità di Internet. Una secchiata di acqua gelata con cui Morozov ricorda che Internet e i social sono utili a dittatori, regimi autoritari e poteri oscuri quanto e più che ai rivoluzionari, e che i sommovimenti in nord Africa o nell’est Europa ci sarebbero stati comunque, con o senza Internet. Morozov diventa più esplicito nel suo libro successivo, Internet non salverà il mondo, e picchia sempre più duro con Contro Steve Jobs e I signori del silicio. Tanto che, ormai, ovunque si parli del “lato oscuro di Internet”, una citazione di Morozov è d’obbligo (volendo, anche in italiano).
Dalle nostre parti, si è unito alla schiera dei tecnopessimisti anche Mario Tozzi, geologo e divulgatore, che nel suo Tecnobarocco – tecnologie inutili e altri disastri, se la prende con molta tecnologia moderna colpevole di complicare le cose anziché renderle semplici, e di portare più danni che soluzioni. Tozzi mette sistematicamente a confronto le tecnologie attuali con quelle che le hanno precedute. Preferisce la scrittura a mano e la macchina da scrivere al word processor, perché il risultato è sempre una pagina stampata, ma il PC costa di più e consuma corrente; critica il gigantismo della tecnologia moderna, ben rappresentato dalla Costa Concordia arenata davanti al Giglio: mette a confronto bicicletta e automobile attribuendo la vittoria per KO alla prima – più efficiente ed ecologica. Tesse le lodi di legno e muratura come materiali di costruzione, che resistono ai terremoti meglio del cemento armato. Non ha alcuna simpatia per la plastica, inquinante e così economica da aver sostituito ovunque materiali più sostenibili.
Persino Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, gli autori del citatissimo Race Agaist the Machine che Gordon addita come esempio principe di tecno-ottimismo (a proposito: ecco il TED-duello tra Gordon e Brynjolfsson), sono ottimisti fino a un certo punto. Sì, dicono che robotica e intelligenza artificiale sono sul punto di scatenare una nuova impennata nella crescita della produttività, e che presto Gordon dovrà rimangiarsi quella sua idea che la rete fognaria sia più importante della banda larga. Ma dipingono anche uno scenario di disoccupazione di massa, parlano di un ceto medio colpito per una o due generazioni dalla concorrenza delle macchine, di pochi fortunati che raccoglieranno i frutti dell’automazione lasciando gli altri a leccarsi le ferite.

Per molti motivi, però, la critica di Gordon è la più dirompente. Più del catastrofismo di Postman, dello spaesamento cognitivo di Carr, degli scenari distopici di Morozov, della tecnonostalgia di Tozzi e della no-man’s (only robot’s) land di McAfee e Brynjolfsson. Tutti autori che descrivono a tinte più o meno fosche come il lato oscuro di automazione e digitale potrebbe sconvolgerci la vita. Gordon fa molto peggio. Dice che la vita non ce la sconvolgeranno abbastanza. Non è un antimoderno, non odia la tecnologia, anzi. Ne vorrebbe di più, e rimprovera tanto a evangelisti quanto a catastrofisti lo stesso errore. Credono di vivere un’era rivoluzionaria, ma scambiano per onda quella che in realtà è risacca.
Ma non sarà che Internet, computer e smartphone meritano più tempo? In fondo, pure l’elettricità ci ha messo qualche decennio ad avere un impatto economico misurabile. Gambardella ricorda gli studi dello storico dell’economia Paul David sull’elettrificazione. “Come funzionasse l’elettricità si sapeva dai tempi di Maxwell, ma l’impatto sull’economia c’è stato 40 anni dopo. Perché per sfruttare l’elettricità devi riorganizzare fabbriche, metterle in punti giusti, mettere persone competenti a progettare l’impianto elettrico, cose che richiedono tempo, formazione per almeno una generazione, investimenti”. Lo stesso potrebbe valere per il digitale, e forse Gordon dà per spacciata la terza rivoluzione industriale quando in realtà deve ancora iniziare. “Può darsi” secondo Gambardella,
a patto che ci siano le necessarie trasformazioni complementari: organizzative, culturali, intellettuali. Il problema è che, rispetto al secolo precedente, l’impatto della tecnologia è dirompente anche su aspetti etici e sociali. È vero che le nuove tecnologie riducono il bisogno di lavoro, valorizzano chi ha competenze molto alte ma penalizzano chi le ha basse. L’elettrificazione non aveva gli stessi problemi, portava vantaggi più o meno a tutti. E poi oggi abbiamo problemi sociali di complessità molto maggiore, basti pensare all’immigrazione. La verità è che il mondo di oggi è più complicato, socialmente, di quello del secolo che Gordon glorifica.