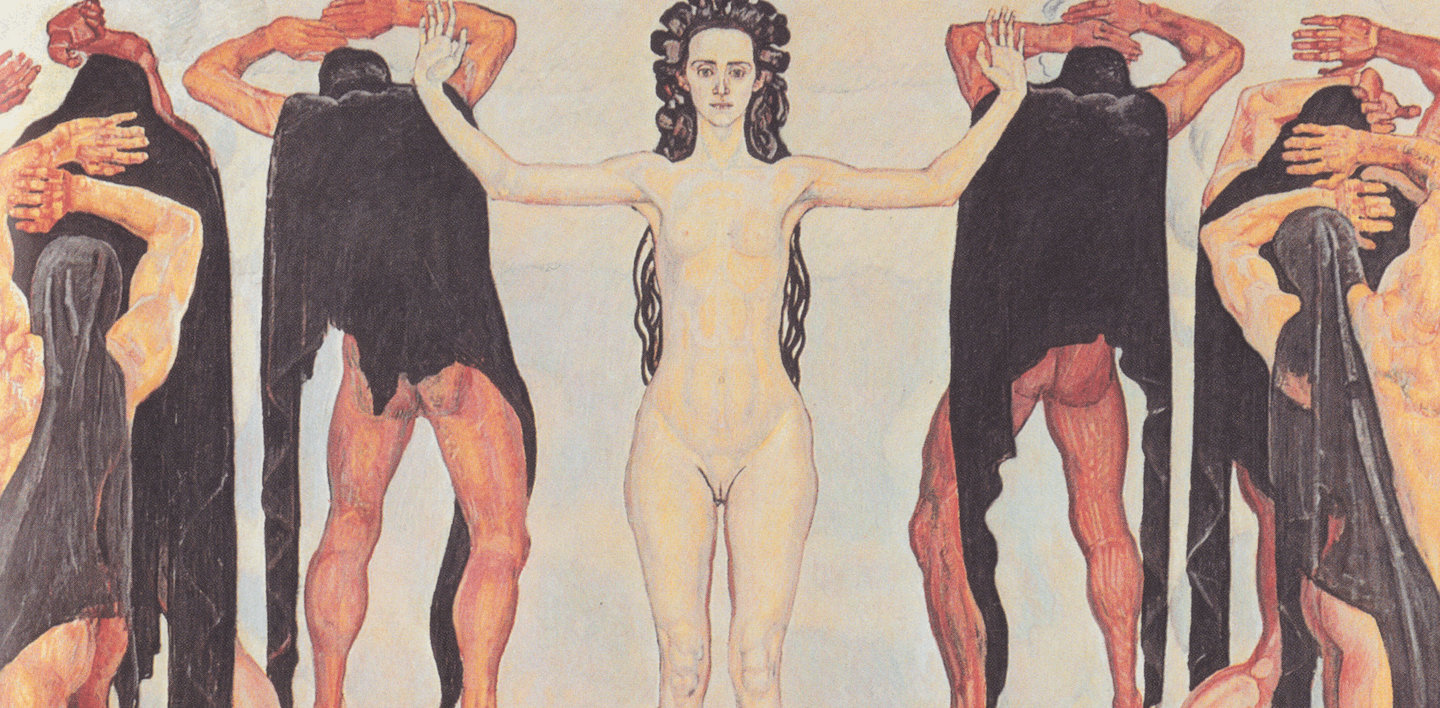
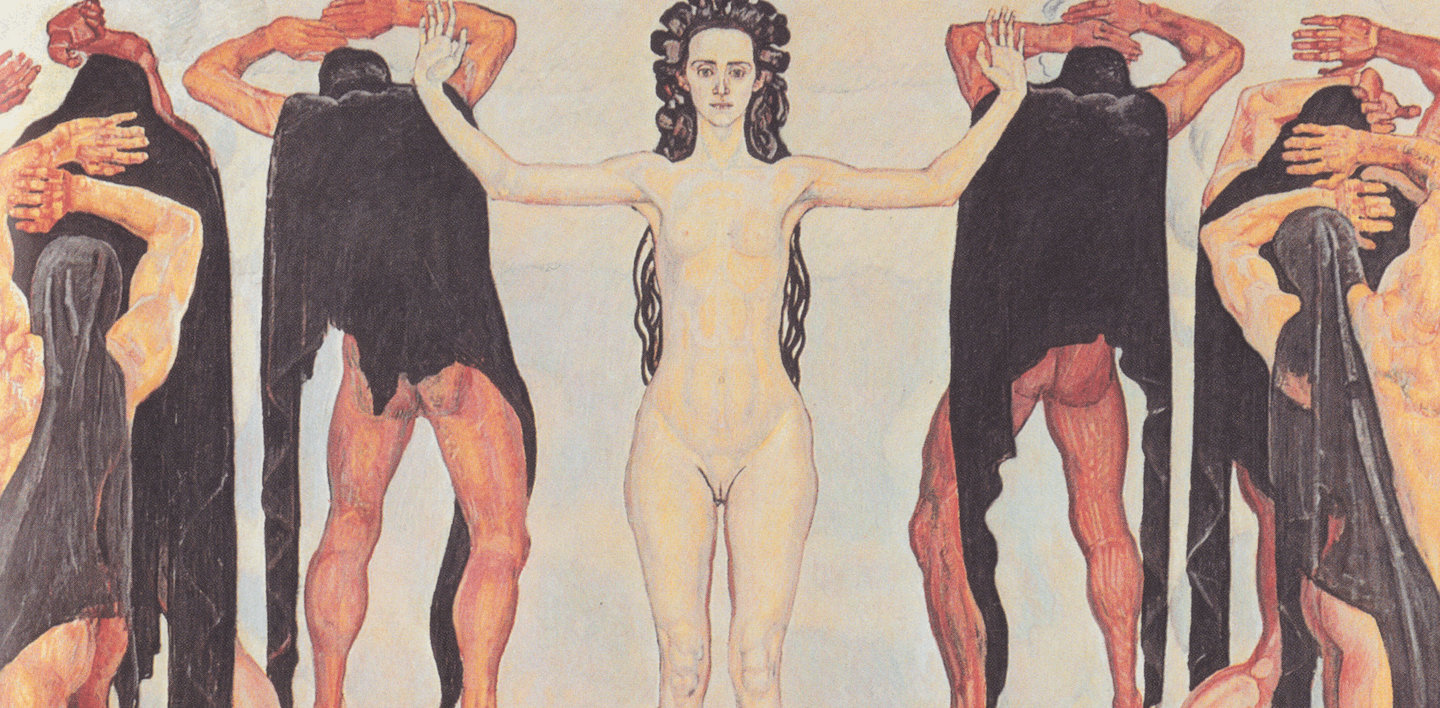
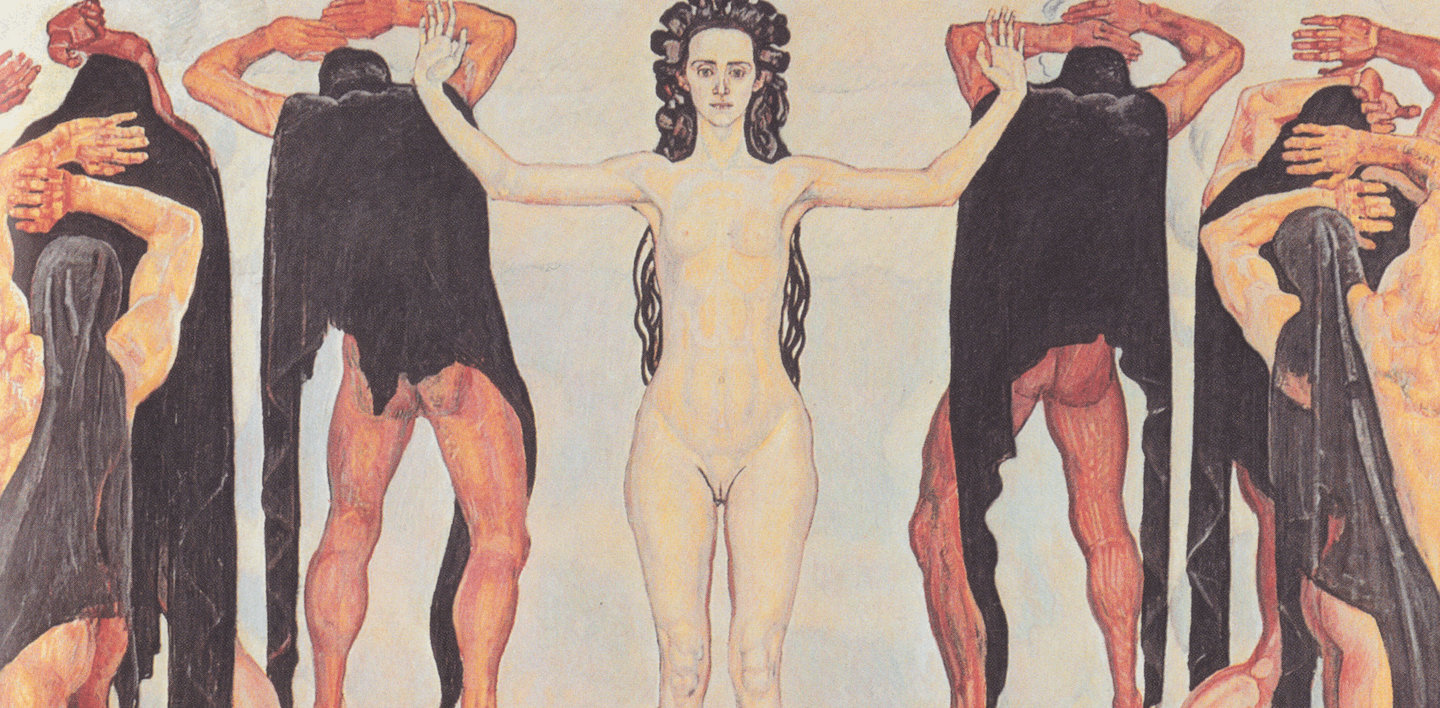
E ducazione sessuale; ‘circoli del sesso’ tra gay, insegnanti e (altre) minacce alla famiglia; ‘sconosciuti pericolosi’; Crimine!; Porno!; abusi satanici negli asili nido; abusi sessuali recuperati dalla memoria; predatori con l’AIDS; ‘super-predatori’; predatori su Internet; i sex offender considerati una categoria a parte di esseri umani; preti pedofili; stupri nei campus”. Sono questi alcuni dei temi dell’ultimo libro di JoAnn Wypijewski, What We Don’t Talk About: Sex, Authority and the Mess of Life (Verso, 2020; inedito in Italia), che raccoglie saggi scritti in un periodo che va dal 1992 al 2018. Il fil rouge che li collega è il cosiddetto sex panic (o anche, panico morale), che, nelle parole dell’autrice, si può definire come una reazione sociale “catalizzata dai media e caratterizzata dall’allarme per l’innocenza in pericolo (stereotipicamente, di donne bianche e bambini)”, nella quale “il predatore è una presenza sociale nascosta e pervasiva, una minaccia contro cui la popolazione deve mobilitarsi”.
Wypijewski parte dal concetto di poisoned solidarity – teorizzato dall’antropologo Roger Lancaster, autore di Sex Panic and the Punitive State – che indica una forma di solidarietà sociale che si determina intorno ad un nemico comune, e attraverso questa lente descrive una serie di casi provenienti dai contesti più disparati: dai cosiddetti “untori” dell’HIV ai preti pedofili, passando per le accuse contro Woody Allen e la censura di alcune opere sessualmente esplicite di David Wojnarowicz, fino al più recente movimento #MeToo che nasce anche come esito di decenni di sex panic negli Stati Uniti. Al cuore dell’interesse di Wipijewski non sono i casi presi singolarmente, né la loro veridicità, quanto la loro narrazione e l’impatto che questa ha sulla nostra percezione. Per questo può parlare di fenomeni molto diversi tra loro. Talvolta si tratta di crimini efferati, come l’omicidio brutale di Matthew Shepard nel Wyoming, ucciso e torturato da due ragazzi a causa della sua omosessualità (sebbene in verità la narrazione che vede l’omofobia come movente del crimine non sia incorretta, ma quantomeno parziale); a volte di preoccupazioni sensate e comprovate, ma strumentalmente amplificate dai media, come lo scandalo dei preti pedofili; altre ancora, direttamente di invenzioni, come quello degli abusi satanici negli asili nido negli anni Ottanta e Novanta.
Quest’ultimo caso può fungere da ponte: i saggi di Wipijewski sono tutti ambientati negli Stati Uniti, ma non mancano esempi di sex panic all’italiana, basti pensare a I Diavoli della Bassa Modenese, la cui storia è raccontata nei dettagli in Veleno, un podcast de La Repubblica: tra il 1997 e il 1998, una setta avrebbe organizzato riti satanici nei quali sarebbero stati molestati e assassinati bambini. A partire dalla denuncia di un bambino, un’indagine determinò la separazione di sedici figli dai genitori; anni dopo, la verità processuale stabilì che i fatti non si verificarono, e che le tecniche di interrogatorio avessero in realtà facilitato la formazione di falsi ricordi nei bambini. O ancora, si pensi allo spauracchio degli “untori” dell’HIV/AIDS. Al di là di fatti realmente accaduti – come quello di Valentino Talluto, condannato a 24 anni di carcere per aver contagiato con l’HIV 30 donne – non è raro che i media abbiano enfatizzato la percezione dell’esistenza di un fenomeno isolato, se consideriamo i servizi de Le Iene sull’“allarme untori”, o articoli a riguardo della stampa mainstream.
In tutti questi casi, “il sesso si configura come un pericolo sovrannaturale, le emozioni inondano la ragione, i mostri abbondano, e la protezione richiede qualsiasi sacrificio”. Ciò che muove Wypijewski, piuttosto, oltre a una sua personale compassione radicale che emerge nelle pagine, è il desiderio di andare oltre narrazioni semplicistiche e le reazioni di pancia che accompagnano gli scandali mediatici, preferendo domande complesse a risposte banali, che ci permettano di cogliere the mess of life. Le ex partner dell’“untore” con l’HIV, Nushawn Williams – considerato dalle autorità una minaccia per la salute pubblica (“public health threat, if you’ve had sex with this man, come down immediately for a test!”, si leggeva sui quotidiani) – dipinte come infantili e immature dai media, cosa pensavano effettivamente di lui, e che peso hanno, piuttosto, l’assenza di programmi di educazione sessuale, la scarsità di risorse di una piccola città, l’eccitazione causata dal rischio (e il modo in cui ci fa abbassare la guardia rispetto al rischio)? Nel caso di Matthew Shepard, cosa ha portato due ragazzi ad assassinare un altro? Che ruolo giocano le aspettative rispetto alla maschilità eterosessuale o l’abuso di droghe? Si potrebbe tracciare un parallelismo con il caso Varani, il giovane di Roma assassinato nel 2016. Come fa notare Nicola Lagioia ne La Città dei Vivi (Einaudi, 2020), saggio in cui racconta l’omicidio nei dettagli, i media e tutto lo spettro politico cercarono di strumentalizzare il caso: da destra si condannavano i presunti eccessi di festini a base di droghe, prostituzione e omosessualità (uno dei due uccisori era gay); da sinistra venne letto come un conflitto di classe, l’assassinio di un giovane della periferia romana da parte di due ragazzi ricchi e viziati della Roma bene; ad accomunare le due parti, il desiderio di punire e condannare i “mostri”. E se, come si chiedono sia Lagioia che Wypijewski, il “mostro” fosse semplicemente uno di noi, piuttosto che una specie aliena o una categoria a parte di essere umano?
Il sesso si configura come un pericolo sovrannaturale, le emozioni inondano la ragione, i mostri abbondano, e la protezione richiede qualsiasi sacrificio.
Se in questi casi l’esagerazione mediatica può sembrare facilmente criticabile, più difficile è approcciarsi a un tema che ha costituito un innegabile passo avanti nella trattazione ed elaborazione collettiva degli abusi, come il movimento #MeToo. Eppure leggere il modo in cui si è propagato questo discorso in continuità con la trattazione di altri scandali permette di comprendere alcuni limiti e criticità. Nella sua critica a #MeToo, Wypijewski traccia una differenza tra il “Me Too” originale, un movimento fondato nel 2006 dell’attivista nera Tarana Burke, con lo scopo di sensibilizzare e promuovere autocoscienza intorno alla violenza sessuale e agli abusi sistemici di cui sono vittime in modo sproporzionato donne e ragazze di colore, e #MeToo, un hashtag co-optato dalle celebrità (per lo più bianche) di Hollywood: da un lato, una pratica politica e comunitaria; dall’altro, una serie di tweet e post sui social con l’obiettivo di ostracizzare il mostro di turno, dal quale si chiede protezione, spesso da parte del potere repressivo e punitivo dello stato, “…fino al prossimo panico”. Vale la pena precisare che l’autrice si tiene alla larga dalle provocazioni fini a se stesse e dallo spirito di contraddizione tipico di un certo pensiero reazionario che ha caratterizzato le prime critiche a #MeToo (“non sono state le giovani attiviste a diffondere questo clima di paura e punizione” scrive infatti), prediligendo, al contrario, un approccio sistemico alle questioni che esamina (“vi è una concezione sotto-analizzata di patriarcato” perché “non c’è niente di più patriarcale del potere dello stato”). Wipijewski non intende correggere gli “eccessi” del #MeToo, ma piuttosto andare a criticare in modo ancora più radicale il sostrato patriarcale che lo anima nelle sue forme superficiali.
In questo, un approccio razionale e garantista è utile. Il sex panic (e, di conseguenza, l’ondata di accuse che hanno caratterizzato #MeToo, incluse quelle anonime raccolte in liste di nomi di presunti abuser, come la Shitty Media Men, o Dis Son Nom, in Quebec, Canada) inverte l’ordine che gestisce la legge, in cui, almeno formalmente, vige la presunzione di innocenza. Nel panico, le storie sono tutte vere, e gli accusati sono colpevoli di default. La legge, essendo stata dichiarata uno strumento difettoso per raggiungere la giustizia – come è, di fatti – viene sostituita dal “far nomi e umiliare”. Mascherate da giustizia, le accuse diventano lezioni morali di trionfo del Bene sul Male; pertanto, risulta difficile metterle in discussione. La loro proliferazione diventa prova della loro veridicità. Le vittime sono incoraggiate a “parlare della propria verità”. A tutti gli altri viene ordinato di credervi.
Ecco allora che Woody Allen viene considerato da molti un pedofilo, sulla base delle accuse da parte dell’ex moglie, Mia Farrow, di aver abusato sessualmente della figlia Dylan, di allora 7 anni, nonostante numerose evidenze (tra cui perizie pediatriche e psicologiche che non trovarono traccia di abusi sessuali) suggeriscano il contrario. È per questo che, secondo Wypijewski, Allen merita il beneficio del dubbio, sottolineando l’importanza di andare oltre il desiderio di punizione, e di soffermarsi sulle complessità di una storia che ci porta a confrontarci con “memorie malleabili, amore e crudeltà, dolore che si fa spettacolo”, aggiungendo che non sappiamo la verità, e che “non c’è niente di radicale o femminista nel pretendere il contrario”. O ancora, due Professori di Legge ad Harvard, Ronald S. Sullivan Jr. e Stephanie Robinson, vengono ostracizzati da studenti e membri della facoltà perché coinvolti nella difesa di Harvey Weinstein, azione considerata “traumatizzante” dagli studenti stessi.
A causa del panico, le definizioni si confondono, comportamenti molto diversi tra loro vengono messi sotto lo stesso ombrello, accorpati in un modo che ci impedisce non solo di valutarli e comprenderli, ma anche di prevenirli. In un contesto simile, qualche anno fa, poco dopo l’inizio del movimento #MeToo (in Italia #quellavoltache), e l’ondata di denunce (sui social e fuori) che ne conseguì, la scrittrice femminista Loredana Lipperini evidenziò sul suo blog vari tipi di abuso sessuale: molestia, ricatto sessuale in ambito professionale, aggressione sessuale, stupro – situazioni che di fatto non lasciano spazio al dubbio, ma aggiunse che “esistono anche infinite sfumature che non rientrano in nessuno dei quattro casi”. Di fatti, Wypijewski ci ricorda che tante storie che riguardano la sessualità e il sesso sono ambigue, fatte di incomprensioni e contraddizioni; storie caratterizzate da “forse”, “avrei dovuto”, “non avrei dovuto”, negoziazioni continue tra “sì” e “no”, che se filtrate sotto la lente di #MeToo potrebbero essere lette come “abusanti”: pentimenti, turbamenti emotivi, insistenze, sesso da ubriachi, giochi di potere.
Tante storie che riguardano la sessualità e il sesso sono ambigue, fatte di incomprensioni e contraddizioni.
Quando, allora, un movimento politico e un insieme di rivendicazioni, come quella di volersi liberare della violenza sessuale, si trasformano in sex panic? È quello che si chiese, durante i primi mesi dell’hashtag, Masha Gessen, secondo cui sfumare i confini tra stupro, coercizione non violenta, sesso pessimo o da ubriachi, ha l’effetto collaterale di “criminalizzare il pessimo sesso, e rendere banale lo stupro”. “Ho scritto “Me Too” perché sono stata stuprata da un uomo (un estraneo), forzata a far sesso da un uomo (un amico), tenuta in ostaggio dalle tendenze compulsive di un uomo (quelle del mio capo) a parlare di sesso, e a scattarmi – e a mostrare – foto sessualmente esplicite. Sono anche una persona queer, e vado nel panico quando sento puzza di sex panic”. Infatti, sono proprio diverse persone queer ad essere sospettose di una certa logica paranoide, che in passato ha fomentato vari casi di sex panic, e perché consapevoli di che effetto abbia venire accusati di comportamenti o desideri sessuali “inappropriati”, “spesso semplicemente in virtù della propria stessa esistenza”, come fa notare Maggie Nelson nel suo ultimo libro, Sulla libertà – un canto d’amore e di rinuncia (Il Saggiatore, 2021).
Sarah Schulman, scrittrice, attivista queer e storica dell’AIDS, che nel saggio Conflict is not Abuse: Overstating Harm, Community Reponsability and the Duty of Repair (Il conflitto non è abuso: sopravvalutazione dell’offesa, responsabilità comunitarie e il dovere della riparazione, Arsenal Pulp Press, 2016, inedito in Italia) osserva che, mentre per alcune persone far sesso con il proprio partner in momenti in cui si sentono ambivalenti a riguardo, viene percepito come coercizione, o perfino abuso, per altre fa semplicemente parte della negoziazione all’interno della relazione. Una cosa simile accade nei rapporti occasionali: per alcuni gli incontri spiacevoli possono essere devastanti, per altri sono parte della vita. In questo senso, si chiede Schulman, perché non riconoscere il fatto che, nella sfera privata, può essere difficile distinguere oggettivamente ciò che è un crimine da ciò che non lo è? Perché non promuovere anche in questo contesto l’autodeterminazione delle persone, fornendo loro un linguaggio per poter discutere e distinguere tra vari tipi di esperienze, e allo stesso tempo uno spazio per poterne parlare, senza che venga avallato un discorso della vittima che punta più all’esclusione e alla punizione (sociale e istituzionale), piuttosto che al dialogo e alla riparazione?
Cosa ne è, invece, della rivoluzione sessuale? Il capitalismo ne ha assorbito le istanze liberatorie, spogliando il progetto iniziale della sua radicalità; dietro l’attuale facciata di liberazione si nasconde un desiderio più profondo di punizione e ostracismo. Ciò che ne rimane è un simulacro di libertà: da un lato, rappresentanti estreme di quella sessualità femminile commercializzabile che protestano contro l’oggettificazione; dall’altro, legioni di uomini ordinari che aprono e-mail che li esortano a “diventare più grossi, durare di più, diventare la bestia che lei ha sempre desiderato!”. Nel mezzo, c’è solo ulteriore dissonanza, se consideriamo il sesso in TV, rappresentato come un combattimento tra gladiatori, senza preliminari, con personaggi femminili potenti che prendono l’iniziativa, creati da una produttrice donna potente
spiega Wypijewski.
Negli anni Ottanta, idee come quelle che le donne fossero vittime di una violenza maschile ubiqua e pervasiva, che il femminismo si dovesse fondare sul credere alle donne vittime di stupro sempre e comunque, appartenevano a una frangia radicale e minoritaria del movimento, le cui massime esponenti erano Andrea Dworkin e Catharine MacKinnon, madrine della crociata anti-porno di quegli anni; oggi invece sono concetti ampiamente condivisi dal femminismo mainstream. All sex is rape è una parodia delle loro argomentazioni, ma come ha osservato la giornalista Cathy Young, Dworkin in Intercourse fa effettivamente equivalere la penetrazione vaginale alla sottomissione femminile, mentre, secondo una rilettura di Joseph J. Fischel, è proprio all’eredità di MacKinnon che si deve l’idea che il sesso debba essere costantemente scrutinato, considerato potenzialmente stupro fino a prova contraria, fonte primaria di oppressione e iniquità in una società patriarcale.
Cosa ne è, invece, della rivoluzione sessuale?
Non è un caso allora se, in una società in cui il sesso è ovunque – organizzato secondo logiche corporate – e al tempo stesso tacitamente sanzionato o iper-scrutinato, la direzione che il discorso intorno a questi temi sembra aver preso è quella di non poter nominare le contraddizioni e i rischi della sessualità, preferendo piuttosto un modello che Emma Gainsforth ha definito “sostanzialmente contrattuale”: no means no, yes means yes!; teach boys not to rape!; lo stupro non ha a che fare con il sesso, ma con il potere! A quest’ultimo slogan, Wypijewski risponderebbe che, mentre un capo che impone del sesso ha a che fare con il potere, e lo stupro ha a che fare con il potere, è il pessimo sesso ad essere l’elefante nella stanza, con le “ansie irrisolte e le lacune rispetto a chi siamo e come ci rapportiamo agli altri” che comporta. Soprattutto, gli esiti negativi del pessimo sesso – che ci appare come una realtà inevitabile, piuttosto che una questione politica – ricadono spesso sulle donne, come argomenta Katherine Angel in Tomorrow Sex will be Good Again: Women and Desire in the Age of Consent (Verso 2021, inedito in Italia). L’insistenza sul consenso affermativo è spesso la reazione al panico morale: un approccio pedagogico e normativo viene opposto a un’idea statica e altrettanto normativa del Male. Ma questa insistenza sul consenso affermativo non può essere una risposta, perché dà per scontato che le donne siano sicure di sé, sessualmente emancipate, capaci di comunicare in modo assertivo i propri desideri e limiti, ignorando una serie di problemi e ambiguità del sesso, o altri problemi strutturali. Queste contraddizioni non possono essere risolte dal consenso affermativo, che è the bare minimum: a volte, scrive Angel, non sappiamo ciò che vogliamo, e il sesso stesso è un processo complesso di scoperta.
Inoltre, gli slogan accattivanti finiscono per spiegare solo parte dei fenomeni che intendono affrontare. Nel manuale The Psychology of Human Sexuality, Justin Lehmiller, Psicologo Sociale e Sex Researcher, chiarifica che numerose ricerche dimostrano che alla base di molte violenze sessuali ci sono motivazioni legate alla gratificazione sessuale. Uno studio in particolare ha individuato cinque motivazioni principali della violenza sessuale da parte degli uomini sulle donne, ovvero: rabbia e risentimento, ostilità nei confronti delle donne, percepire le donne esclusivamente come oggetti sessuali, avere una libido incontrollabile, sentimenti di entitlement. Chiedersi perché certe cose (anche quelle considerate oscure e indicibili) accadono porta con sé il rischio di ricevere accuse di victim blaming, o di “empatizzare con il mostro”, anche perché molte persone hanno già la risposta pronta: è colpa del patriarcato, della “cultura dello stupro”, del potere, del privilegio maschile. Tuttavia, non semplificare eccessivamente le cause delle aggressioni sessuali, interrogarsi anche sulle ragioni multifattoriali (psicologiche, biologiche, socioculturali) che le determinano, ragionare in termini di recupero e riparazione, è funzionale alla prevenzione del fenomeno, soprattutto se consideriamo che, come spiega Lehmiller, diversi sex offender tendono a recidivare quando si tratta di commettere crimini sessuali.
Sulla stessa riga, sempre in Conflict is not Abuse, Schulman ricorda la conversazione con una collega esperta di prevenzione di violenze sessuali, che le racconta di aver notato che, parlando con un vasto numero di studenti universitari, solo una piccola parte di questi era costituita da “aggressori patologici”, ma di aver scoperto, al tempo stesso, un gran numero di studenti “confusi dai conflitti delle donne rispetto alla sessualità”, e dalle rappresentazioni contrastanti e ambigue del sesso e delle relazioni in televisione, nei film, online – influenze che orientano tanto i nostri comportamenti, quanto l’interpretazione di quelli altrui. Schulman precisa che lei e la sua collega, entrambe lesbiche, “sapevamo che le donne vivono conflitti profondi rispetto a comportamenti, aspettative, la propria immagine, e anche noi siamo spesso confuse e non capiamo noi stesse o le altre donne (…) Riconoscere le contraddizioni non implica ‘incolpare la vittima’, ma è necessario per trovare soluzioni effettive”.
In tanti discorsi contemporanei su stupro e violenza sessuale, anche a coloro che vengono etichettate come vittime o survivor viene riservato un certo livello di deumanizzazione, che, secondo Wypijewski, si verifica nel momento in cui viene negata loro complessità: le loro esperienze vengono amputate, incasellate e inquadrate nei termini della violenza che avrebbero subito. “Il sesso è il primo luogo in cui mentiamo a noi stessi”, scrisse l’attivista radicale Amber Hollibaugh. Ribrezzo, angoscia, imbarazzo, rischio, senso di colpa, vergogna, ambiguità del desiderio, diniego, sono tutti elementi che coesistono con piacere e godimento; l’assenza di una conversazione adeguata che prenda in considerazione le complessità che caratterizzano la sessualità, “implica che la realtà della vulnerabilità sessuale non potrà mai essere compresa a pieno”, dice Wypijewski.
Il sesso è il primo luogo in cui mentiamo a noi stessi.
Può essere rilevante in questo contesto quella che è forse la citazione più famosa del filosofo queer Leo Bersani: “C’è un grande segreto che riguarda il sesso: a molte persone non piace farlo”. A differenza di ciò che si potrebbe intuire, Bersani non si riferisce alla “repressione” che molte persone esperiscono, ma a una più generale e comune “avversione” al sesso, nello specifico quei sentimenti di ansia dovuti ad una componente intrinsecamente masochistica della sessualità, che si prende gioco di qualsiasi tentativo di “redenzione” o “prescrizione” da parte di coloro che aspirerebbero ad una sessualità “più autentica” o “più sana”. Allo stesso modo, Wypijewski ci mette in guardia dal rischio di “limitare le possibilità di avere conversazioni ragionate su cose reali che le persone fanno e sentono, sulle cause, gli effetti e i complessi scambi di potere di un’attività umana che non opererà mai secondo precetti da manuali o trattati di giurisprudenza”.