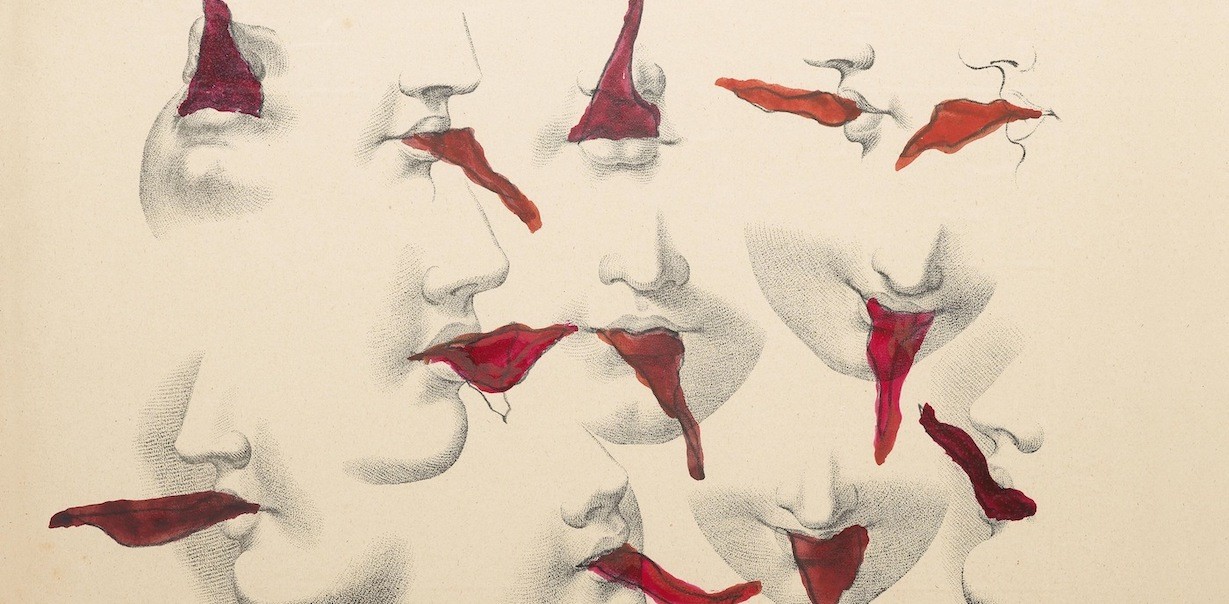
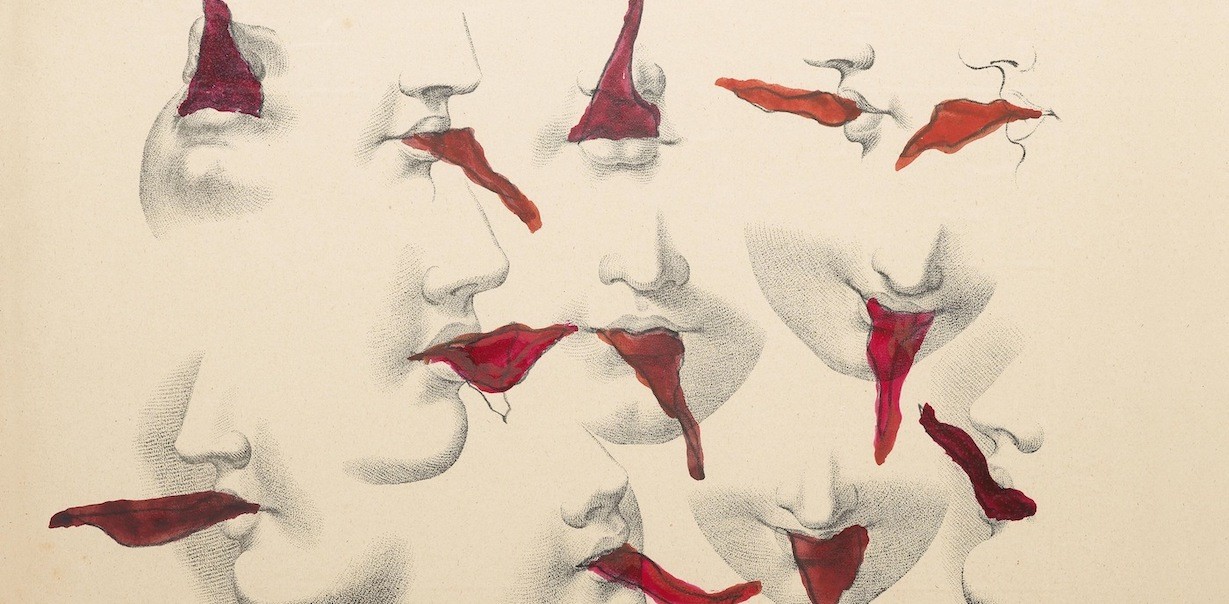
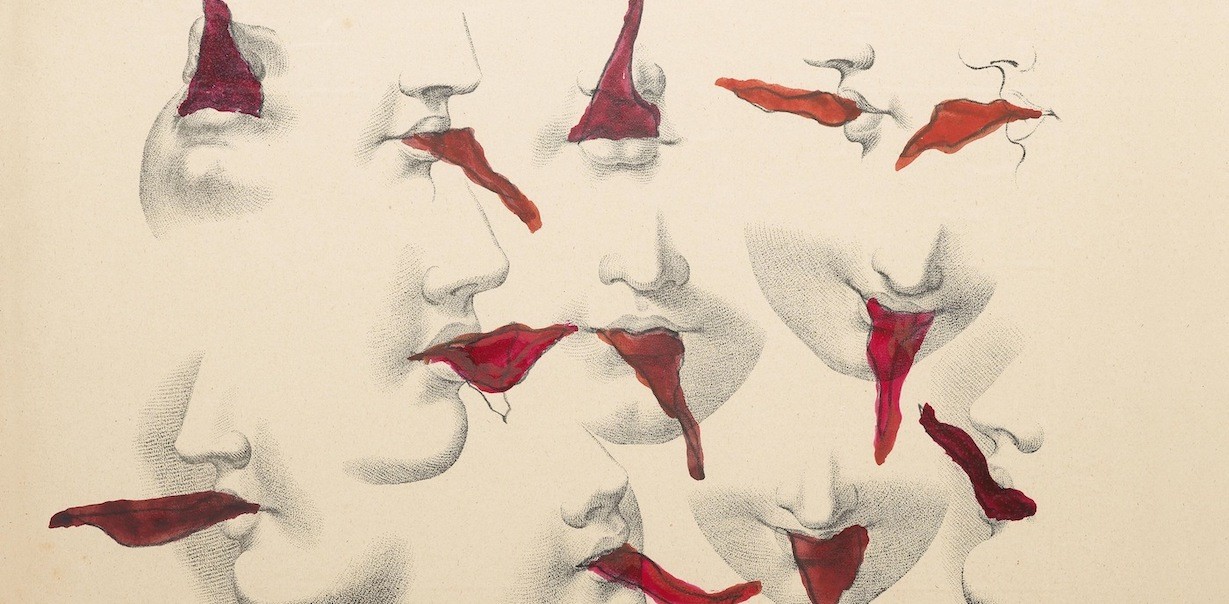
A ll’inizio degli anni 10, il performer James Deen ha realizzato un porno con una sua fan, battezzata Girl X. Di quel film, solo una piccola percentuale ha a che fare col sesso, spiega Katherine Angel nel primo capitolo di Tomorrow sex will be good again. Women and Desire in the Age of Consent, il resto è occupato dalla discussione tra l’attore e la ragazza sulla possibilità di fare sesso e di caricarlo online. Anche quando decide di procedere, la ragazza è nervosa, incerta rispetto alla forma dei suoi desideri: vuole fare sesso con Deen? Ha paura di quello che accadrà una volta che il video diventerà pubblico? Di lei sappiamo che deve aver poi dato il consenso alla diffusione del materiale, ma nulla più, niente di quella esperienza, se abbia accusato Deen di molestie come altre attrici, o cosa sia accaduto dopo. Katherine Angel inizia da qui l’analisi del presente della sessualità, da una storia di conflitto: Girl X incarna la contraddizione tra il desiderio e il timore di essere vista, tra la voglia di seguire i propri desideri e il sospetto che questi siano introiettati e non liberi, il dubbio che rivendicare la propria sessualità sia un modo per smarcarsi da una posizione di passività.
Tomorrow sex will be good again, il terzo libro della studiosa di storia della medicina e sessualità ha come sottotitolo “donne e desiderio nell’età del consenso”. Attraverso una struttura che procede per incrementi, comprensiva per quanto possibile, Angel indaga i temi del consenso, del desiderio, dell’eccitazione e della vulnerabilità, le pulsioni contrastanti che abitano, infestano e, infine, impediscono una vera discussione sul sesso. Nel libro Angel sceglie la via del conflitto, osserva le dinamiche paradossali che mostrano da un lato la tendenza a normare ogni aspetto della nostra vita e dall’altro la violenza che aleggia intorno al sesso, come frutto della stessa inadeguatezza di confronto, di vocabolario, per tentare di spingere la conversazione più avanti rispetto all’inefficacia della proliferazione di categorie e di strumenti di contrattazione.
Tomorrow sex will be good again, che come ricorda Angel è una citazione di Foucault, arriva dopo Unmastered, una riflessione in frammenti sul desiderio, e Bella di papà, un saggio sulla figura paterna attraverso la psicoanalisi e prodotti culturali, tradotto di recente da Blackie edizioni (che nel 2022 pubblicherà anche questo). L’ho letto a pochi mesi di distanza dal libro di Elisa Cuter, Ripartire dal desiderio (minimum fax, 2020) e mi sembrano affrontare gli stessi nodi cruciali: l’urgenza di smontare il dialogo sul sesso e il desiderio, perché esca da una posizione di difesa e protezione e torni ad essere fertile; perché provi a complicare, piuttosto che risolvere e riportare a un piano di responsabilità solo individuale questioni che sono sociali, culturali e, dunque, collettive, politiche.
Faccio fatica a usare la prima persona in questa introduzione, perché ho sempre avuto poco interesse a rendere pubblico il mio privato – non è pudore, ma una questione di rilevanza – eppure il desiderio di condurre questa conversazione nasce dalla mia stessa insoddisfazione, dalla frustrazione di vedermi vendere l’amore e la relazione come azione positiva, a metà tra il self care e la cura dell’altro (come scrive Sofia Torre in questo articolo) che trasforma ogni incontro in una società partecipata, con tanto di rischio imprenditoriale, che, come nelle questioni economiche, implica successo o fallimento – una visione individualizzante, che dunque permea l’esperienza sessuale anche fuori da rapporti definiti. Le relazioni come fondi pensionistici, in cui ancorare l’imprevedibilità delle nostre vite: trovo deprimente il modo in cui ricorriamo al sentimentalismo per ogni questione che meriterebbe una conversazione collettiva. Di fronte alla sacrosanta vittoria del matrimonio omosessuale, mi chiedo perché non esistano altre forme di associazione e relazione che non prevedano strutture nucleari, per liberare l’altro da essere the one, l’unica persona che provvede a noi e a cui provvediamo.
Quando Katherine Angel dice che, se vogliamo migliorare il sesso per le donne, dobbiamo aprirci a una discussione che vada al di là del piano legislativo, contrattuale, mi sono chiesta se la questione non riguardasse anche e soprattutto gli uomini e la loro percezione di ciò che è piacere e godimento, perché implichi, incoraggi la vulnerabilità senza renderla una forma di debolezza, di nudità senza riparo, da cui sottrarsi rapidamente. I ruoli, le definizioni, le categorie che proliferano sono strumenti di difesa, che presto diventano a tenuta stagna, stanze separate. Offrono invulnerabilità, direbbe Angel, il cui pregio è muoversi nella direzione opposta. La dimensione eventualmente eterocentrica – da cui io stessa parto – è resa meno influente o divisiva se letta nella chiave di femminilizzazione di cui parla Cuter, che rende la responsabilità sempre individuale, pur in una condizione di passività. Angel analizza il linguaggio giuridico per liberarsene, mentre Cuter problematizza l’inclusività come sinonimo di azione politica: come il therapy-speak, l’uso e abuso di termini dedotti dalla psicologia e che feticizzano il trauma, questi vocabolari si mostrano adatti a categorizzare, a rendere ineluttabili le posizioni, nulle le evoluzioni, gli sconfinamenti.
La via del conflitto e l’intenzione irrisolutiva sono l’unica strada, mi sento di dire, per poter continuare la conversazione, perché esca dall’impasse in cui la spinge la tentazione nevrotica di mettere un punto lì dove di solito ci augureremmo la sorpresa dell’indefinitezza, della scoperta continua, l’abisso del desiderio. Il punto è che è qui dovrebbe iniziare la discussione, una volta che l’abbiamo rimessa nei ranghi, spinta fuori dai vicoli ciechi: i libri di Cuter e di Angel aiutano a ritrovare le coordinate, a uscire dal pantano retorico, ma sono un punto di partenza, non di arrivo. In uno dei saggi sul femminismo, scritto nel 1978, Vivian Gornick trascrive una tra le tante esperienze di autocoscienza collettiva, in cui una delle partecipanti alla fine dichiara “Siamo intrappolate in un pasticcio, come ci muoviamo sbagliamo. Va bene. È esattamente per questo che siamo qui, per spezzare il cerchio.” A quarant’anni da quel momento è ancora quello che mi auguro.
Elisa Cuter: Dire che le cose sono cambiate può sembrare banale – ogni epoca e ogni generazione deve avere avuto questa sensazione, eppure non si può negare che la necessità di un cambiamento in questi ultimi anni è molto forte: si criticano valori e stili di vita che avevano la pretesa di essere astorici, naturalizzati e (apparentemente) immutabili. È il compimento (anche se ancora ostacolato e certo non pacifico) di una serie di trasformazioni in atto da tempo: nel mio libro cerco di evidenziare come questo dipenda dalla presa di parola di soggettività che, per quanto sempre esistite, prima non avevano spazio nella sfera pubblica, anche perché escluse in vario modo da quella economica. Questa sfera pubblica oggi comprende (e a volte riguarda esclusivamente) quello che una volta era considerato il “privato” o, per dirla con il femminismo della seconda ondata, “il personale”: l’espressione della propria individualità e la sfera degli affetti e della sessualità. Il senso del mio titolo (ma, mi sembra, anche il lavoro di Katherine) è un invito a cercare di leggere dialetticamente questa mutazione storica per vedere se, pur analizzando criticamente la contemporaneità, sia possibile trovare il modo di immaginare un futuro a partire dallo scenario attuale. La mia risposta è che questo sia effettivamente possibile, e anzi promettente, se ci si concentra sul desiderio come esperienza che scardina e destabilizza quell’identità che il sistema capitalista impone invece di rafforzare.
Katherine Angel: Ho scelto la citazione di Foucault come titolo perché mi piace la sua ironia mesta. L’originale francese non include “di nuovo” e quindi la traduzione inglese fa mostra di credere all’esistenza di una condizione edenica, in cui il sesso era buono, prima di non esserlo più. Lì, Foucault ironizzava sul clima che c’era tra le figure della controcultura con cui era in dialogo – la loro fede in un orizzonte raggiungibile, in cui avremmo finalmente risolto i problemi del passato. In questo libro mi interessava avere una dinamica simile rispetto alla convinzione, ripetuta a intervalli regolari, di avere di fronte a noi un futuro roseo per il sesso, adesso che avevano capito quali erano gli strumenti di cui avevamo bisogno – in questo caso, consenso e ricerca. Mi piacerebbe pensare che il sesso sarà migliore, che i problemi della cultura sessuale verranno estirpati alla radice, ma a questo volevo aggiungere un’avvertenza: che l’entusiasmo e cieca fiducia che affidiamo al consenso perché risolva tutti i problemi legati al sesso potrebbero essere mal riposti. Spero che il mio libro porti a un risultato diverso, a un altro tipo di ottimismo, basato sul tentativo di comprendere perché quegli strumenti non sono sufficienti, al di là delle nostre buone intenzioni. In un certo senso, nel libro mi confronto con il mio pessimismo e il mio ottimismo, come forze che mi assediano quando ragiono sul sesso e la cultura.
EC: Quello è stato un momento particolare. Da un lato le donne sembravano aver conquistato molti più diritti che in fasi precedenti: mi riferisco, in Italia in particolare, a cambiamenti sociali fondamentali come l’aborto e il divorzio, e allo stesso tempo alla possibilità di avere ruoli di rilievo e di autorità come dimostra proprio Margaret Thatcher. Allo stesso tempo, però, e gli anni Novanta ne sono la dimostrazione lampante, per fare parte dello spazio pubblico, in una società sempre più spettacolarizzata (come spiegano bene i Tiqqun in Théorie de la Jeune-Fille), le donne diventarono sempre più “ragazze”: giovani, avvenenti, disponibili, ingenue ma maliziose eccetera. Come scrive Angela McRobbie era questo il ruolo richiestogli, e da qui seguì a ruota il femminismo mainstream o pop di cui abbiamo tanti esempi anche oggi: una rivendicazione totalmente apolitica di quegli aspetti ascritti al genere femminile da quello stesso binarismo di genere che il femminismo della seconda ondata aveva in parte iniziato a criticare. In un’ottica di parità, però, non si può negare che anche questo sia stato un processo di emancipazione: come agli uomini è stato concesso un ruolo di primo piano nella storia anche (e soprattutto) quando incarnavano alla perfezione i diktat della loro maschilità, non si vede perché anche le donne non dovessero essere incluse. Per me è molto difficile dire se questo sia stato una cooptazione del femminismo da parte del capitale, o se non dimostri un limite intrinseco, da un punto di vista strategico e quindi davvero politico, al femminismo stesso – per lo meno a quello essenzialista che critico nel mio libro.
KA: A un certo punto, quando stavo finendo il libro, mi sono resa conto che era con l’eredità degli anni Novanta che mi stavo confrontando. È stato un periodo particolarmente affascinante in cui varie forze si sono congiunte: l’ascesa del pensiero neoliberista, in cui veniva iper-valorizzata la responsabilità individuale e viene abbandonata l’idea di politiche collettive; l’emersione del post-femminismo, che riteneva che le battaglie femministe fossero state vinte; l’arrivo, soprattutto nel Regno Unito, di questa specifica figura femminile, sicura e aggressiva, che poteva competere con gli uomini, sia dal punto di vista economico che sessuale; la pervasività della visione del rischio come pericolo da gestire. Mi affascinava come il linguaggio con cui, negli anni Novanta, si è parlato di consenso esplicito – in tutte le conversazioni importanti e ben intenzionate sull’argomento – fosse collegato a quei fenomeni. L’enfasi di quelle conversazioni sul consenso su come la donna dovesse conoscere sé stessa e dovesse dichiarare i suoi desideri in modo assertivo è un esempio perfetto di come implicitamente abbiamo consegnato alle donne il peso e la responsabilità di gestire la violenza che avrebbero dovuto affrontare. Mi interessano profondamente tutti gli ambiti in cui ci si è affannati a tenere a debita distanza l’immagine della donna come figura fragile o vulnerabile, come sia chi utilizza la retorica del consenso sia che chi critica il consenso sembri impegnato a rifuggire e condannare quell’immagine. Dobbiamo avere donne forti, sicure di loro! Ma a che serve questo tipo di ostinazione? È davvero d’aiuto per le donne?
EC: Penso che ci sia un comprensibile timore nei confronti del sesso, proprio perché questa ondata di rivendicazioni e accuse ha messo in luce il suo potenziale violento. Tuttavia manca uno sguardo più ampio al sistema economico all’interno del quale questa violenza si è perpetrata, e mi sembra che ci sia anche una grande voglia di addossarsi le colpe reciprocamente tra generi, il che sembra paradossale in una fase storica che renderebbe possibile concentrarsi sulle similitudini piuttosto che sulle differenze tra loro, e la messa in discussione del binarismo. Il problema credo che risieda nel fatto che il sesso è proprio quel luogo in cui emerge il conflitto tra soggetto e oggetto (anche all’interno delle singole soggettività): penso che sia questo conflitto a spaventare, che ci sia paura dei rapporti e della molteplicità. Pensare a una lotta tra generi è un modo di creare una narrazione che non confligga con la centralità dell’identità individuale che impone il sistema.
KA: Credo si guardi con un po’ di sospetto al rapporto tra desiderio e consenso, legge, violenza sessuale. Questo è perché il desiderio è, strutturalmente, una forza destabilizzante, che si fa beffe di tutti noi; non rispetta necessariamente le regole, le leggi o anche le politiche (Amia Srinivasan ha scritto un saggio magnifico dal titolo “The Right to Sex” -“Il diritto al sesso”- su LRB e sullo stesso tema anche Jacqueline Rose, sempre su LRB). È preoccupante, però, separare desiderio e sessualità dalle conversazioni su violenza sessuale e coercizione, perché di fatto è il modo in cui intendiamo il desiderio e il sesso a determinare in profondità le condizioni che rendono possibili la violenza, la coercizione, il cattivo sesso. Chi ha il diritto di desiderare e perché? Cos’è legittimo? Queste sono domande cruciali per identificare lo squilibrio di potere che permette tutto il sesso deprimente che le donne spesso tollerano. E la mia sensazione è che una politica e un’etica sessuali degne di questo nome dovrebbero partire dalla complessità del desiderio – il fatto che non sappiamo sempre cosa vogliamo, che i nostri desideri cambiano e che rispetto a questi possiamo avere sentimenti contrastanti – invece che negarla e provare a creare leggi e regole che partono da una idealizzata e artificiale concezione di desiderio. Dobbiamo essere curiosi e realisti rispetto alla natura del desiderio sessuale, con tutte le sue idiosincrasie – e iniziare da qui a pensare a ciò che rende il sesso buono o cattivo.
EC: Esattamente: in un sistema in cui ci si sente impotenti sia come singoli che come collettività, è molto difficile aprirsi alla vulnerabilità che, come scrive Katherine, è poi il fondamento dell’esperienza sessuale. Costruirsi un’identità stabile, curarla sui social e nella vita pubblica, considerarsi delle monadi in controllo di ciò che ci riguarda più da vicino, è un modo per sopravvivere, un comprensibile coping-mechanism. Ma il prezzo che si paga è molto alto.
KA: Il sesso è un ambito in cui siamo tutti profondamente, intimamente vulnerabili. Non ci sono in gioco solo i piaceri del corpo, ma anche i nostri sentimenti, speranze, voglie e paure. Non c’è da stupirsi che ci sia la tentazione di essere rigidi di fronte al sesso – su cosa vogliamo, su cosa vogliono gli altri. E l’incertezza e la precarietà oggi pervasive nelle nostre vite – dal lavoro, al cambiamento climatico, ai social, alle istituzioni democratiche – forse ci spingono ancora di più a usare le nostre vite intime e sessuali come spazi in cui trovare stabilità. Comprendo questa tentazione, capisco il desiderio che le cose che facciamo ci mettano al sicuro, che impediscano al terreno di franare. In ultima analisi, però, i tentativi di irrigidire la nostra vita sessuale e intima non ci sono d’aiuto, ci rendono più spaventati e impediscono l’apertura, la curiosità e la vulnerabilità necessarie per il piacere e la gioia. E certo è molto difficile coltivare l’apertura e la curiosità, visto il rischio pervasivo di violenza sessuale, quindi sarebbe superficiale consigliare solo di rilassarsi un po’ e prendersi qualche rischio! Ma non sarebbe stupendo se invece tutti insieme creassimo un mondo in cui la vulnerabilità e l’apertura non ci rendessero così spaventati dal venire feriti?
EC:Le conseguenze della paura generalizzata (che, ripeto, è molto comprensibile e non va imputata ai singoli soggetti che la provano) fa sì che nasca questo bisogno di precettistica che ti dica come leggere certe situazioni, cosa pensare e come agire in modo molto prescrittivo. Oltre a quello che va perso, di cui parlavamo sopra, mi sembra che questo tipo di discorso aumenti il peso sul singolo, la pressione sul comportamento individuale: è un modo di articolare il discorso pubblico che parte già da una condizione di sfiducia, di diffidenza di base postulata tra i soggetti, non solo nel sesso ovviamente.
KA: Il consenso entusiasta, come idea, nasce come tentativo di alzare l’asticella – di risolvere il problema inerente al discorso sul consenso, che dà ancora per scontato che siano gli uomini a voler fare sesso e che le donne vogliano o meno acconsentire. Per me questo discorso è una falsa pista: mostra che il consenso, da un punto di vista legale, non rende giustizia, non dà indicazioni su quello che c’è di insoddisfacente nel cattivo sesso e di soddisfacente nel buon sesso – è un tentativo di risolvere quel problema unicamente all’interno del linguaggio giuridico. La mia soluzione è un’altra: chiederci se non stiamo per caso feticizzando un concetto legale e sperando che risolva tutta la questione del sesso. Non può! Il consenso è utile, ma è solamente una questione legale. Se siamo davvero interessati ad assicurarci che le donne possano godere del sesso, immaginare e incontrare relazioni sessuali soddisfacenti – e se siamo interessati a una cultura che non normalizza l’essere costrette al sesso dagli uomini – allora dobbiamo allargare il discorso al di là della legge e provare a sviluppare idee che concorrano alla prosperità sessuale. Idee come reciprocità, esplorazione, curiosità, gioco, godimento, piacere…
KA: Essere vulnerabili fidandosi che l’altra persona non ci faccia del male è molto difficile – spesso semplicemente le condizioni non sono date. Ed è per questo che ci sono così tanti fronti su cui lottare, dall’educazione sessuale alle politiche sociali che spezzino le ineguaglianze, dall’assistenza sanitaria a condizioni di lavoro eque. Proteggerci dai rischi a cui espone la vulnerabilità è del tutto comprensibile, è una risposta pragmatica del mondo come è. Quello che però voglio rifiutare o rigettare è l’idea che la vulnerabilità sia di per sé uno stato da evitare, voglio evitare le argomentazioni che partono dal presupposto che la vulnerabilità vada allontanata. La stigmatizzazione della vulnerabilità è al centro di due cose: il disprezzo nei confronti delle donne che sono state ferite e la violenza e il bullismo con cui sono intessute le concezioni tradizionali di mascolinità. Il modo in cui il potere – e il piacere – sono distribuiti è una questione profondamente politica ed è a livello politico che dovremmo creare le condizioni per un sesso migliore – per una maggiore apertura, vulnerabilità, fiducia e godimento.
EC: Il libro di Katherine mi ha fatto riflettere molto, soprattutto nella sua critica a un’autrice come Laura Kipnis, che conoscevo e apprezzavo. Ho capito che anche io, pur criticando la retorica dell’empowerment, a volte sembro esortare il lettore – e soprattutto la lettrice – a diventare più assertiva. Credo che questa confusione per me nasca dal fatto che cerco di tenere insieme un piano di rivendicazione politica e uno più individuale, personale, e forse la quadra potrebbe stare nel fatto che le rivendicazioni politiche non possono essere portate avanti dai singoli, ma da comunità e collettività che si formano su legami nei quali il desiderio, e quindi anche il suo portato di vulnerabilità e di apertura, sono centrali.
EC: Esatto. Per me il punto è la naturalizzazione binaria di cui è impregnato il discorso di genere. Mi rendo conto che è una conclusione a volte semplicistica e un po’ inattuale (perché ancora di là da venire) pensare di poter semplicemente liquidare così la questione, ma mi sembra che sia un dato riscontrabile nell’attualità il fatto che un paradigma più femminilizzato (laddove la femminilità altro non è che un costrutto culturale istituito all’interno di un sistema gerarchico) ha implicato una precarizzazione generalizzata, e, come dici giustamente tu, un ripiegamento sull’identità che causa un accresciuto senso di isolamento e insicurezza. Questa insicurezza per la propria identità è qualcosa di diverso dalla vulnerabilità o della passività che si esperisce nel desiderio, anzi credo sia proprio il contrario.
KA: L’idea che gli uomini e le donne abbiano sessualità diverse esiste da lungo tempo ed è tornata in auge negli ultimi decenni. Nel libro, quello che volevo suggerire è che parte del lavoro della sessuologia che sta tentando di migliorare le condizioni della vita sessuale femminile nei fatti non riesce a riflettere sulla produzione culturale della sessualità maschile. Le vite e le storie sessuali degli uomini e delle donne, i loro desideri, si esplicano in mondi molto diversi; i desideri sono accolti e accettati in modi diversi. Non meraviglia, credo, che quindi si manifestino in modo diverso. Provare a definire quello che è fondamentalmente diverso – dal punto di vista biologico o fisiologico – della sessualità maschile o femminile è una falsa pista, un vicolo cieco. Ogni desiderio sessuale vive e si evolve all’interno della cultura, non c’è sessualità che non ne sia profondamente modellata. Come possiamo quindi cambiare la cultura, in modo che porti la sessualità prosperi?
Vorrei usare il precedente libro di Katherine, Bella di papà da poco tradotto in Italia da Veronica Raimo e Alice Spano), per leggere Ripartire dal desiderio. Usando quella prospettiva, in Non è la Rai, che apre il libro di Elisa, Ambra è la giovane ragazza che incarna il talento e l’intelligenza del padre Boncompagni, che prospera ed è animata dalle parole dell’uomo. Ma il padre sfrutta la sua giovinezza, la mette in mostra come esempio (per le altre figlie) e come preda (per gli altri uomini), mentre dice di proteggerla (lui sa cos’è meglio per lei): è una cosina da guardare, che non ha una vita indipendente da chi l’ha creata. Sono curiosa di sapere se questa lettura si allinea con quella di Elisa. E a Katherine vorrei chiedere quanto quel libro si soffermi sulla dinamica contraddittoria tra odio e amore, violenza e tenerezza, e su come siamo tentati di scegliere sempre uno di due poli, per non stare dentro quella tensione paradossale: i tuoi libri mi sembrano una sorta di trilogia ideale.
EC: Ti confesso che leggendo Bella di papà non ho pensato al mio animale chimerico composto dal corpo di Ambra e la mente di Boncompagni, perché lì vedevo in atto una questione di desiderio mimetico (un uomo adulto che vorrebbe il corpo e l’appeal di un’adolescente, e un’adolescente che vorrebbe il potere di un uomo adulto). C’è un desiderio per il potere (mediatico) più che davvero un desiderio erotico per l’altro, mi pare. Il rapporto tra padri e figlie di cui parla Katherine è ancora più complicato, perché al di là del problema socioculturale ed economico del patriarcato c’è anche una dinamica di attrazione e seduzione reciproca, che rende ancora più difficile identificare gli abusi di potere… allo stesso tempo, mi ha fatto ripensare a un libro che ho amato molto, The Daughter’s Seduction di Jane Gallop, che drammatizza Lacan come padre/seduttore di Luce Irigaray: semplificando molto, proprio perché il padre, mostrando il suo desiderio per la figlia rinuncia all’autorità, alla cavalleria, alla protezione, permette la ribellione della “figlia” (Irigaray) e, in sostanza, consente paradossalmente lo sviluppo del pensiero femminista!
KA: Ho apprezzato molto l’analisi che Elisa fa di Non è la Rai – così evocativa e acuta. A volte ho pensato, in relazione al tropo della venerazione del corpo delle ragazze da parte degli uomini, al suo significato di non-io, come ‘cosa’ innocente, giovane, incorrotta, incontaminata, che diventa oggetto di investimento erotico in parte come risposta al disgusto di sé. Penso spesso a quello che Sianne Ngai ha scritto sul ‘cute’: ‘carino’ è quello di cui si vuole distruggere la vulnerabililtà. Le ragazze e le giovani donne hanno potere sugli uomini perché sono distruttibili, perché possono essere ferite, schiacciate. E quanto di questo desiderio è legato a distruggere le parti di sé che si odiano. E sì, i tre libri sono in dialogo tra loro, anche se non intenzionalmente. Tra loro e con la psicoanalisi, su cosa vogliamo conoscere di noi.
EC: Anche io ho questa sensazione, e non riesco a dare torto a Solanas. Il fatto è che non si può nemmeno dire che “si stava meglio quando si stava peggio”, o che dovremmo rimpiangere un passato più coercitivo. Non è questo il mio pensiero. Però dovremmo davvero non accontentarci di un mondo più “inclusivo” o più (maternamente) accogliente: la brutalità del mondo passato non è certo diminuita, il fatto che adesso si nasconda meglio dovrebbe renderci più vigili, e anche più arrabbiati infatti. La buona notizia è che adesso ci sarebbero potenzialmente più soggettività diverse sulla scena con cui creare alleanze trasversali, bisogna insistere molto su questo.
KA: Mi piace molto quello che dice Elisa sulle alleanze trasversali: penso che abbia ragione. Dobbiamo aspirare e puntare a relazioni di affinità, a solidarietà tra identità diverse. Il Manifesto Xenofemminista lo dice in modo molto bello: vuole “costruire una coalizione politica, una politica senza l’infezione di purezza”. Mi piace, ne abbiamo bisogno! Non omogeneità e identificazione, ma proliferazione e moltiplicità.