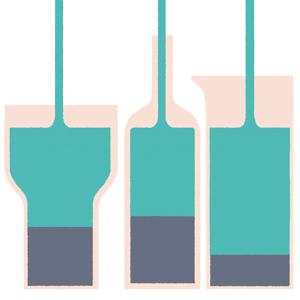E se la discussione sull’opportunità o meno di introdurre un reddito di cittadinanza si dimostrasse del tutto inutile? Gli scenari futuri lasciano pensare che assicurare a tutti uno stipendio minimo vita natural durante sarà piuttosto una scelta obbligata per far fronte all’automazione del mondo del lavoro, che nei prossimi anni porterà alla cancellazione di una percentuale di mestieri che va dal 35% (calcoli di Deloitte) al 47% (secondo uno studio di Oxford).
Le previsioni, anche sulle tempistiche, variano di analisi in analisi, ma è evidente che la sostituzione dell’uomo non è una questione di se, ma di quando: “Secondo me, ci vorranno ancora decenni”, ha spiegato al New York Times James Manyika, autore di uno degli studi più prudenti sul tema. “A dispetto di quanto pensano i tecnologi, che tendono a focalizzarsi solo su ciò che è tecnicamente fattibile, il modo in cui l’automazione influirà sul lavoro dipende anche da altre incognite”. Per esempio, dalla convenienza economica: non è un caso allora che una proposta di legge sul tema Robot & Lavoro depositata al Parlamento Europeo sottolinei la necessità di tassare le imprese proporzionalmente al livello di automazione; per impedire che i loro guadagni aumentino drasticamente (i robot non richiedono stipendi, tredicesime, ferie, malattie; solo acquisto e manutenzione) senza che nulla venga restituito alla società e per far sì, magari, che contribuiscano per via fiscale all’introduzione di un reddito di cittadinanza.
La questione del reddito di cittadinanza (o reddito di base; sulle differenze terminologiche torneremo più avanti) è oggi inestricabilmente legata all’automazione del lavoro. Un legame indissolubile, ribadito da più parti, che fa sì che l’idea di garantire a tutti uno stipendio minimo venga considerato un tema innovativo e futuribile. Sulla questione ha qualcosa da dire Tommaso Moro, il filosofo umanista che – nella sua celebre opera L’Utopia, pubblicata nel 1516 – è stato il primo a proporre qualcosa di simile a un reddito garantito, allo scopo di ridurre i furti nell’Inghilterra del tempo.
“Provvedere affinché tutti abbiano i mezzi per guadagnarsi da vivere”, scrive Moro, avrebbe contribuito a far scendere il tasso di criminalità molto più efficacemente dell’impiccagione, che peraltro aveva uno sgradevole effetto collaterale: l’aumento del numero di omicidi. Più che al reddito garantito, però, Moro mirava all’impiego garantito; ragion per cui se si vuole cercare la più antica proposta veramente vicina al reddito minimo bisogna guardare a un altro umanista: Juan Luis Vives. Il filosofo elaborò nel 1526 una dettagliata proposta – destinata al sindaco di Bruges con il titolo “De Subventione Pauperum” – in cui descrisse la necessità che fosse il municipio della città a occuparsi di garantire un minimo di sussistenza a tutti i suoi residenti.
La questione del reddito di cittadinanza è oggi inestricabilmente legata all’automazione del lavoro.
Vives prevedeva inoltre che questa sorta di reddito minimo dovesse spettare a tutti: “Anche quelli che dissipano le loro fortune in una vita dissoluta – attraverso il gioco, le donne, il lusso esagerato, le scommesse – dovranno ricevere il cibo; perché nessuno dovrebbe morire di fame. D’altra parte, a costoro andrebbero assegnate razioni minori e compiti peggiori, in modo che possano essere d’esempio agli altri”.
In un’epoca in cui il problema non era tanto la disoccupazione, ma la povertà (“anche i vecchi e gli stupidi possono imparare un lavoro in pochi giorni, come scavare buche o portare l’acqua”, scriveva Vives; oggi il problema è proprio che a breve questi lavori non esisteranno più), ancora non veniva presa in considerazione la possibilità che qualcuno potesse ricevere soldi senza in cambio offrire quanto meno la disponibilità a lavorare.
Bisogna arrivare all’epoca delle rivoluzioni, sul finire del ‘700, per trovare un pensatore che sostenga l’idea di un reddito minimo incondizionato, giustificato come forma di ricompensa per l’ingiustizia insita nella proprietà terriera. L’autore di questo concetto è il filosofo, politico e rivoluzionario Thomas Paine: “La terra, nel suo stato naturale e non coltivato, era, e sarebbe continuata a essere, una proprietà comune a tutta la razza umana”, scrive nel libello Giustizia Agraria. “(…) Ogni proprietario terriero, per questa ragione, deve alla comunità una rendita per la terra che possiede”. Una rendita, prosegue Paine, “che dovrebbe essere pagata a ogni singola persona quando arriva all’età di ventuno anni”.
Se nell’Ottocento il reddito di base poteva rappresentare la compensazione per l’ingiusta sottrazione di terre che sarebbero spettate per natura a tutti, negli anni Duemila lo si potrebbe considerare una compensazione per il lavoro gratuito che, inseriti come siamo nel “capitalismo dei dati”, svolgiamo quotidianamente senza ricevere nulla in cambio.
“Quando si parla di reddito di base, solitamente si intende una forma redistributiva, quindi secondaria. Io ritengo che, oggi, i processi di creazione del valore utilizzino invece una parte della vita degli individui senza che venga certificata come produttiva”, spiega a il Tascabile Andrea Fumagalli, docente di Economia Politica all’Università di Pavia e uno degli economisti italiani più attivi sul fronte del reddito di base.
“L’attività di consumo, ma anche quella artistica e di svago, non rientrano nelle categorie del labor novecentesco, ma sono comunque inserite in un processo di produzione di valore: quando sono su Facebook produco valore attraverso i big data; quando al supermercato pago con una fidelity card entro in un meccanismo di produzione del valore e lo stesso si può dire per una molteplicità di azioni che compiamo quotidianamente online ma non solo”.
Si potrebbe considerare il reddito di base come una compensazione per il lavoro gratuito che, inseriti come siamo nel ‘capitalismo dei dati’, svolgiamo quotidianamente senza ricevere nulla.
Il reddito di base, di conseguenza, diventerebbe una forma di compenso diretto per un lavoro che svolgiamo costantemente senza che, oggi, nessuno ci paghi per farlo: “Sarebbe la remunerazione di un’attività lavorativa che non viene considerata come tale”, conferma Fumagalli. “Da questo discende un altro aspetto fondamentale: se è una remunerazione per un lavoro che svolgo, non può essere sottoposta ad alcuna condizione”.
Vale a dire, per esempio, che il reddito di base non andrebbe elargito solo a chi si impegna a cercare lavoro o solo per un limitato periodo di tempo; al contrario, dev’essere fornito incondizionatamente e dev’essere un reddito sufficiente a vivere: “L’obiettivo dovrebbe essere di portare tutte le persone alla soglia di povertà relativa, che è di circa 700 euro al mese a testa”, prosegue il professore. Ed è proprio per questa ragione che dev’essere lo Stato, e non direttamente le aziende private, a ricompensare i cittadini per il servizio svolto: per assicurarsi che il compenso per questa produzione di valore abbia una funzione sociale nei confronti delle classi più disagiate.
Fornendo potenzialmente a tutti un reddito di questo tipo, però, si andrebbe incontro a una società in cui lavorare diventa un’opzione. Una società post-lavoro, insomma; difficile da accettare in una “Repubblica fondata sul lavoro” come la nostra, in cui il lavoro è anche “una forma di affermazione e costruzione dell’identità personale”.
Questa visione si trova perfettamente espressa da Michele Serra in una recente Amaca pubblicata su Repubblica, il 24 gennaio: “Riuscite a immaginare un mondo nel quale la propria fisionomia individuale e sociale non sia anche il frutto di quello che si è capaci di fare? Io no. Sono cresciuto nel mito del ‘lavoro ben fatto’, dell’operaio Faussone (Primo Levi, ‘La chiave a stella’). (…) Una eventuale società di assistiti, nella quale il ‘lavoro ben fatto’ diventa appannaggio di pochi privilegiati, non sarebbe forse una società di depressi, anche se con la pancia piena?”.
A un ragionamento di questo tipo si potrebbe replicare sottolineando una differenza generazionale: il “mito del lavoro” ben si applica a chi, com’è il caso dei figli del dopoguerra e dei decenni successivi, ha goduto di uno scambio equo: la disponibilità a lavorare in cambio di diritti, tutele e garanzie. Più difficile proporre questa visione a una generazione che semmai ha davanti a sé il “miraggio del lavoro”.
Ma l’aspetto fondamentale è un altro: davvero una società in cui chiunque può ottenere un reddito di base incondizionato si trasformerebbe in una società “di assistiti depressi con la pancia piena”? “Personalmente, mi rifiuto di pensare che le persone passerebbero il loro tempo davanti alla televisione”, spiega il professor Fumagalli. “È vero invece che ci sarebbe maggiore possibilità di esprimere se stessi nella gestione libera e autonoma del proprio tempo. Si tornerebbe al concetto di otium latino, sfruttando il tempo liberato per svolgere attività di proprio gradimento, per partecipare all’attività sociale della comunità di riferimento, per costruire relazioni migliori e magari per brevettare invenzioni significative”.
A sostenere la tesi secondo cui il reddito di base non porterebbe a una società di sdraiati sul divano è anche un’azienda privata come Y Incubator (il più importante incubatore di start-up della Silicon Valley), che ha deciso di elargire per un anno un reddito compreso tra i mille e i duemila dollari al mese a 100 famiglie di Oakland. Per quale ragione un’impresa dovrebbe farsi carico di un impegno del genere? Al di là dell’attività di lobbying che la Silicon Valley sta facendo in favore dell’universal basic income – per evitare l’ira funesta di chi subirà sulla sua pelle l’automazione del lavoro – la ragione sembra essere un’altra: “Y Incubator sta fornendo questo reddito a persone dotate di un certo tipo di istruzione e di abilità; vogliono vedere se metteranno a frutto questi soldi in maniera utile per loro. Se, insomma, grazie al tempo liberato riusciranno a inventare qualcosa che potrà poi essere messo a frutto”, prosegue Fumagalli. “È un capitalismo avanzato tipico della Silicon Valley, che si scontra con le visioni sindacali dell’etica del lavoro basate su una società passata”.
Quello di Y Incubator, però, non è l’unico esperimento in atto. Una forma di reddito di base viene elargita, a partire dall’inizio del 2017, anche in Finlandia: il governo di Helsinki ha infatti varato un programma sperimentale che garantisce un reddito di 560 euro mensili a 2000 cittadini disoccupati, che non dovranno fornire giustificazioni sul modo in cui spenderanno i soldi e che manterranno la somma (detratta però da eventuali altri sussidi) anche se dovessero trovare un lavoro.
Ma a fornire i dati più interessanti sono due esperimenti che si sono tenuti nel passato. Il primo risale al 1969 e ha come protagonista Richard Nixon, che aveva uno dei suoi più ambiziosi obiettivi proprio nell’introduzione di uno universal basic income “di destra” (torneremo più avanti su questa divisione). La sperimentazione venne avviata corrispondendo l’equivalente odierno di 10mila dollari l’anno (quindi circa 800 dollari al mese) a 8.500 cittadini, senza alcuna condizione.
Quale fu la conseguenza? Che le ore lavorate diminuirono del 9% (non esattamente il trionfo dell’assistenzialismo), principalmente perché i giovani sfruttarono questo reddito per proseguire gli studi, o comunque per formarsi, e perché alcuni genitori sacrificarono parte delle ore lavorative per dedicarle alla cura dei figli. Il grande piano di Nixon finì nel nulla, soprattutto a causa della strenua opposizione di uno dei suoi principali consiglieri: Martin Anderson.
La questione della ‘pigrizia indotta dal reddito di base’ sembra essere smentita non solo dai progetti che prendono forma nella Silicon Valley, ma anche dagli studi condotti sugli esperimenti del passato.
Un altro esperimento del passato si tenne negli anni ‘70, in Canada, nella provincia di Manitoba: per cinque anni i cittadini più poveri della provincia ricevettero un assegno mensile, anche in questo caso di circa 800 dollari. La fase di test si interruppe bruscamente a causa del cambio di governo, ma fu comunque sufficiente a fornire i dati che l’economista Evelyn Forget ha utilizzato in uno studio del 2011. Stando a quanto risulta dagli studi di Forget, il tasso di scolarizzazione salì notevolmente, mentre i tassi di ricovero in ospedale calarono, grazie alla maggiore possibilità dei cittadini di procurarsi le cure di base. Nel complesso, invece, la quantità di ore lavorate scese solo dell’1%.
Insomma, la questione della “pigrizia indotta dal reddito di base” sembra essere smentita non solo dai progetti che prendono forma nella Silicon Valley, ma anche dagli studi condotti sugli esperimenti del passato. La stessa questione, però, si ritrova anche analizzando la differenza tra le due varianti fondamentali del reddito di base: il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza strettamente inteso; una differenza decisiva, sulla quale si fa spesso confusione.
Sintetizzando: il reddito minimo garantito comporta che, per esempio, chi non lavora riceva 800 euro al mese, chi invece ha un reddito di 600 euro ne riceva altri 200, come integrazione, e chi guadagna più di 800 euro non riceva nulla. Il vero e proprio reddito di cittadinanza prevede invece che vengano dati 800 euro mensili a tutti, dal disoccupato nullatenente fino a Bill Gates.
Ma perché mai lo stato dovrebbe spendere soldi per darne a chi non ne ha bisogno? È proprio per rispondere a questa domanda che ritorna la questione della pigrizia. I sostenitori del reddito di cittadinanza da elargire a tutti, miliardari compresi, sostengono che solo attraverso uno strumento di questo tipo si evita che le persone siano disincentivate a lavorare. La logica è la seguente: se lo stato mi dà 800 euro indipendentemente da tutto e mi viene offerto un lavoro da 1000 euro al mese, lo accetterò volentieri, perché avrò così la possibilità di mettere assieme 1.800 euro mensili. Se invece accettare quel lavoro dovesse provocare la perdita del reddito di base di 800 euro, lo rifiuterei: perché dovrei lavorare 40 ore a settimana per 200 euro in più?
“Non riesco a considerare una conseguenza negativa il fatto che una persona, grazie al reddito minimo, abbia la possibilità di rifiutare un lavoro. Anzi, che un lavoratore sia messo nelle condizioni di rifiutare i lavori malpagati è solo positivo, potrebbe anche portare a una crescita dei salari”, prosegue Fumagalli, sostenitore di un reddito di base la cui elargizione si interrompa oltre una certa soglia di reddito.
La differenza tra un reddito minimo garantito e un reddito di cittadinanza indipendente da qualunque altro fattore sta, ovviamente, anche nei costi enormemente differenti: “Nel primo caso, si tratta di portare alla soglia di povertà relativa tutti gli italiani che, nel 2017, si trovano al di sotto, ovvero 9 milioni di persone. Andando a vedere i calcoli Istat, e i dati della Commissione di Indagine sulla Esclusione Sociale, se ne deduce che una misura di questo tipo costerebbe circa 22/23 miliardi di euro l’anno”.
Non sono pochi. Ma da questi 22 miliardi si dovrebbero sottrarre tutte le forme di sussidio che verrebbero sostituite dal reddito minimo: Aspi, Naspi, cassa integrazione in deroga, indennità di mobilità, ecc ecc; resterebbero da recuperare circa 11/12 miliardi di euro: “Se pensiamo che nelle due ultime leggi di stabilità, tra riduzione dell’Irap, dell’Ires, super-ammortamento e incentivi per il Jobs Act, si sono spesi circa 11 miliardi; ecco che le risorse si possono trovare”. Un modo anche per ribaltare la logica con cui vengono spesi i soldi da parte dello Stato: “Perché spendere una decina di miliardi di euro a sostegno della produzione quando si possono spendere gli stessi soldi per sostenere la domanda?”, prosegue Fumagalli.
Nel caso di un reddito di cittadinanza fornito a tutti, indipendentemente dal reddito, i costi sono decisamente più elevati. I calcoli, in compenso, sono molto più semplici: fornire 800 euro al mese a tutti i cittadini maggiorenni (in Italia, 47 milioni di persone) verrebbe a costare la spropositata cifra di 450 miliardi di euro. Una voce che sarebbe pari a poco più del 50% di quanto lo stato spende complessivamente ogni anno (circa 830 miliardi di euro).
Ma il fatto che abbia un costo stratosferico non significa che sia un progetto impossibile da realizzare: “Sostenendo tale ipotesi, si correrebbe però il rischio di azzerare qualsiasi servizio sociale diretto e indiretto e il reddito di cittadinanza dovrebbe diventare quasi l’unica voce di spesa dello stato. Il che significherebbe privatizzare tutto: dalla scuola alla sanità, dalle carceri all’esercito”. Un incubo per chiunque ritenga che il mercato debba restare fuori (almeno in parte) da determinati settori e un sogno iper-liberista in cui lo stato si fa talmente leggero da non dover fare altro che staccare un assegno mensile per ogni suo cittadino (ma deve comunque raccogliere le tasse, ovviamente).
Che lo stato (specie quello italiano) decida a breve di abdicare al suo ruolo per diventare un immenso libretto degli assegni è altamente improbabile; lo stesso non si può dire per la possibilità che un reddito minimo garantito venga introdotto per tamponare gli effetti dell’automazione del lavoro. Il reddito minimo, come detto, potrebbe diventare realtà più per obbligo che per scelta, ma contribuirebbe comunque a modificare radicalmente la nostra cultura e a precipitarci in una società completamente nuova: la società post-lavorativa, in cui il lavoro salariato diventa un’opzione e non più la forma stessa della nostra identità sociale.
La battaglia sul reddito minimo potrebbe riunire la sinistra a quella fascia della popolazione che dalla sinistra si è sentita tradita: i precari, le finte partite Iva, il popolo dei voucher, i disoccupati.
È per questa ragione che la sinistra italiana rischia di compiere un errore gravissimo a lasciare un tema del genere nelle mani del Movimento 5 Stelle (il cui fondatore, Gianroberto Casaleggio, era ammiratore della versione ultra-libertaria, ma un necessario pragmatismo ha fatto sì che le proposte di legge depositate dal M5S siano relative al reddito minimo garantito). Un errore a cui non si sta ponendo rimedio, se si considera che il leader del più grande partito della sinistra italiana – che al momento è ancora Matteo Renzi – ha definito il reddito di base “la cosa meno di sinistra che esista” e che Sel-Sinistra Italiana (che ha depositato anch’essa una sua proposta a riguardo) batte su questo chiodo con molta meno convinzione dei grillini.
E pensare che, idealmente, quella del reddito minimo garantito e incondizionato potrebbe essere la nuova grande battaglia della sinistra; una battaglia in grado di dare un nuovo orizzonte a un’area politica che proprio sul lavoro sta perdendo la sua identità; un sol dell’avvenire da inseguire per arrivare a una società in cui nessuno sia più costretto ad accettare qualunque tipo di trattamento economico e di sfruttamento orario perché privo di alternative.
La battaglia sul reddito minimo potrebbe riunire la sinistra a quella fascia della popolazione che dalla sinistra si è sentita tradita: i precari, le finte partite Iva (ma pure quelle vere), il popolo dei voucher, i lavoratori a cottimo della on-demand economy, i disoccupati e tutta quella nuova generazione di non garantiti che si sono sentiti abbandonati da una sinistra e da un mondo sindacale che scende in piazza solo in difesa di chi, comunque, ancora può contare su tutele certe, su una pensione assicurata e più in generale su quei diritti che sono stati ormai trasformati in privilegi (come gli straordinari pagati o le tredicesime).
È proprio nel vuoto di idee offerto ogni volta che si parla di giovani e lavoro che la sinistra ha perso la sua battaglia, lasciando che fosse il Movimento 5 Stelle a impugnare, tra contraddizioni insanabili, quella che potrebbe essere la soluzione per conciliare due generazioni di lavoratori senza mettere l’una contro l’altra. Il reddito di base e la costruzione di una società post-lavoro potrebbero rappresentare un progetto a lungo termine con la giusta dose di utopia. La sinistra così ritroverebbe la sua ragion d’essere originaria: difendere i più deboli. Questa volta, però, non dai padroni, ma dai robot.