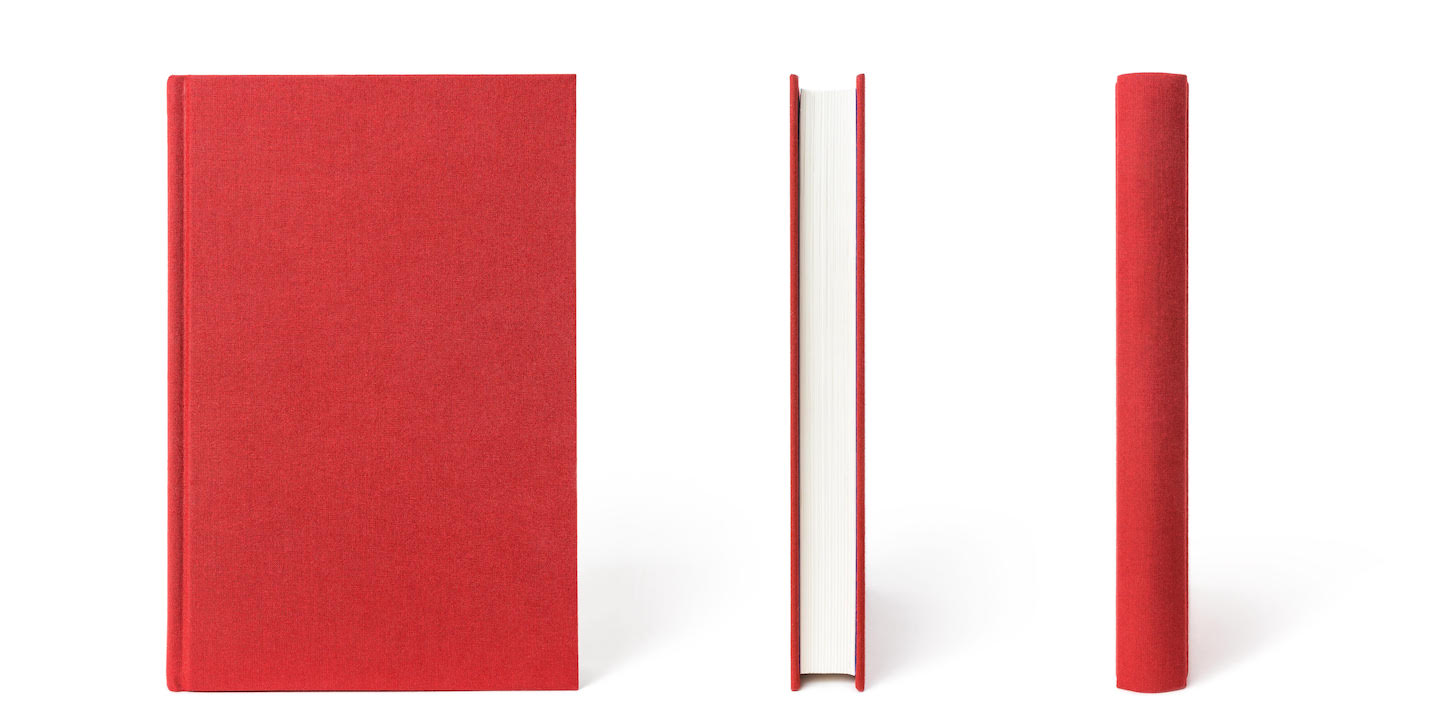
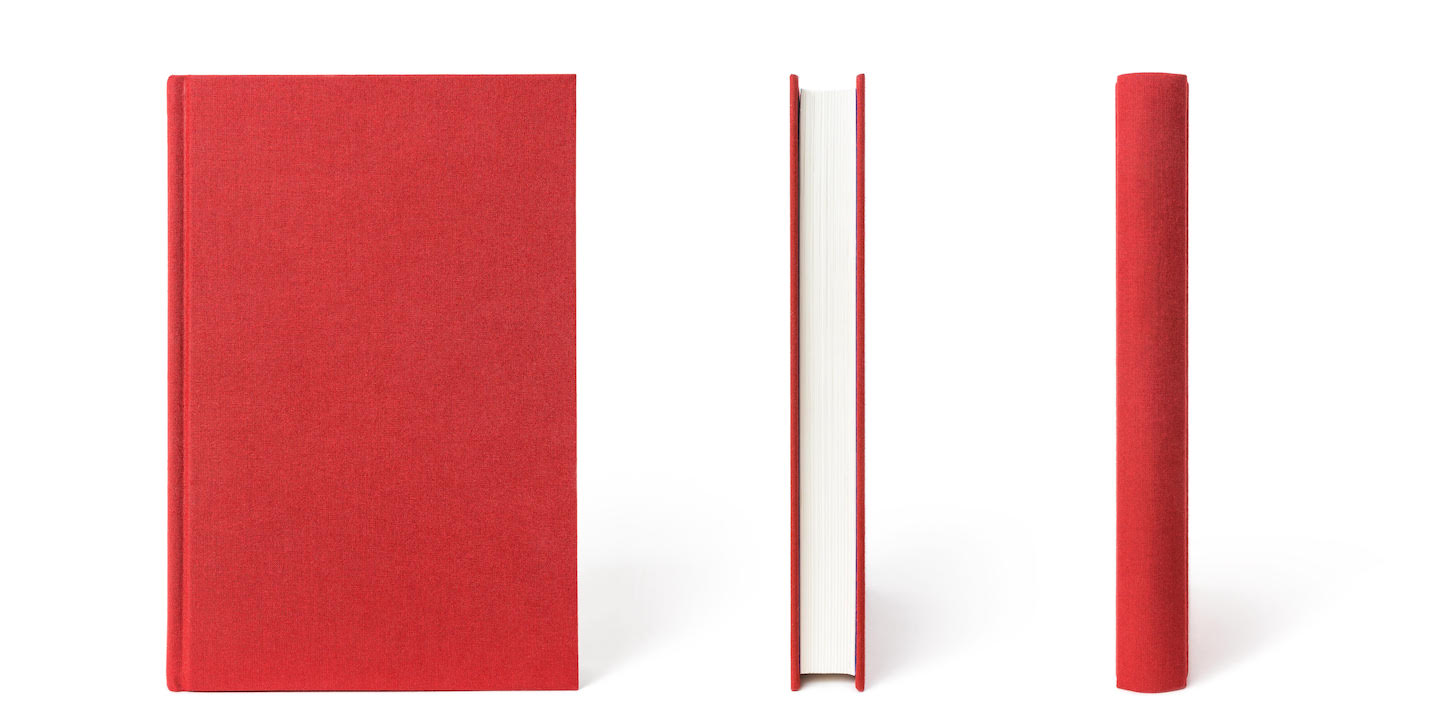
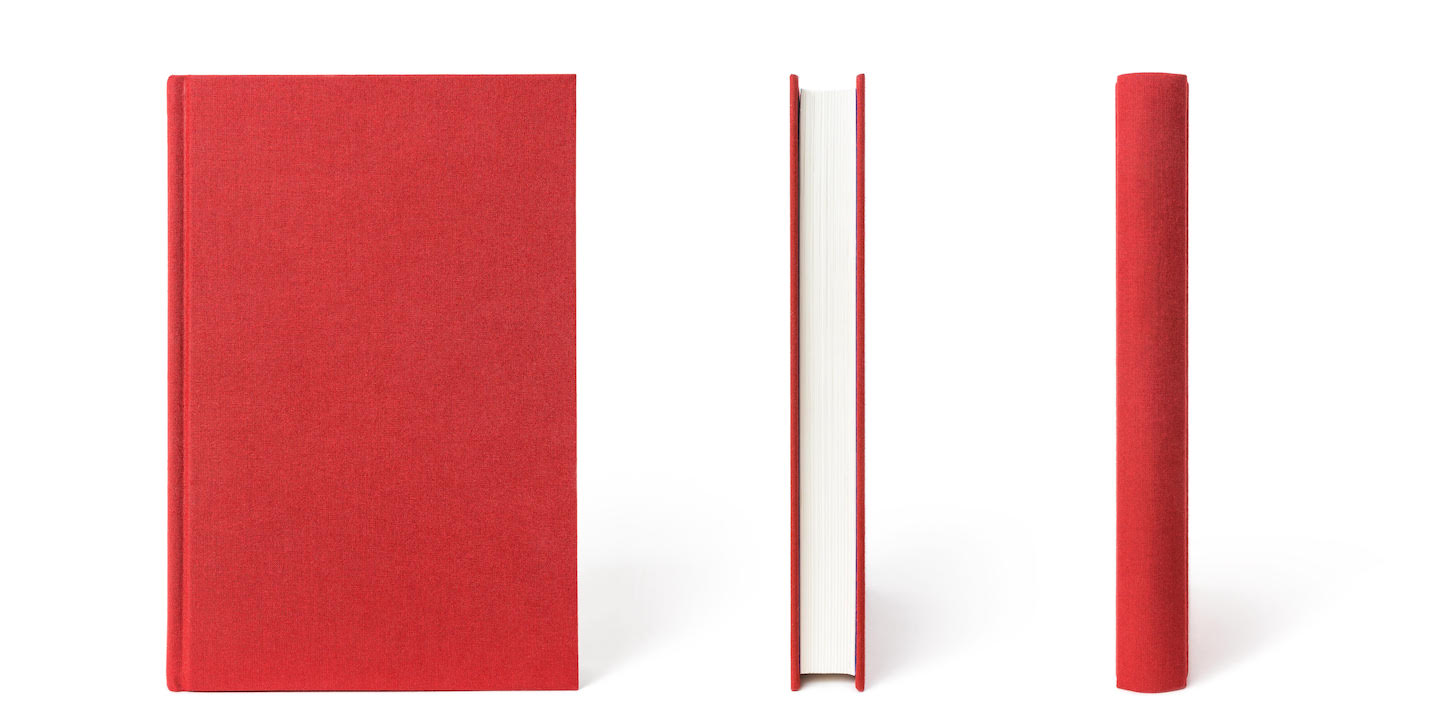
P er molto tempo mi sono sentita sbagliata: vedevo le persone intorno a me misurare la propria vita contando i passi in avanti nella propria professione, mettere i ‘check’ al raggiungimento di ulteriori mansioni da svolgere, bramare il carico di responsabilità, ammirare tutto ciò che sembrava in grado di oliare il meccanismo dell’adultità.
Ho potuto vedere con i miei occhi persone che volevano più da-fare, più ore, più rogne persino, e avvertire con quanta ansia volessero allontanarsi dalla de-realizzazione che ti dà l’essere senza step, senza prospettive, senza crescita lavorativa. Sembrava che farcela nel lavoro fosse l’unico modo attraverso il quale dar conto della propria esistenza, sembrava che bisognasse tutti e tutte giocare al gioco della busta paga, sembrava che non volercela fare significasse dover esibirel’intralcio della propria mediocrità.
Il lavoro come elemento fondante dell’individualità, non criticabile: quello che andava fatto per essere, alfine, realizzati, per esistere realmente.
Qualche giorno fa, in occasione del Primo Maggio il giornalista Alessandro Sahebi ha divulgato sui social una serie di card – anche di questo deve vivere chi frequenta il lavoro intellettuale oggi – scrivendo: “La skill di cui hai bisogno per stare meglio si chiama dunque conflitto”. L’accostamento tra la più abusata delle parole coeve con una che abbiamo disimparato a nominare mi ha ricordato il disagio che sento davanti al linguaggio anglicizzato e alla verve carrieristica ma anche che, per fortuna, faccio parte di questa cosa che si chiama Redacta. Ho tirato un sospiro di sollievo: è da qualche anno che, nel volermi sottrarre dall’equazione stipulata tra il nostro lavoro e il nostro valore, non mi sento più sola. E come me, molte altre persone.
Guardarsi negli occhi, dirsi la verità
Ad aprile 2019, Redacta è nata dall’iniziativa di alcuni soci e socie Acta come inchiesta sulle condizioni di lavoro nel settore dell’editoria libraria. È iniziata in modo semplice: sedute in cerchio dentro una stanza abbiamo iniziato a chiederci “Come va?”, “Come stai?” e, contestualmente, abbiamo iniziato a capire insieme che, nonostante stessimo svolgendo il lavoro per il quale avevamo studiato a lungo e per il quale avevamo forse chiesto sacrifici ai nostri genitori, non stavamo poi così bene. Il lavoro dei sogni, sì: correggere una prima bozza, revisionare una traduzione scricchiolante, fantasticare sulla copertina più accattivante, compilare schede di lettura, dare il “visto si stampi”: sembrerebbe un sogno, sì – se solo non fosse un lavoro.
Alessandro Sahebi ha scritto: “La skill di cui hai bisogno per stare meglio si chiama conflitto”
Ci sentivamo isolate e dunque sole perché lavoravamo spesso da casa, dalla stanzetta, dal tavolo del soggiorno; ci sentivamo diverse le une dalle altre a causa della vasta frammentazione di inquadramenti – possono una partita iva e un diritto d’autore parlare insieme per davvero di lavoro? –, ci sentivamo uniche ma in un senso sempre più deteriore, anche se ci era sempre stato insegnato che per farcela bisogna competere, emergere, primeggiare. Ma, nonostante le differenze, un unico comune denominatore c’era eccome: tutte guadagnavamo poco, troppo poco; percepivamo compensi bassi, troppo bassi per vivere a fronte di un’intensità lavorativa piuttosto sostenuta e qualifiche elevate (ovvero anni di studio e magari un master, quando i risparmi o le possibilità erano disponibili per la nostra formazione).
Là, in quelle stanze in cui abbiamo iniziato a incontrarci e a guardarci negli occhi per dirci la verità e rompere il tabù che aleggia intorno ai soldi, non abbiamo dovuto riflettere troppo a lungo su quello che stavamo facendo: ci stavamo unendo per trovare soluzioni condivise a problemi comuni. Era l’inizio di un’esperienza sindacale.
Parlando con le persone che ci dicevano che eravamo figli e figlie del privilegio per poter fare un lavoro intellettuale, che dovevamo ringraziare per le opportunità, che dovevamo lasciar perdere perché se un settore è povero c’è poco da brigare né alcun conflitto da innescare, abbiamo iniziato a essere quelle che invece di parlare di passione pronunciavano la parola ‘soldi’, quelle che invece di prestare il fianco all’individualismo preferivano riunirsi in una coalizione. Abbiamo messo in piedi uno spazio di convergenza per tutte le persone che lavorano nell’editoria libraria e che non hanno mai avuto un luogo – fisico, ma anche metaforico – in cui ritrovarsi e confrontarsi. E per trasformare un quesito cortese in una domanda che ci ricomprendesse nel modo più collettivo possibile, siamo passate dal contingente “Come stai?” allo strutturale “Come stiamo?” per indagare le condizioni di lavoro nel mondo del lavoro editoriale: le nostre.
Nel 2019 abbiamo fatto un primo sondaggio perché, prima di poterlo cambiare radicalmente, un settore è necessario ricostruirlo, e l’auto-inchiesta è il primo passo per riconoscersi tra pari e mobilitarsi. Quella di Redacta è un’inchiesta che non ha mai subìto una battuta d’arresto perché non è mai finita la necessità di capire le condizioni in cui versiamo (anche i contributi) e che si è rinnovata pochi mesi fa con il nostro secondo sondaggio, “Vale davvero la pena di lavorare in editoria?”.
Se l’inchiesta è permanente, la lotta per i soldi è senza quartiere
“Il lavoro culturale è povero” è un refrain quasi consolatorio e autoindulgente ma spesso manca la volontà di andare oltre e scomodare i numeri.
Dopo un numero incalcolabile di riunioni in giro per l’Italia, partecipazione a panel ed eventi, lezioni in università, ore su Zoom, gruppi di lavoro, abbiamo deciso che era ora di aggiornare la fotografia scattata all’editoria e tornare a metterla a fuoco in modo più completo, strutturato, tenendo conto di tutto quello che abbiamo imparato in questi ultimi anni.
Abbiamo messo in piedi uno spazio di convergenza per tutte le persone che lavorano nell’editoria libraria e che non hanno mai avuto un luogo in cui ritrovarsi e confrontarsi.
Al nostro sondaggio, rivolto a tutte le figure della filiera – dalle autrici agli stagisti – e a tutti gli inquadramenti, compilabile da giugno a settembre 2023, hanno risposto 825 persone: è un numero che non ha rilevanza statistica ma che di certo è significativo soprattutto in un settore in cui, tendenzialmente, le persone bisogna tirarle per la giacchetta e convincerle che quello che stanno facendo è un bel lavoro, sì, ma è pur sempre un lavoro. I risultati sono consultabili per intero dal sito di Acta ma se ne serve uno che faccia da catalizzatore dell’attenzione può bastare forse questo: 17.660 euro è il reddito mediano netto annuo di chi lavora unicamente in editoria libraria. Diciassettemilaseicentosessanta euro con cui pagarsi l’affitto in città dove il costo della vita è mediamente più alto, dove gli affitti galoppano verso cifre astronomiche e gli spazi per lavorare come i co-working sono sono sempre meno accessibili.
Allargando lo sguardo oltre al singolo dato estrapolato, i risultati del sondaggio di Redacta restituiscono l’immagine di un settore che si tiene in piedi spingendo con tutto il peso sulla compressione continua del costo del lavoro, sfruttando l’isolamento di collaboratori e collaboratrici freelance, sovraccaricando di mansioni chi ha un contratto da dipendente, abusando della turnazione forsennata di stagisti e stagiste, evitando di pagare le royalties alle figure autoriali.
L’editoria libraria assomiglia tremendamente all’immagine della vecchia imbellettata di Pirandello: “Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere […]”.Similmente a me pare di vedere un’editoria tutta impegnata con uscite su uscite di libri engagé, pubblicati su impulso di un vago progressismo formale; mi pare di vedere un’editoria goffamente imbellettata con proclami sulla sacralità della cultura e parata di buoni propositi sbandierati a ogni appuntamento editoriale, dimentica del fatto che l’aspetto gradevole con cui si presenta in pubblico nasconde grottesche condizioni di lavoro.
Oscurantismo dell’editoria, illuminismo degli strumenti
E tuttavia, ricostruire lo stato dell’arte dal punto di vista di lavoratori e lavoratrici del settore è un passaggio necessario ma non sufficiente. Le fotografie servono a immortalare, ma un attimo dopo aver scattato bisogna aguzzare lo sguardo e scandagliare il contenuto; e quella che ci restituisce il nostro sondaggio è l’immagine di un settore che può permettersi di sfruttare le professionalità per via di fattori diversi: se da una parte, infatti, abbiamo le scelte imprenditoriali e, dunque, una gestione del rapporto di lavoro che ha come obiettivo principale la più alta riduzione possibile dei costi, dall’altra è innegabile come, negli ultimi quarant’anni, si sia assistito a una sempre più massiccia esternalizzazione del lavoro redazionale e negli ultimi venti questo trend si sia rafforzato per l’impatto di tecnologie nuove, dal costo relativamente abbordabile, che hanno sostituito quelle vecchie più costose. L’avanzamento tecnologico ha permesso di creare una schiera di persone che non hanno bisogno di essere fisicamente in redazione, che non si incontrano, che non si conoscono le une con le altre e con le quali, quindi, è facile che il cliente – casa editrice, service, etc. – possa fare il bello e il cattivo tempo.
Pare di vedere un’editoria parata di buoni propositi sbandierati a ogni appuntamento editoriale, dimentica del fatto che l’aspetto gradevole con cui si presenta in pubblico nasconde grottesche condizioni di lavoro.
E quindi, se siamo nella condizione di freelance, si lavora da casa, si ricevono chiamate nelle quali viene bofonchiata una cifra e, su due piedi, ci viene affidata una mansione, per così dire, cangiante: se la guardi da una parte sembra una snella correzione di bozze ma se ti avvicini un po’ e la guardi meglio ti accorgi che in realtà quello che c’è da fare è un vero e proprio editing stilistico. E, in ogni caso, sia che si debba dare la caccia al refuso sia che ci sia bisogno di riscrivere periodi interi, quella cifra rimane là, inalterata, e ci si deve sbrigare a rispondere che sì, quel lavoro lo vogliamo perché molte altre persone sono prontissime per iniziare a lavorarci da subito.
E allora magari si prova a fare delle domande per capire il tipo di lavoro, per quando sarebbe la consegna, che storia redazionale ha avuto il testo, ma tutto si svolge in una specie di nebbia. L’indefinitezza in cui si muove un rapporto di lavoro del genere è difficile da dipanare perché manca il tempo, mancano le persone con cui poterne parlare, mancano i riferimenti per capire quanto quel certo lavoro andrebbe pagato.
Ma forse è più corretto dire ‘mancavano’. Dopo aver pubblicato i dati del sondaggio, come Redacta abbiamo reso noti due strumenti che sono il punto di arrivo di due anni di fatica, e che rappresentano la migliore incarnazione del nostro modo di fare sindacato: la Guida ai compensi dignitosi e un’applicazione che si chiama Redalgoritmo. Alla base di entrambi c’è un principio di equità – il costo del lavoro di chi è freelance deve essere equivalente a quello di chi è dipendente – e la considerazione ben più generale per cui non è accettabile né tantomeno sostenibile lavorare in un settore che sembra funzionare alla stregua della “notte in cui tutte le vacche sono nere”, in cui vale tutto e tutto è permesso perché le contrattazioni e i contatti si svolgono al buio, nell’omertà, in quell’indefinitezza che non avvantaggia mai chi lavora ma unicamente la controparte. In questo senso, usare la Guida e il Redalgoritmo equivale ad accendere la luce e vederci chiaro.
Qualcosa è cambiato, qualcosa continua a cambiare
Se qualcosa nell’editoria libraria è cambiato negli ultimi cinque anni, rimane vero che molte cose devono ancora mutare di segno e diverse altre sono in procinto di farlo. Nel dicembre del 2021, ad esempio, su questa stessa rivista usciva un articolo in cui si leggeva che: “Dovrebbe essere noto a tutti che al Salone sono di casa i discorsi sul libro come veicolo di cultura, i suoi successi, la sua capillarizzazione, le forme future che assumerà per non scomparire. Il Salone è una fiera, una kermesse, una vetrina: a Torino ci sono i libri da vendere, non i processi produttivi da analizzare. Nessuna sorpresa, quindi, che la direzione del Salone non abbia ritenuto interessante organizzare panel o altro per parlare dei gravissimi problemi della filiera e della logistica”. Seguiva un furbesco truismo secondo cui “il Salone del Libro è alcune cose e non può esserne altre”, e altre considerazioni sul fatto che lo spazio per parlare di lavoro culturale dentro le fiere e i festival è tradizionalmente residuale se non assente – nel migliore dei casi disinnescato.
E tuttavia nel programma del Salone del Libro di quest’anno si affaccia un evento dal titolo inequivocabile: “Belli i libri ma la vita di più. Lavoro editoriale e sfruttamento”. Non è la prima volta che siamo ospiti di una fiera, ma è la prima volta che lo siamo in quella principale a livello italiano. E ci sembra di poter dire che, anche per chi organizza il Salone, potrebbe essere non così abituale ospitare un evento nel quale, dati alla mano, delle condizioni economiche di lavoratori e lavoratrici del libro, di coalizioni, di traiettorie di sindacalizzazione. Non posso mettermi a scartabellare i programmi di tutti i Saloni passati per assicurarmene, ma una cosa è certa: è ben più facile che la parola ‘sfruttamento’ entri al Lingotto facente parte di un titolo – magari un libro sui rider o sulle centraliniste dei call center o, ancora, sui raccoglitori di pomodori vessati dal caporalato.
Perché questa parola, per l’ambiente editoriale, sembra andare bene sempre come Altrove, come elemento esotico di cui appropriarsi: lo sfruttamento va bene come argomento vendibile che ha pure l’effetto collaterale ma benvenuto di segnalare la virtù dell’editore che propone il titolo stesso. Stavolta, però, facciamo qualcosa di un po’ diverso: da oggetto, ‘sfruttamento’ lo facciamo diventare la lente stessa attraverso cui guardiamo all’editoria.
(Questo testo è di pugno dell’autrice ma non potrebbe esistere senza l’elaborazione collettiva che lo sostiene e anima)