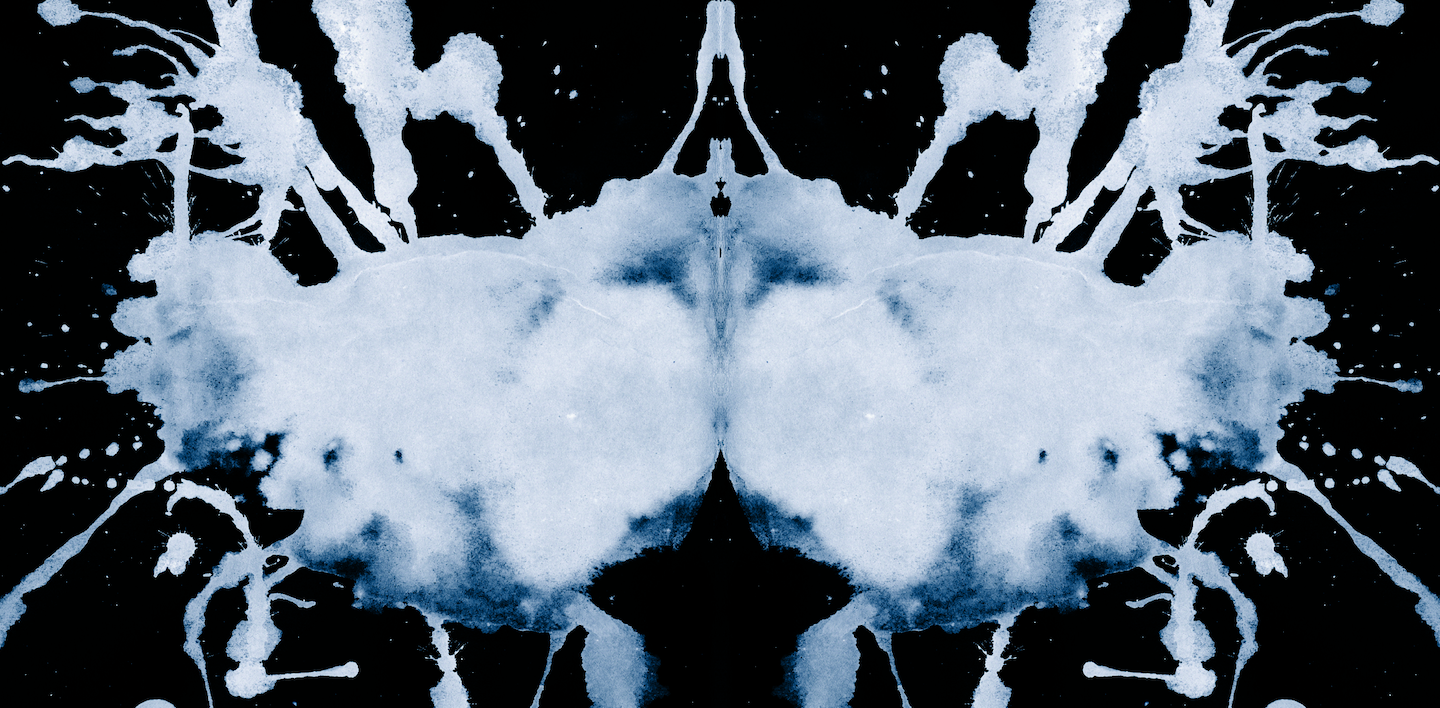
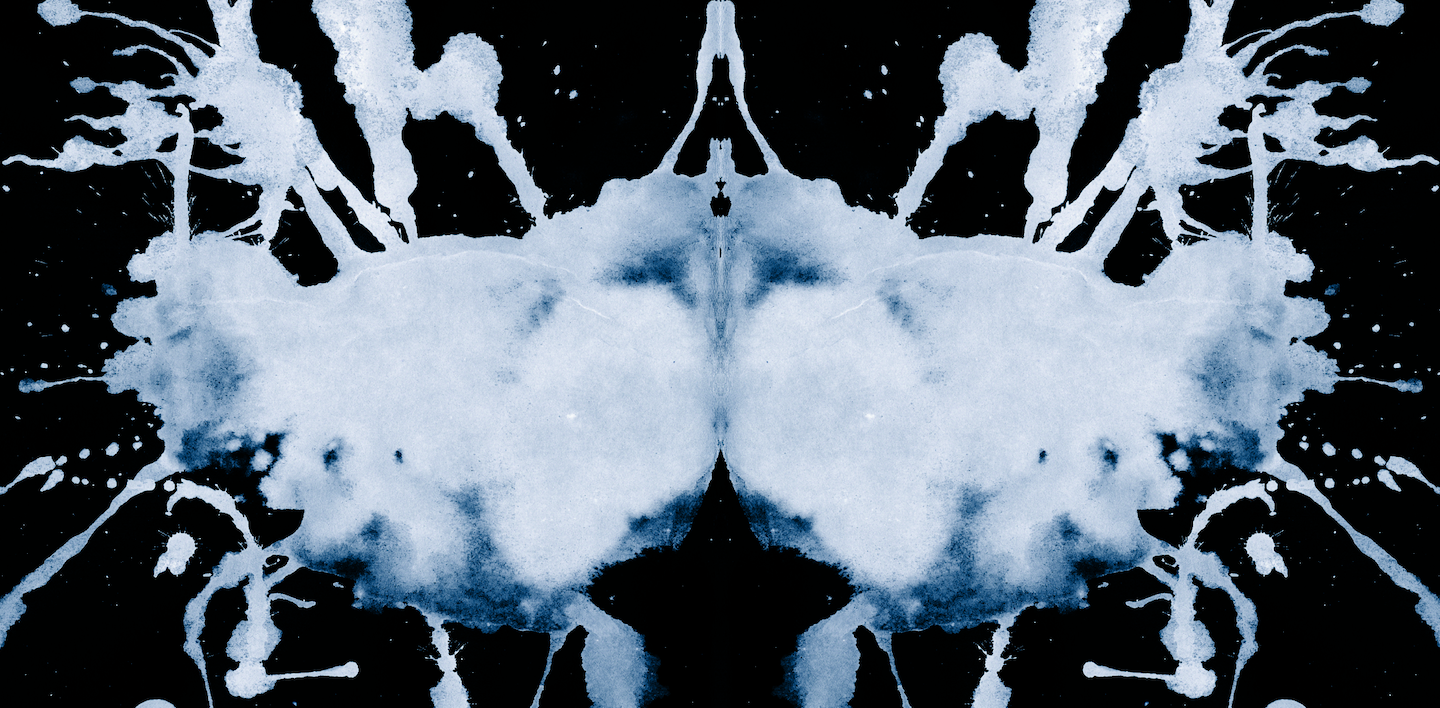
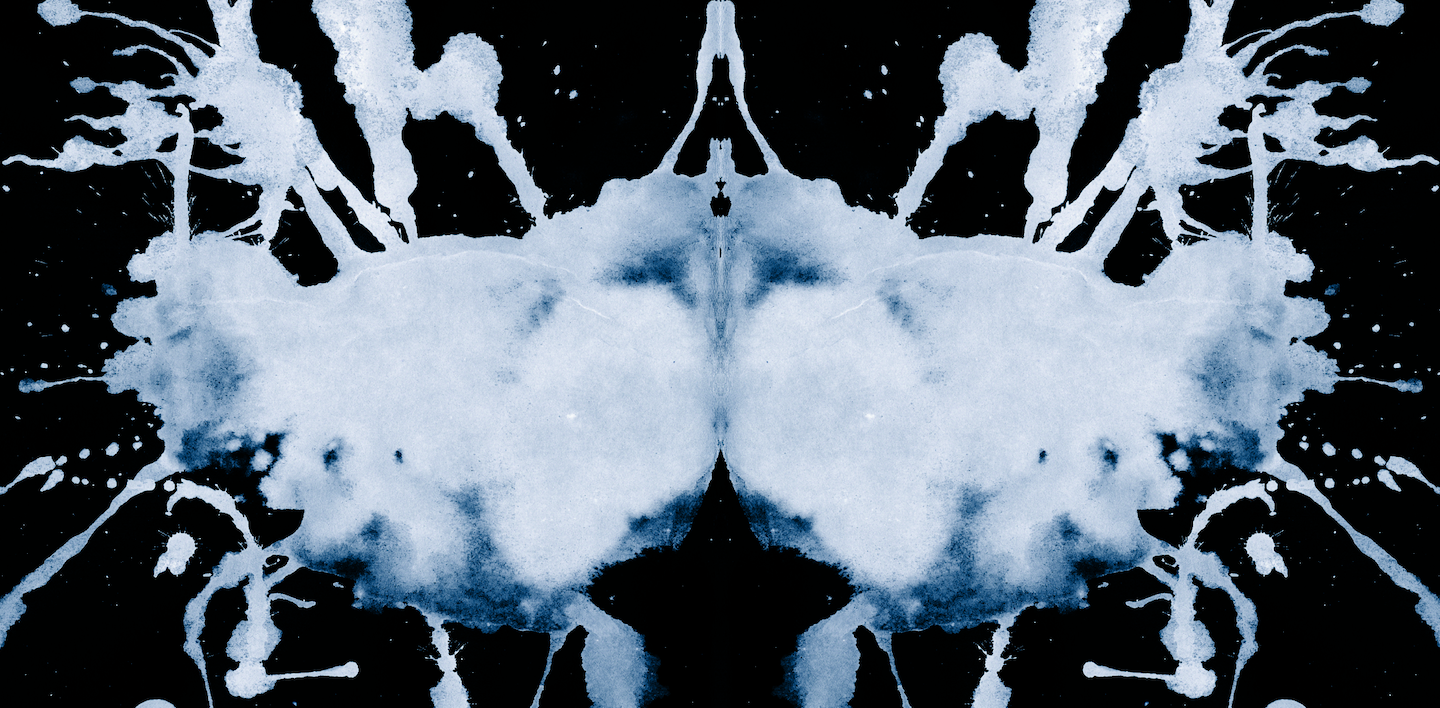
Q uale rapporto c’è fra disagio psichico e organizzazione sociale? La domanda è complessa. La sua complessità riposa, per un verso, sulla difficoltà di definire i termini in gioco. Non è semplice definire cosa è un disagio o un disturbo psichico. È più intuitivo definire, lo si fa quasi con immediatezza, un dolore. Possiamo dire quando soffriamo per una delusione personale o per la lontananza di una persona. Ma quando si tratta di qualificare una sofferenza come un disturbo mentale, in termini per esempio psicopatologici, la questione è più articolata. Dove tracciamo la differenza fra la sofferenza per un lutto improvviso e una condizione depressiva che emerge in seguito a un lutto, o fra la preoccupazione che qualcuno ci sta mentendo e la convinzione paranoica che chiunque ci sta nascondendo qualcosa? Spesso questa differenza diventa labile anche nel linguaggio quotidiano: le persone ci capiscono quando diciamo “sono depressa” per esprimere un sentimento di tristezza.
Per un altro verso, parlare di organizzazione sociale può apparire altrettanto chiaro, mentre è soltanto vago. Una famiglia asfittica, un’amicizia ricattatoria non sono semplici rapporti fra individui, ma sono rapporti codificati, sono organizzazioni sociali. Un linguaggio, la difficoltà di trovare le parole per descrivere la propria esperienza, è anche un’organizzazione sociale. Un corpus di leggi, una batteria di comportamenti stabilizzati in una comunità, sono organizzazioni sociali. Uffici pubblici, posti di lavoro, gerarchie ecclesiastiche, confini nazionali: si tratta sempre di organizzazioni sociali. E ciascuno di questi esempi può essere legato a un qualche disagio psichico.
Infine, cosa diciamo quando diciamo che c’è un rapporto fra le due cose? Intendiamo una qualche forma di causalità, come la pioggia che cade è la causa dell’asfalto bagnato? Forse intendiamo una causa scatenante in un insieme di condizioni, per esempio ragionando che un’esperienza di discriminazione sul posto di lavoro sarebbe stata certo un fastidio, ma non avrebbe scatenato nessun comportamento ossessivo, se nella storia individuale non vi fosse già stata l’esperienza, diciamo, di una famiglia disfunzionale. Oppure possiamo anche dire che il disagio psichico non ci sarebbe affatto se non esistesse un’organizzazione storica e sociale, cioè la psichiatria, che identifica come disagio psichico alcuni comportamenti umani. O quante volte ancora, a mezzo stampa, leggiamo di alcune organizzazioni sociali come di una sorta di follia collettiva: per esempio l’antivaccinismo, tema caldo di qualche tempo fa.
Può anche darsi che tutte queste domande, apparentemente significative, siano in fin dei conti complicazioni a buon mercato: al contrario, sarebbe chiaro come il sole che l’organizzazione sociale determina il disturbo psichico, in quali ne siano le forme, quali che siano i nomi che diamo loro. Uno dei meriti di Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui di Marco Rovelli consiste proprio nel tagliare a piombo la questione, riportandola all’evidenza: stiamo male e il nostro malessere ha a che vedere con la nostra società. Ma dove sta la forza di questa evidenza? E in che direzioni ci suggerisce di pensare al disagio psichico, contestualizzato micro- o macro-socialmente?
Stiamo male e il nostro malessere ha a che vedere con la nostra società.
Il testo vuole rispondere a queste domande muovendosi in diverse direzioni: la cronaca giornalistica, che raccoglie le narrazioni di casi clinici, ottenuti da interviste a professionisti e professioniste della salute mentale, e le esperienze personali dell’autore, l’antropologia filosofica, la critica sociopolitica e la storia della psichiatria. Per quanto riguarda il primo aspetto, Rovelli riassume a sommi capi, adoperando talvolta categorie psicoanalitiche, talvolta categorie psichiatriche, alcune storie di disagio psichico per mostrarne la correlazione con fenomeni sociali tipici del mondo in cui viviamo: il lavoro, l’uso di sostanze stupefacenti, l’isolamento, eccetera.
Queste narrazioni hanno due ruoli: per un verso, l’esemplificazione del legame fra rapporti sociali e interindividuali e l’eziologia del disagio psichico, per l’altro, invece, stimolare in chi legge una sorta di identificazione affettiva con gli individui di cui si narrano le sofferenze. Della risposta emotiva di chi legge si può dire poco, perché riposa, appunto, su chi risponde al testo nella lettura. Della qualità esemplificativa delle storie raccontate da Rovelli si può dire forse qualcosa, ma non molto di più: se un esempio esemplifica una tesi, un’idea, dipende innanzitutto dalla tesi che è supposto esemplificare. È da questo punto di vista che la questione diventa più tortuosa e va discussa rispetto ad altre due direzioni del libro di Rovelli: quella antropologica e quella di critica sociopolitica.
Iniziamo dalla prima. Per quasi l’intera estensione del testo, Rovelli ripete volentieri la tesi che gli individui umani sono fatti dalle relazioni che intrattengono con altri individui e con la società. Il suo obiettivo polemico è l’idea secondo cui, al contrario, ogni individuo umano è innanzitutto qualcosa di isolato, con delle proprietà o qualità diciamo intrinseche, cioè che non dipendono in modo essenziale dalle relazioni che intrattiene. La tesi relazionale di Rovelli è accompagnata da un certo tono personalistico, che si può definire come quel pensiero che attribuisce alla vita della persona umana un valore irriducibile. C’è qualcosa di essenzialmente valido nell’essere una persona, qualcosa da difendere e preservare; e, allo stesso tempo, essere una persona significa essenzialmente intrattenere delle relazioni intersoggettive e sociali.
Rovelli critica l’idea che il malessere psichico e il disturbo mentale siano innanzitutto fenomeni legati alla costituzione individuale e alla fisiologia del cervello.
Otteniamo un’idea più precisa di quello che Rovelli intende con il suo personalismo relazionale (lo chiamo così per capirci) una volta che consideriamo l’oggetto della sua critica. Cioè l’idea secondo la quale il malessere psichico e il disturbo mentale – descritto, questo secondo, adoperando categorie perlopiù psichiatriche – sono innanzitutto fenomeni legati alla costituzione individuale, per un verso, e causati da elementi neurologici e biochimici. Questi due elementi concettuali, l’individualità del disturbo mentale e il suo rapporto causale con la fisiologia del corpo umano, prevalentemente del cervello, sono legati, ma distinguibili.
Rovelli fa spazio per questa distinzione. Sottolinea per esempio come gli sviluppi più recenti nelle scienze naturali della coscienza abbiano già in parte slegato le componenti neurofisiologiche dalla dimensione strettamente individuale dell’organismo. Al contrario, la componente materiale dei fenomeni mentali viene indagata, già da decenni a questa parte, non soltanto rispetto al sistema nervoso centrale, e soprattutto al cervello, ma anche alla dimensione interattiva ed ecologica dell’organismo, essenzialmente in una relazione dinamica con il mondo che lo circonda. Dunque, se anche consideriamo il disturbo mentale in quanto causato da fattori organico-fisiologici, non è detto che questi ultimi siano legati esclusivamente e soprattutto alla costituzione dell’organismo individuale. Hanno piuttosto a che fare con gli scambi e le interazioni di un organismo individuale con il suo ambiente. Le cause organico-fisiologiche dei fenomeni mentali, e a maggior ragione di quelli psicopatologici, sono cioè già comprese come essenzialmente relazionali.
E tuttavia questo non è abbastanza. Rovelli dedica molta enfasi a sottolineare che fra le cause dei disturbi mentali non ci sono soltanto relazioni organismo-ambiente, ma anche, se non soprattutto, relazioni micro- e macro-sociali. Il disagio psichico è legato all’intreccio sia episodico, cioè dovuto a un lasso di tempo relativamente ristretto, sia biografico, cioè legato se non all’intera almeno alla più ampia vita della persona, di relazioni fra individui (relazioni familiari, affettive, sul luogo di lavoro) e delle istituzioni sociali (culturali ed economiche) che regolano, organizzano e stabilizzano la vita delle persone in una determinata comunità. Un esempio chiave può essere la sindrome da burnout: un sistema economico che sfianca un individuo in nome della produttività si può riflettere, per esempio, nelle relazioni intersoggettive che caratterizzano un posto di lavoro. Questa costellazione di relazioni, che può anche essere episodica, potrebbe a sua volta installarsi su una biografia già caratterizzata da uno stato di sofferenza, scatenando così l’espressione acuta di un comportamento o di stati affettivi che discorso e pratica della psichiatria indicano con il concetto di sindrome da burnout.
Il disturbo mentale non sarebbe dovuto quindi soltanto a relazioni organiche e biologiche; ma anche a relazioni intersoggettive, istituzionali, economiche. Il discorso e la pratica della psichiatria hanno fatto loro questa lezione: si parla infatti di modello bio-psico-sociale del disturbo mentale. Perciò non a torto Rovelli discute con occhio critico il paradigma biomedico – cioè, in breve, l’idea secondo cui il disagio psichico è da descrivere come il prodotto di processi organici e dunque da rimuovere intervenendo su quegli stessi processi (spesso con una terapia farmacologica).
Se anche consideriamo il disturbo mentale in quanto causato da fattori organico-fisiologici, questi ultimi hanno comunque a che fare con gli scambi e le interazioni di un organismo individuale con il suo ambiente.
Però le sue osservazioni – o, come già detto prima, il suo personalismo relazionale – non si limitano soltanto alla spiegazione delle cause del malessere psichico. Al contrario, vogliono anche sviluppare una critica di come questo è compreso e trattato nella società contemporanea. Ed è proprio in questo contesto che il problema dell’individualità o dell’individualismo, come lo indica Rovelli, prende tutto il suo peso. Il testo intende mostrare al grande pubblico che sofferenza psichica e comportamenti psicopatologici vengono trattati, nel mondo di oggi, cioè nel sistema produttivo, negli schemi culturali, nel sistema sanitario, spesso e volentieri come affari dell’individuo che ne è affetto: come qualcosa che sorge nell’individuo e che va eliminato intervenendo sull’individuo.
Questa prospettiva, se sono vere le osservazioni fatte sulla natura relazionale, micro- e macro-sociale del disordine mentale, è falsa e probabilmente controproducente. Essa non è tuttavia priva di cause a sua volta, che sono per Rovelli categorizzate sotto il concetto di individualismo. Questo sta a indicare che il sistema di produzione tardo-capitalistico, i sistemi sanitari che vi si allineano e le pratiche discorsive e culturali tendono a deviare l’attenzione dalle radici sistemiche degli eventi che riguardano la vita gli individui, come può essere appunto la sofferenza psichica, per farne una questione di responsabilità individuale: è colpa della tua inettitudine se ti viene l’ansia sul posto di lavoro – o, al più, del tuo cervello mal calibrato, della chimica del tuo corpo che va rimessa in ordine. Questo genere di critica – che si può per esempio ritrovare in autori come Franco Berardi, Mark Fisher o Brian Massumi, o già nel discorso antipsichiatrico di Michel Foucault – è seguita da Rovelli con un occhio di riguardo per Franco Basaglia. Le sue ricostruzioni di storia della psichiatria sottolineano, e a diritto, come al momento dell’antipsichiatria e dell’approccio sistemico e sociale al disordine mentale sia seguita, negli ultimi decenni, una massiccia rimedicalizzazione del disturbo mentale. Prendi la tua pillola e taci, per chiosare un celebre motto sessantottino.
La critica è, in linea di principio, corretta e le intenzioni di Rovelli sono buone: smettere di pensare che la sofferenza psichica e il disturbo mentale si giochino tutti all’interno del cranio. L’idea che la mente sia qualcosa di trattenuto nelle ossa, o anche circondato dalla pelle, è obsoleta. Forse questa cosa la vide, e ne fece per la prima volta un caposaldo del suo pensiero, Hegel con il concetto di spirito. Si pensa anche tramite le istituzioni sociali, con le pratiche culturali e razionali che utilizziamo nella nostra vita quotidiana per dare senso, descrivere, giudicare quello che ci accade, quello che desideriamo fare, quello che ci aspettiamo dalle altre persone che ci circondano.
Ma si possono fare anche almeno due rilievi a margine. Il primo problema riguarda la prospettiva eziologica: il disordine mentale ha delle cause e queste cause non sono solo legate all’organismo individuale, ma anche alle relazioni organismo-ambiente così come ai rapporti intersoggettivi e alle costellazioni sociali.
Se il mio comportamento non è niente di più e niente di meno di un plesso di condizioni causali, allora non si vede perché criticarle.
Ogni comportamento umano ha delle cause – o, meglio, delle condizioni – fisiche, biologiche e sociali; dunque, per forza di cose, le ha anche il disturbo mentale. E però – e non mi riferisco qui alla contrapposizione di soggettivo e oggettivo, che è improduttiva in questo contesto – ogni comportamento umano, pur essendo anche il risultato di determinate condizioni, non può essere compreso soltanto come tale. Soprattutto, non può essere compreso solo come risultato di condizioni se vogliamo, in qualche modo, come a tratti fa Rovelli, approntare una critica alle sue condizioni stesse. Se il mio comportamento non è niente di più e niente di meno della stratificazione, sedimentazione, precipitazione di un plesso di condizioni causali, allora non si vede perché posso o devo criticarle: come non avrebbe alcun senso, per una pietra, criticare la gravità.
Piuttosto, i comportamenti umani hanno delle pretese, esprimono delle richieste e delle rivendicazioni normative rispetto alle proprie condizioni fattuali, e spesso lo fanno articolando delle ragioni. Alasdair MacIntyre, in L’inconscio. Un’analisi concettuale, pur criticando il pensiero di Sigmund Freud, gli riconosce un’intuizione fondamentale. Cioè di aver considerato il comportamento che la psichiatria indica come psicopatologico non come il risultato di processi causali – siano queste cause fisiologiche o sociali – ma come l’espressione, per quanto incastrata o enigmatica, della razionalità dell’individuo. Il discorso della follia non è una pietra da far cadere in questo o quel modo, ma è una richiesta, una pretesa, una domanda – che non si tratta tanto di eliminare, quanto di riconoscere come espressione della razionalità e della libertà umana.
Questo punto, che ha fatto più recentemente anche Axel Honneth in Patologie della ragione. Storia e attualità della teoria critica, è esemplificato nella Critica della ragion pura di Immanuel Kant.
[S]i esamini un’azione volontaria […]; si ricerchino prima di tutto le cause determinanti che le hanno dato origine, per poi giudicare se essa possa venirgli imputata, unitamente alle sue conseguenze. Il primo punto richiede che venga preso in esame l’intero carattere empirico dell’uomo fino alle sue sorgenti, che vanno ricercate nella cattiva educazione, nelle cattive compagnie, parzialmente anche nella malvagità di un naturale indifferente alla vergogna, e risalenti inoltre alla superficialità e alla dabbenaggine; e neppure vanno trascurate le concause occasionali. Il procedimento così impiegato è in generale lo stesso di quello a cui si fa ricorso nella ricerca delle serie delle cause determinanti di un effetto naturale.
Kant parla di colpa e di imputabilità morale e perciò, in un certo senso, la citazione sembrerebbe a prima vista ricalcare l’oggetto della critica di Rovelli. Ma proviamo a cambiare la riflessione di Kant di segno, ricordandoci di cosa parla: cioè del fatto che gli individui umani sono da considerare liberi, cioè non solo i risultati di un processo, ma centri di razionalità pratica. Posta in questi termini, la questione va a detrimento del punto di Rovelli, che rischia di prendere la complicazione dell’eziologia psicopatologica come un principio di rispetto della persona. Con Kant si può dire proprio l’opposto: un’eziologia semplice (i tuoi nervi non funzionano) non è molto diversa da un’eziologia complessa (cioè i tuoi rapporti intersoggettivi e la tua società non funzionano) almeno in un aspetto fondamentale. In entrambi i casi, l’individuo con un disturbo mentale non è innanzitutto una persona, capace di scegliere, capace di formulare richieste, di articolare critiche, di lamentarsi della sua condizione dovuta anche a costellazioni sociali. È piuttosto come una pietra che cade – certo, con molte leggi da considerare, non solo la gravità, ma anche l’economia, la biologia, la sociologia, ma pur sempre una pietra che cade.
Se vogliamo trattare da persona chi lamenta un disturbo mentale, forse è meglio ascoltare quello che ha da dirci sul suo malessere, perché può articolarsi una richiesta di cambiare le condizioni che lo causano.
Nessuna pietra si lamenterà mai di cadere. Ma se una persona si lamenta di soffrire, nel suo disturbo mentale, se vogliamo trattarla da persona e non da pietra, forse è meglio prenderla sul serio e ascoltare quello che ha da dirci sul suo malessere – non perché questo ha molte cause, ma perché può articolarsi come una richiesta di cambiare le condizioni che lo causano. Detto con le parole di Jacques Lacan, in Discorso sulla causalità psichica, proprio a criticare un concetto organicistico della follia: la follia non è un insulto alla libertà, ma la sua più fedele compagna, che ne segue le mosse come un’ombra. E in fondo questo è il punto su cui Freud non ha mai desistito: non tanto prendi la tua pillola e taci, quanto: magari prendi la tua pillola, però parla e di’ ciò che vuoi, c’è qualcosa da capire in quello che dici.
Il personalismo relazionale di Rovelli e le sue buone intenzioni rischiano di presupporre che un’eziologia complessa abbia più riguardo della persona di un’eziologia semplice. Il secondo rilievo che si può fare al libro è in rapporto a questo, ma diverso. Riguarda la critica all’individualismo. Ora, la critica all’individualismo è forse uno dei luoghi più amati della critica culturale della società contemporanea: le istituzioni culturali dell’Occidente globalizzato, prepotentemente informate dal sistema di produzione post-fordista, si caratterizzerebbero per fare dell’individuo il termine ultimo della vita in comune anziché, come vuole Rovelli, i rapporti sociali fra gli individui organizzati nel senso di un’etica della cura delle persone le une per le altre. Naturalmente, una società di individui egoisti è tanto poco un ideale sensato su cui puntare quanto, credo, una descrizione appropriata della vita collettiva. Personalmente nutro molti dubbi sull’idea che ci siano individui ultimativamente egoisti: si tratta al più di una finzione letteraria o di un esperimento mentale.
Ma la critica all’individualismo, o all’idea che l’individuo e l’individualità siano qualcosa di importante, se non di addirittura fondamentale, è controproducente proprio a elaborare una critica del rapporto fra disturbo psichico e istituzioni sociali. In effetti, già nel testo di Rovelli si rileva una tensione interessante. Da una parte troviamo la problematizzazione dell’individualismo. Dall’altra, e a diritto, c’è la simmetrica disapprovazione di un approccio al malessere mentale che si riduce all’analisi statistica (sia del sintomo psicopatologico, ridotto a una casella diagnostica da medicare, sia dei grossi numeri che i sistemi sanitari si ritrovano a governare) come unico criterio della gestione politica e istituzionale del malessere mentale stesso. Ora, questa seconda critica si giustifica soltanto alla luce di un assunto: cioè che il disordine mentale è caratterizzato da qualcosa di profondamente individuale cui si tratta di rendere giustizia, tanto nella diagnosi quanto nella terapia. Questa idea, in effetti, si ritrova in quella che a grandissime linee si potrebbe chiamare la comprensione psicoanalitica del sintomo psicopatologico: non uno scompenso organico né tantomeno la precipitazione, nel senso chimico, di disfunzioni sociali e intersoggettive che per caso si manifestano in questo o in quell’altro individuo, ultimo anello di una catena di sfortune. Piuttosto, il sintomo si può comprendere, prendendo a grandi linee dalla riflessione ancora una volta di Lacan, come la risposta o soluzione singolare a un problema, una domanda, un disagio che investono innanzitutto il singolo. Una risposta che può esprimersi in modo cifrato, corporeo, doloroso; e che nondimeno si esprime.
Questo non significa eliminare la dimensione sociale, facendo dell’individuo l’unico fautore dei suoi problemi. Significa, al contrario, trattare una persona con un disturbo mentale, banalmente, come una persona: considerare cioè i suoi atti e i suoi comportamenti non come il risultato di processi, ma come la risposta a questi processi. Significa riconoscere all’individuo che il suo disagio è un’espressione della sua capacità di agire, di muovere richieste, di articolare desideri, seppure in un modo confuso. Una razionalità pratica contratta ed enigmatica, ma non per questo meno razionale: non una pietra che cade, appunto, ma una persona.
Il disordine mentale è caratterizzato da qualcosa di profondamente individuale cui si tratta di rendere giustizia, tanto nella diagnosi quanto nella terapia.
Ora, ammettere che il disordine mentale è un’espressione singolare della razionalità pratica di un individuo mette il mondo pubblico e condiviso in una posizione problematica – oltre naturalmente a ridimensionare la critica un po’ generalista che Rovelli muove alla cultura individualista (al contrario, si dovrebbe dire con l’Oscar Wilde de L’anima dell’uomo sotto il socialismo che non c’è niente di più contrario all’individualismo della proprietà privata e del sistema di produzione che la pone a proprio fondamento).
Un punto che ha visto, almeno in parte, Emmanuel Renault nel suo L’expérience de l’injustice. Essai sur la theorie de la reconnaissance. Nel confronto con il disturbo psichico – una volta che smettiamo di considerarlo una malattia e un mero risultato o precipitazione – il mondo sociale si trova a che fare con un punto enigmatico: un’articolazione che non si risolve nelle pratiche e norme condivise, discorsive e non, che in genere gli individui di una società adoperano per manifestare il loro dissenso, per rispondere ai problemi che si trovano a fronteggiare. La medicalizzazione – e, da questo punto di vista, anche la cura, se il concetto non viene specificato ulteriormente – rinchiudono queste pretese nella gabbia di un puro effetto, non di una richiesta o di una risposta. Ammettere al contrario che, pure in modo cifrato, talvolta al limitare dell’incomprensibilità, anche il disturbo mentale è un comportamento umano, come tale carico di una sua razionalità pratica, significa che le pratiche e le norme che una società utilizza per stabilizzare e sanzionare ciò che vale come razionale e come non razionale sono potenzialmente da rivedere, da cambiare.
Questa è forse, in effetti, e qui concludo, proprio la grande intuizione di Freud. Mentre Kant, almeno nella citazione più in alto, vede solo nell’azione volontaria l’espressione di una razionalità, forse perché ancora indebitato a una filosofia della coscienza e dell’autocoscienza soggettive e cognitive, Freud rileva che anche alcune azioni involontarie – i disturbi mentali – esprimono non tanto una causalità naturale o sociale, quanto appunto pretese di razionalità. Pretese che sono espresse al modo dell’enigma e del disagio o della sofferenza ma che anche, proprio in quanto tali, richiedono che il mondo cambi, perché questa sofferenza sia ammorbidita e questa richiesta accolta. Non tanto, perciò, “soffro dunque siamo,” ma soffro e lasciami parlare. E se non capisci la mia parola forse è perché è proprio la tua parola che è ora che cambi.