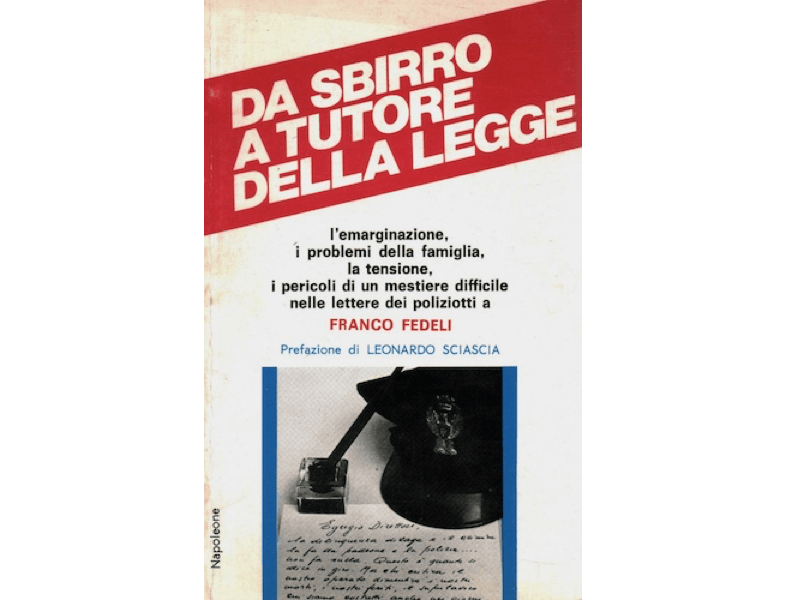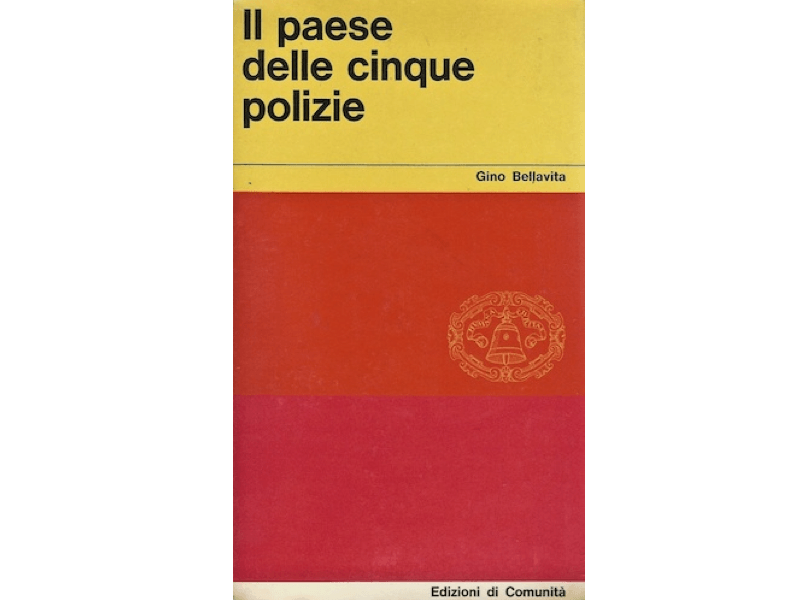N el corso dell’anno passato cinquantotto operatori dei vari corpi di polizia si sono tolti la vita. Nei cinque anni precedenti, tra il 2014 e il 2018, i suicidi sono stati 180. 238 morti in sei anni: Polizia di Stato (74), Arma dei carabinieri (55), Guardia di Finanza (29), Polizia Penitenziaria (40) e polizie locali (40). La drammatica contabilità di questo male oscuro che attraversa le polizie del Paese proviene dall’attento – e necessario – lavoro dell’Osservatorio Nazionale dei Suicidi nelle Forze dell’Ordine dell’associazione Cerchio Blu. Indagare la natura di questo fenomeno risulta tuttavia piuttosto difficile e complesso ed è probabile che alla base della tragica scelta spesso vi sia la somma di più fattori, personali e lavorativi, anche se il logorio professionale, che non è trattato e combattuto in maniera adeguata, resta tra le cause determinanti.
In altri paesi europei, come la Francia, la situazione appare ancora più grave, forse anche a causa delle tensioni sociali fortissime di questi ultimi due anni. Tanto che il 2 ottobre 2019 i sindacati di polizia francesi hanno organizzato a Parigi una marche de la colère – a cui hanno preso parte ventisettemila persone – per denunciare il silenzio pubblico sulla questione dei suicidi tra gli agenti e soprattutto la mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni.
Tornando al contesto italiano, i sindacati di polizia hanno sottolineato spesso l’assenza di un’azione concreta per combattere le cause di disagio e di stress. Tuttavia da parte del mondo politico, più che rispondere in maniera fattiva alle questioni urgenti si è preferito, specialmente a destra (ma non solo), indugiare su una retorica law and order, da sceriffi, reclamando leggi più dure, stipendi più alti e maggiore libertà nell’uso delle armi, e ricorrendo – per influenzare il dibattito pubblico e per corroborare richieste da Far West – a immagini lontane di poliziotti poveri e sfruttati, vittime di una collettività ingrata. Eppure, se paragonate al passato, le condizioni di vita attuali degli agenti appaiono molto più confortevoli.
Ma per comprendere meglio alcuni dei problemi di oggi, è bene fare un salto indietro proprio a quel passato, alle immagini e alle vite di quei poliziotti emarginati. All’inizio degli anni Sessanta, i miglioramenti portati dal boom economico nella società italiana avevano reso più evidenti (e anacronistiche) le cattive condizioni di vita dei lavoratori in divisa impiegati nei diversi corpi separati dello Stato; la situazione peggiore si riscontrava forse all’interno della polizia. Una parte cospicua della PS era composta da uomini mal pagati e sfruttati, privi di molti diritti civili e di qualsiasi tutela di tipo sindacale, sottoposti a una rigida disciplina militare e obbligati al celibato fino ai trent’anni (il limite scese poi a ventotto anni nel 1966 e a ventisei nel 1973).
La politica ricorre a immagini lontane di poliziotti sfruttati per corroborare richieste da
Far West.
Molti degli arruolati erano giovani di circa diciannove anni e provenivano dai contesti sociali più disagiati del Paese, in maggioranza originari del Mezzogiorno. Alle cattive condizioni economiche e di vita – le caserme in cui erano costretti a vivere i poliziotti versavano in condizioni pessime e il vitto era spesso scadente – si aggiungevano spesso gravi difficoltà lavorative. Difficoltà prodotte da un’istituzione che, per disinteresse o noluntas da parte politica, faceva fatica a rinnovarsi, a competere con i mutamenti repentini del panorama criminale, e ad assicurare al personale una formazione adeguata, oltre che i mezzi necessari allo svolgimento del servizio. In aggiunta a ciò, vigeva la cattiva consuetudine di impiegare una parte del personale – a cui veniva attribuito l’epiteto “sciacquini” – in maniera impropria e irregolare, in servizi e lavori di ogni tipo (cuoco, maggiordomo, giardiniere, bambinaio, muratore) che si svolgevano durante l’orario di servizio presso le abitazioni private di alti funzionari e ufficiali del corpo. Relegati in questa condizione di sfruttamento e separatezza, i poliziotti si trovavano spesso a guardare, senza potervi prendere parte, le novità e i progressi di un Paese attraversato da una profonda trasformazione e da importanti mutamenti sociali e ideali. Nei momenti di libera uscita fuori dalle anguste camerate, lontani dai loro luoghi di origine, gli agenti trascorrevano le poche ore di pausa in prossimità della caserma, per non correre il rischio di perdersi o di rientrare fuori orario, e incorrere in tal modo in provvedimenti punitivi. Ciò accadeva soprattutto ai più giovani, a quelli meno avvezzi al contatto con i grossi centri, che scontavano il forte disadattamento generato dalla nuova dimensione urbana. Nelle ore libere alcuni di essi pagavano caro l’isolamento sociale, dilapidando i compensi già risicati con le prostitute e con i venditori (di tutti i generi possibili) che pullulavano e prosperavano in prossimità delle caserme.
In parallelo, a causa della precisa e collaudata strategia governativa di gestire l’ordine pubblico e le emergenze sociali in maniera dura e conflittuale (già attuata e con conseguenze gravissime sin dall’immediato dopoguerra), a partire dalla contestazione studentesca del 1968 – che pure fu fronteggiata con una cautela maggiore – il personale di PS conobbe un impiego costante e massiccio nelle piazze del Paese che coinvolse non soltanto i reparti mobili e celeri destinati a quei servizi, ma anche gli allievi delle scuole di polizia e gli agenti destinati ad altri servizi. Un lavoro incessante, che si sarebbe protratto per molti anni e che aggravò le difficoltà e gli affanni degli uomini, imponendo rischiosi straordinari quotidiani privi di un qualsiasi corrispettivo economico. I poliziotti si trovarono così ad essere sacrificati su due fronti: da un lato furono esclusi dai benefici che a partire dalla fine degli anni Sessanta, con l’approvazione dello statuto dei lavoratori, riguardarono una gran parte del mondo del lavoro; dall’altro furono utilizzati in maniera costante e pervasiva dai governi, prima per arginare e respingere le istanze di cambiamento provenienti dalla società, poi per tamponare, alla meno peggio, le emergenze criminali e il terrorismo.
Per questi motivi, tra la contestazione del ‘68 e l’autunno caldo del 1969 molti dei nodi mai sciolti, che la Pubblica Sicurezza si portava dietro sin dal dopoguerra, iniziarono a venire al pettine. Vale la pena ricordare il primo episodio che segnalò in maniera eclatante all’opinione pubblica l’esistenza di un forte malcontento nel corpo: la rivolta nelle caserme scoppiata dopo la morte della guardia di PS Antonio Annarumma (avvenuta a Milano il 19 novembre 1969 nel corso di violenti scontri di piazza seguiti allo sciopero generale per la casa indetto da Cgil, Cisl e Uil). Il poliziotto ventiduenne, originario di una famiglia di braccianti di Monteforte Irpino, morì per una profonda ferita alla testa mentre era alla guida di uno dei gipponi che caricavano i manifestanti. La versione ufficiale attribuì la morte dell’agente ad un tubo di ferro lanciato dai manifestanti, un’altra versione riconduceva la morte dell’agente allo scontro, che in effetti avvenne, del suo gippone con un altro mezzo. La vicenda, che anticipò e annunciò il clima della strategia della tensione (la strage di piazza Fontana avvenne solo poco più di venti giorni dopo), fu sfruttata dalle destre e dalla parte più conservatrice del Paese, interessata a contrastare il successo dello sciopero generale unitario del 19 novembre e a reprimere i fermenti che attraversavano il mondo del lavoro. Ma la triste vicenda di Annarumma causò anche una rivolta di proporzioni mai viste nei reparti mobili di Milano, Torino e Roma. Non si trattò di un episodio contenuto, come alcune narrazioni istituzionali hanno affermato, ma di un ammutinamento, una rivolta mossa dalla rabbia e dall’esasperazione, rinfocolata da voci infondate, che gli ufficiali a stento riuscirono a contenere all’interno delle caserme (subendo insulti, sputi e violente aggressioni). Questa storia è stata ricostruita di recente, e con dovizia di particolari, in un volume (Il caso Annarumma. La rivolta delle caserme e l’inizio della strategia della tensione) scritto dal giornalista Cesare Vanzella.
Immersi nel clima sociale degli anni Settanta, i poliziotti furono contagiati dal clima di contestazione e coinvolti in un processo di cambiamento.
Sottoposti a queste brusche e continue sollecitazioni, immersi nel clima sociale degli anni Settanta, i poliziotti non rimasero sordi e immobili ma furono a loro volta “contagiati” dal clima di contestazione del periodo e coinvolti in un processo di cambiamento, dapprima in maniera sporadica, disorganizzata (talvolta reazionaria, come avvenne dopo la morte di Annarumma) e in un secondo momento in una forma organizzata, attraverso una struttura clandestina – un movimento – che dopo anni di battaglie condusse il corpo alla smilitarizzazione e alla riforma. Fu in questo frangente che molti dei problemi del corpo emersero con forza e riuscirono a imporsi all’attenzione della società, superando la separazione creata dall’asfittica cappa della disciplina militare. Un ruolo importante nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica fu svolto dagli stessi agenti, che provarono a raccontare la loro esistenza nella Pubblica Sicurezza attraverso una pioggia di lettere spedite dapprima alle riviste professionali, poi anche ai quotidiani e ai settimanali.
Ordine Pubblico, il giornale che fu il punto di riferimento del movimento clandestino per la smilitarizzazione e il sindacato sorto nella Pubblica Sicurezza, e il suo direttore Franco Fedeli (un giornalista di sinistra, con un passato nelle file della Resistenza, legato all’esperienza di “Giustizia e Libertà” e del Partito d’Azione), ricevettero ogni mese, a partire dalla fine degli anni Sessanta, centinaia di lettere di poliziotti. Oltre a denunciare ingiustizie, distorsioni, abusi e irregolarità di ogni genere, gli agenti contribuirono in tal modo alla costruzione di un impressionante racconto collettivo della condizione di sfruttamento in cui erano costretti a vivere.
“Siamo stufi di questa vita”, scrissero alcune guardie a “Ordine Pubblico” nel 1974, “non crediamo a quello che ci dicono i nostri ufficiali. Siamo degli sfruttati come gli operai che i nostri superiori vorrebbero che bastonassimo quando fanno sciopero. Ma la maggioranza di noi, escluso qualche fascista, non vuole andare contro gli operai perché essi si battono pure per i contadini del Meridione, per i nostri compaesani emigrati all’estero e anche per noi. Sì, anche per noi. Siamo entrati nella polizia perché eravamo senza lavoro, ma credevamo che il nostro compito fosse quello di catturare i delinquenti e non quello di colpire i lavoratori”.
Alcune lettere come questa furono poi raccolte da Franco Fedeli e pubblicate nel 1981 (anno della riforma, della smilitarizzazione della Pubblica Sicurezza e della nascita della Polizia di Stato) nella raccolta Da sbirro a tutore della legge. In una pungente prefazione al volume, Leonardo Sciascia non mancò di sottolineare la responsabilità pesante che la borghesia italiana aveva avuto nell’isolamento del personale di polizia e nelle distorsioni della stessa istituzione: “sono stati i buoni cittadini a fare le cattive polizie, più o meno consapevolmente operando come Bernard Shaw diceva facessero i bianchi nei riguardi dei negri: prima li costringono a fare i lustrascarpe, poi dicono che sono soltanto capaci di fare i lustrascarpe”.
Oltre che a Sciascia, l’eco della protesta dei poliziotti giunse, sin dall’inizio degli anni Settanta, alle orecchie di alcuni degli osservatori più sensibili della società italiana, che scrissero a più riprese delle condizioni di sfruttamento esistenti nei corpi separati dello Stato. Stefano Rodotà fu tra i più attivi, pubblicando pagine lucidissime su Panorama. Ma fu Pier Paolo Pasolini a cogliere, forse tra i primi, molti dei sottili meccanismi di sfruttamento che si muovevano sulla pelle dei poliziotti. I passaggi più significativi da lui scritti su questo tema non sono quelli – troppe volte citati a sproposito in tempi recenti e passati – della famosa poesia del 1968, Il Pci ai giovani (“Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti, / io simpatizzavo coi poliziotti”) ma alcune riflessioni (contenute in due articoli successivi: Per una polizia democratica e Soggetto per un film su una guardia di PS) su come l’istituzione fosse capace di sfruttare e (de)formare a suo vantaggio alcune delle caratteristiche principali di molte giovani reclute meridionali: la povertà materiale, l’ignoranza e soprattutto l’educazione all’obbedienza.
Le precarie condizioni di vita e di lavoro degli agenti ebbero talvolta effetti tragici che – rimbalzando nelle cronache – contribuirono a rafforzare nell’opinione pubblica l’immagine del poliziotto sfruttato. Il 21 novembre 1975 Sante Di Ruzza, un anziano appuntato di PS appena pensionato, si uccise gettandosi dalla finestra della questura centrale di Roma, in via San Vitale, perché non riusciva a sopravvivere e a mantenere la famiglia. Come scrisse Ennio Di Francesco nella sua autobiografia (Un commissario), “nel rivolo di sangue che gli usciva dalla bocca c’era tutta la storia di una vita sfruttata. Quarant’anni di lavoro per una pensione da fame”. Altrettanto duro fu il commento dei poliziotti che si battevano per la riforma del corpo: “Il suicidio dell’appuntato Sante Di Ruzza è una morte per cause di servizio. Al termine di una vita professionale di sacrifici, di mortificazioni e di sfruttamento non si ha neppure il diritto di trascorrere umanamente gli ultimi anni”.
Un altro tema ricorrente nella storia delle polizie italiane che fa parte integrante del meccanismo di sfruttamento del passato è l’assenza di una protezione sindacale.
Pur essendo anacronistiche, le condizioni di vita che abbiamo descritto non furono un fenomeno peculiare degli anni Settanta o della storia della Repubblica, ma la manifestazione contemporanea di un male antico, di un problema originario mai risolto e mai affrontato. Immagini di sfruttamento e sofferenza molto simili a quelle che abbiamo descritto si ritrovano infatti, senza troppe differenze, andando a rileggere i giornali riservati alle polizie dell’Italia liberale. Nel 1879 la più nota e longeva pubblicazione a stampa riservata ai funzionari di PS di quel tempo, parlava in questi termini delle guardie di pubblica sicurezza e della loro esistenza:
[un] uomo che non ha moglie, che non ha figli, che non ha famiglia, non ha casa, non sarà mai simpatico al pubblico, non conseguirà mai ciò che gli inglesi chiamano rispettabilità. Non avendo vincoli né interessi comuni colla società in mezzo alla quale deve vivere, sarà sempre un mercenario soldato di ventura. Circondato spesso da una popolazione ostile, fra la quale non ha parenti, né amici, senza una voce che lo consoli, sarà sulle prime oppresso dalla nostalgia, poi cercherà nelle bettole una distrazione dove affogare le sue amarezze e finirà per odiare la società che gli domanda il sacrificio della vita e lo ricambia con l’isolamento, e fors’anco col disprezzo.
Anche in molti altri interventi dello stesso periodo storico si rintracciano analoghe testimonianze delle enormi difficoltà – economiche, lavorative ed esistenziali – che accompagnarono senza interruzioni la vita delle polizie dell’Italia postunitaria e che si sarebbero protratte fino alla fine degli anni Settanta.
Esiste un altro tema ricorrente nella storia delle polizie italiane su cui vale la pena soffermarsi, un elemento che fa parte integrante del meccanismo di sfruttamento che abbiamo raccontato: l’assenza di una protezione sindacale. Nella polizia italiana agli inizi del Novecento era già sentita l’esigenza di un’associazione di mutuo soccorso, di un organismo che difendesse gli interessi dei poliziotti. Nello stesso periodo in molti paesi d’Europa (ma anche nel resto del mondo) furono costituite associazioni sindacali collegate talvolta alle organizzazioni degli altri lavoratori. In alcuni paesi la battaglia degli agenti per il sindacato sfociò anche in aspri conflitti con le autorità politiche. Il 15 agosto 1919, ad esempio, i poliziotti di Boston decisero a larga maggioranza (oltre l’ottanta per cento) di costituire un sindacato collegato all’American Federation of Labour e il mese successivo, in risposta ai provvedimenti punitivi che le autorità avevano preso per arginare quell’iniziativa, proclamarono uno sciopero a oltranza che durò diversi giorni, a cui aderì gran parte del personale, e che seppur infruttuoso e controproducente rimase nella memoria collettiva come il Boston police strike.
In Italia nulla di ciò accadde e il malcontento del personale, pur manifestandosi più volte, soprattutto nel decennio che precedette la prima guerra mondiale, non portò a forme di protesta più strutturate. I fermenti che attraversarono la pubblica sicurezza rimasero inascoltati e si spensero con l’avvento del fascismo. Bisognerà attendere gli anni Settanta e il movimento clandestino sorto nella Pubblica Sicurezza per tornare a sentir parlare in maniera concreta di sindacati.
Nell’Italia di oggi, l’immagine che abbiamo sin qui tratteggiato, con tutte le sue implicazioni e le sue conseguenze, appartiene in gran parte alla storia e non è adatta a descrivere la condizione attuale delle polizie, che è cambiata ed è molto migliore rispetto al passato. Certo, le polizie del Paese non sono immuni da problemi e difficoltà. Per esempio, un’istituzione come la Polizia di Stato o come l’Arma dei carabinieri che affronta questioni delicate e complesse, per essere definita affidabile e credibile, dovrebbe essere in grado di fornire risposte, garantire chiarezza e saper giustificare le proprie scelte. Questo non sempre è avvenuto e non sempre avviene e ciò non giova in nessun modo a proteggere o a migliorare le condizioni di lavoro degli agenti.
I poliziotti di oggi non sono né sfruttati né sottopagati, e chi afferma il contrario lo fa per propaganda elettorale.
Inoltre, come avveniva nel passato, l’assenza nel dibattito pubblico – al netto degli slogan celebrativi e delle prese di posizione faziose di certi partiti politici – di una seria analisi dei problemi del comparto sicurezza non aiuta le istituzioni e gli operatori a migliorarsi, non facilita il necessario dialogo tra i cittadini e gli agenti, e soprattutto crea isolamento, favorisce chiusure corporative e abbandona a sé stessa la parte più aperta e progressista delle istituzioni, una componente che vive e sopravvive anche grazie al dialogo con la società.
Nella carenza generale di informazione e dibattito sulle forze dell’ordine, alcune analisi proposte di recente e amplificate con eccessiva enfasi dai media rischiano di essere fuorvianti. È il caso di un articolo diffuso e accreditato da La Repubblica e da Il Manifesto, in cui si afferma che in Italia le polizie hanno un organico e un costo superiore a molti paesi europei. In primo luogo, questa “scoperta”, non è certo una novità: si tratta di un problema segnalato più volte per oltre cinquanta anni in quasi tutta la saggistica che si è occupata di polizie, dalla prima seminale inchiesta di Gino Bellavita – Il paese delle cinque polizie – fino ai più recenti studi, scientifici e non, sul comparto sicurezza di questo paese.
Inoltre, bisogna rilevare che non è metodologicamente corretto sviluppare e proporre un’analisi comparata tra Paesi diversi, guardando solo alla spesa e alle dimensioni numeriche dei singoli comparti nazionali, senza prima analizzare quali mansioni esplicano le diverse istituzioni. Per fare un esempio: in Italia le polizie svolgono servizi amministrativi, come il rilascio dei passaporti, che altrove, prendiamo il caso della Germania, non sono gestiti da personale in divisa, ma dagli uffici comunali. Nel contesto italiano, quando si analizza il lavoro delle polizie si resta impressionati dalla pluralità di mansioni attribuite e dai carichi burocratici ad esse connessi, si pensi, per fare un altro esempio, al rilascio dei permessi di soggiorno. Per far fronte a questi compiti, al di là della effettiva necessità di gestire certi problemi con personale di polizia (su cui si può e si deve senz’altro discutere), le istituzioni hanno degli organici stabiliti per legge che non possono essere tagliati a caso, guardando solo alle esigenze di bilancio. Quando si verifica un grave deficit di personale, come avviene al momento attuale nella Polizia di Stato, i disservizi sono inevitabili, sia per gli operatori, costretti a straordinari eccessivi, sia per la collettività.
Anche la pluralità dei corpi di polizia e la loro problematica sovrapposizione, deplorata da molti addetti ai lavori sin dall’Ottocento, andrebbe risolta dopo un’accurata attività di analisi e di studio, assicurando con una riforma (e non con dei tagli orizzontali) l’effettivo ed efficace coordinamento tra le diverse forze, visto che il sogno di un corpo unico sembra ormai da tempo tramontato. Sarebbero da evitare inoltre, quando possibile, operazioni di dubbia efficacia, come il recente – e sciagurato – accorpamento del personale del Corpo Forestale all’Arma dei carabinieri, un rimedio peggiore del male.
Rispetto al passato remoto di cui abbiamo parlato, ma anche rispetto ai più recenti anni Sessanta e Settanta, oggi oltre ad essere molto migliorata la condizione degli agenti, sia a livello professionale e retributivo sia a livello esistenziale, sono molto cambiati anche la società e il mercato del lavoro, per tanti aspetti non in meglio. Se nel 1969 il mestiere di poliziotto rappresentava un ripiego, un lavoro duro e rischioso a cui ambivano in gran parte persone provenienti da ceti sociali bassi e disagiati, ora, nell’epoca del ritorno al cottimo (anche se camuffato con attraenti anglicismi come riders), i lavoratori delle polizie sono abbastanza tutelati e hanno accesso a una retribuzione equa e a una serie di agevolazioni e benefici, anche grazie a una pletora di sindacati di categoria piuttosto agguerriti e sui metodi dei quali, eccezion fatta per alcune sigle, si potrebbe discutere molto.
I poliziotti di oggi dunque non sono né sfruttati né sottopagati, e chi afferma il contrario lo fa per propaganda elettorale. Gli appartenenti ai corpi di polizia svolgono una professione che, pur presentando senza dubbio problemi e rischi, anche gravissimi, rappresenta un’opportunità, un’occasione di pieno inserimento sociale ed economico. Nell’Italia contemporanea, per dei giovani diplomati (come sono molti tra i nuovi agenti) è piuttosto difficile trovare un impiego che garantisca una retribuzione, una preparazione professionale e, per quelli che sanno percepirlo, un ruolo sociale anche solo paragonabile a quello del poliziotto.
In una società dove i diritti dei lavoratori sono in forte contrazione, il complesso mestiere di poliziotto offre possibilità e sicurezze sconosciute a molte categorie.
Nella nostra epoca assistiamo infatti a un fenomeno opposto rispetto a quello che si era verificato negli anni Settanta: nel corso del tempo le prerogative e le tutele acquisite dai poliziotti sono state tutto sommato difese e mantenute, mentre il resto del mondo del lavoro – al contrario – ha subito un impoverimento progressivo e una perdita di tutela costante. In una società dove i diritti dei lavoratori sono in forte contrazione, dove i “lavoretti” sono diventati un fenomeno di massa spaventoso chiamato gig economy, il complesso mestiere di poliziotto offre possibilità e sicurezze sconosciute a molte categorie ed è per questo motivo, in qualche modo, un’occupazione privilegiata.
Tuttavia bisogna anche aggiungere che, oggi come in passato, la migliore o peggiore qualità di vita del personale delle polizie dipende anche dal modo in cui è impiegato. La strada percorsa sin dall’unità d’Italia, senza cesure troppo significative fino alla riforma del 1981 (e a volte anche dopo), è di tipo conflittuale ed è il frutto di una precisa scelta politica: quella di tamponare le emergenze e le questioni sociali irrisolte – immigrazione, conflitti di lavoro, urgenze abitative, accattonaggio, commercio abusivo, prostituzione – utilizzando le polizie come un “ammortizzatore sociale”, uno strumento per attutire e cronicizzare problemi la cui soluzione appare complessa e non foriera di benefici elettorali. Un approccio negativo che non giova né alla collettività, che attende sine die soluzioni organizzate e concrete, né alle istituzioni, costrette a fare spesso i conti con i danni di immagine che derivano da questo impiego non ortodosso, né agli operatori che in quelle istituzioni lavorano, che vedono svilire quotidianamente la loro professionalità e il loro mestiere.