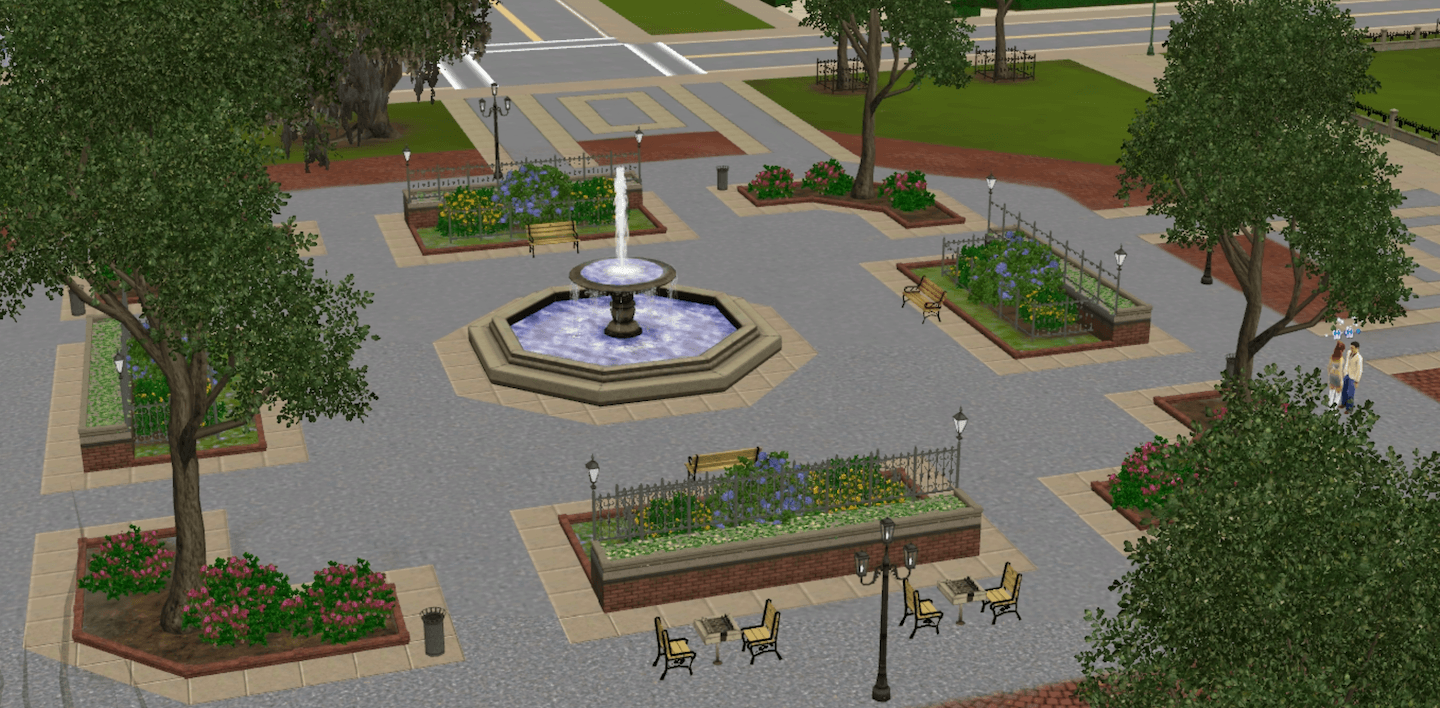
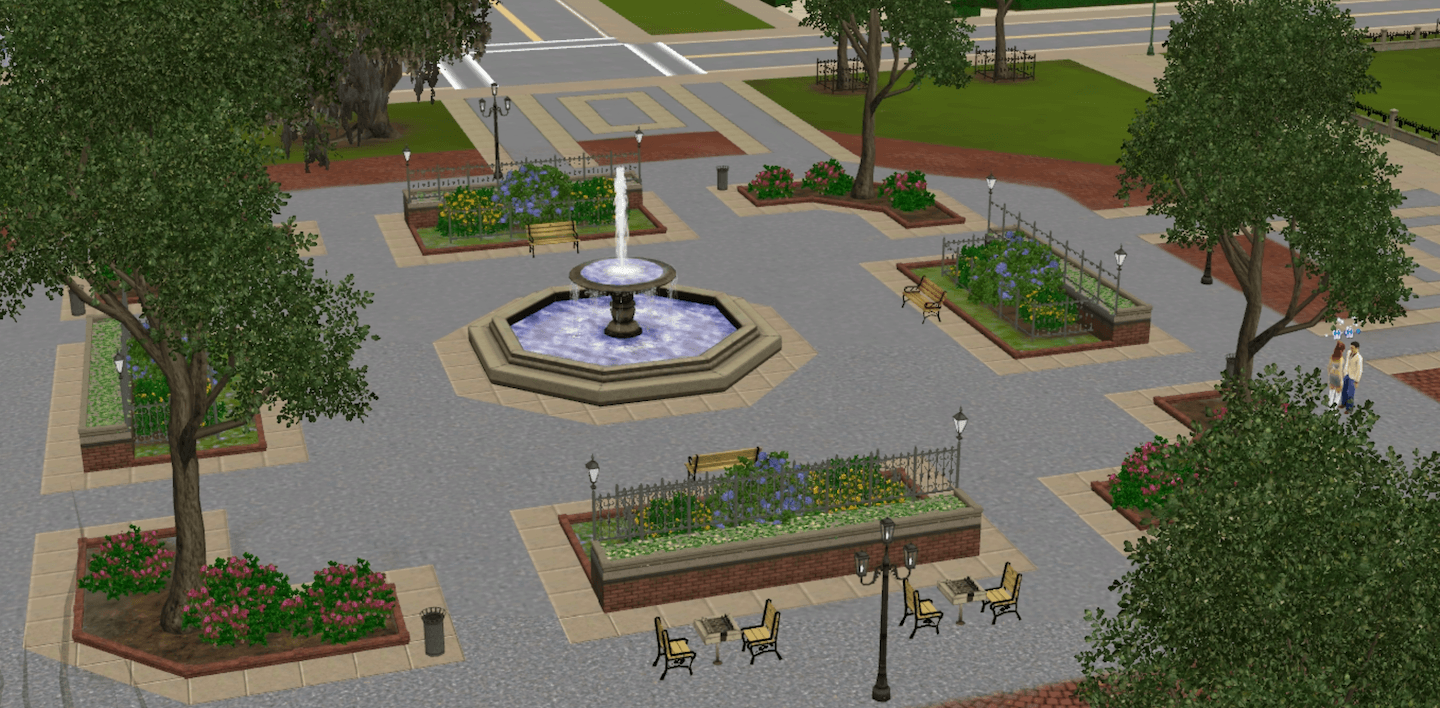
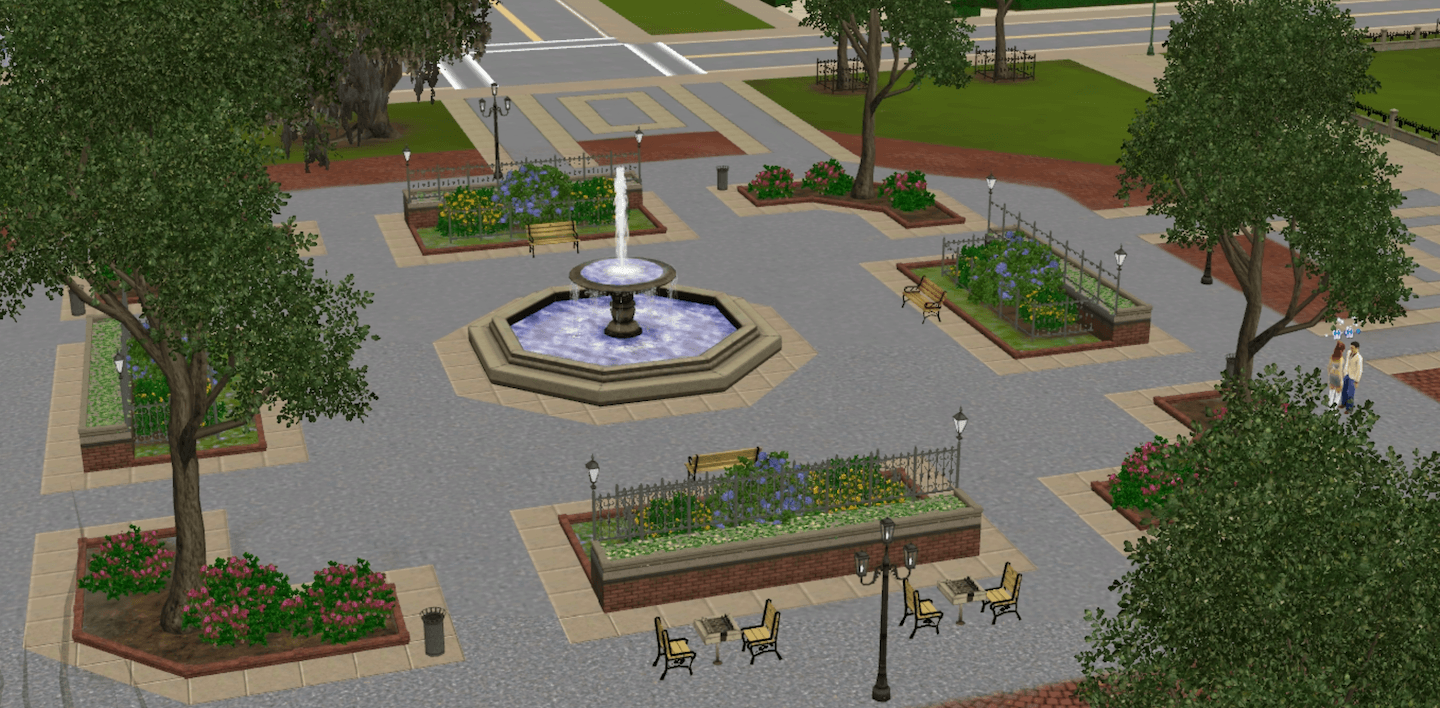
A fine aprile, parlando dei motivi che lo stavano spingendo a comprare Twitter, Elon Musk in un TED Talk diceva che la piattaforma “è diventata di fatto la piazza cittadina”. Nel marzo del 2019, Mark Zuckerberg aveva usato la stessa immagine quando affermava che “negli ultimi 15 anni, Facebook e Instagram hanno aiutato le persone a connettersi con amici, comunità e interessi nell’equivalente digitale di una piazza cittadina”.
Condivisa da leader del settore tecnologico e accademici, politici e opinionisti, la metafora secondo cui un angolo o l’altro del web svolgerebbe la stessa funzione di una piazza pubblica viene reiterata da anni – al punto che si è fatta strada fin nella Corte suprema statunitense, con la sentenza Peckingham v. North Carolina.
In quel caso, lo stato del North Carolina aveva provato ad impedire a un uomo che era andato in galera per pedofilia di usare Facebook una volta uscito dal carcere. Dopo diverse discussioni, nel 2017 la Corte suprema aveva però dichiarato che “vietare a chi è stato condannato per reati sessuali l’uso di certi siti web impediva l’accesso a quella che per oggi è per molti la principale fonte per conoscere l’attualità, controllare annunci di lavoro, parlare ed ascoltare ciò che viene detto nella moderna piazza pubblica, ed esplorare in generale i vasti regni del pensiero e della conoscenza umana”. “Se in passato poteva esserci stata difficoltà nell’individuare i luoghi più importanti (in senso spaziale) per lo scambio di opinioni, oggi la risposta è chiara. È il cyberspazio, i vasti forum democratici di Internet in generale e i social media in particolare”, aveva scritto il giudice Anthony Kennedy nell’opinione condivisa dalla maggioranza.
All’interno della giurisprudenza statunitense sul primo emendamento, che garantisce e regola la libertà d’espressione, la dichiarazione non era priva di peso, ma si inseriva all’interno di un atto di interpretazione dei nuovi spazi digitali e delle discussioni che avvengono al loro interno su cui non è ancora stata trovata una quadra. Per intenderci, solo tre anni prima, nel 2014, nella sentenza McCullen v. Coakley la stessa Corte aveva tracciato una netta differenza tra spazi pubblici fisici e virtuali, affermando che strade pubbliche e marciapiedi “ancora oggi rimangono uno dei pochi posti in cui un oratore può essere sicuro di non predicare soltanto ai convertiti. Un individuo messo di fronte a un messaggio scomodo su un altro mezzo di comunicazione può sempre voltare pagina, cambiare canale o lasciare il sito web”. Più che piazze, allora, la Corte in quel caso indicava che gli spazi digitali fossero assimilabili a mezzi come la televisione, la radio o i giornali.
La metafora secondo cui un angolo o l’altro del web svolgerebbe la stessa funzione di una piazza pubblica viene reiterata da anni.
Se a livello giuridico la questione non è ancora risolta, la diffusione della metafora che vede i social network come grandi piazze pubbliche contemporanee ha di per sé delle conseguenze. Come scrive la studiosa di diritto Mary Anne Franks per il Yale Law Journal, “l’immagine di una piazza pubblica digitale enfatizza principalmente il principio di apertura a tutte le persone e a tutte le idee. Di conseguenza, chi aderisce alla metafora della piazza pubblica digitale tende a considerare ogni restrizione e norma nei forum online come antidemocratica e censoria. (…) Il concetto viene invocato per criticare forum ritenuti non abbastanza aperti, soprattutto quelli che tentano di affrontare la disinformazione online, gli abusi e le violazioni dei loro termini di servizio”. Esempio perfetto di questa interpretazione è il discorso di aprile di Musk, che dopo aver chiamato Twitter la piazza cittadina globale ha aggiunto, come se fosse l’unica conseguenza naturale, che questo significava che gli utenti dovevano essere messi nelle condizioni di poter parlare liberamente di quello che volevano, entro i limiti della legge – anche a costo di stralciare anni di tentativi di rendere la piattaforma meno tossica e violenta per donne e minoranze e in generale più civile.
Quel che sostiene allora Franks è che la metafora della piazza pubblica digitale sia totalmente inutile, e addirittura controproducente, se ciò che si vuole ottenere sono spazi digitali che favoriscano dibattiti e discorsi politici fruttuosi per una serie di ragioni. La prima, evidente, è che le piattaforme su cui passiamo le nostre giornate lucrano sul fatto che più gente possibile le percepisca come spazi vitali per comunicare e scambiare idee, ma sono progettate per servire interessi aziendali, non pubblici.
La seconda è che, di per sé, le piazze pubbliche hanno storicamente accolto soltanto un tipo molto specifico di voce. “Sebbene sia innegabile che le piazze pubbliche abbiano funzionato a intermittenza come potenti luoghi di resistenza – attraverso proteste contro pratiche economiche e lavorative sleali, marce per i diritti civili e manifestazioni per l’uguaglianza di genere – la piazza pubblica non è mai stata veramente pubblica: leggi e norme hanno sempre servito i potenti a spese dei vulnerabili. In effetti, le piazze pubbliche sono sempre servite più a rafforzare le gerarchie legali e sociali che a facilitare una deliberazione democratica aperta e inclusiva”, scrive Franks. Basti pensare a come, per secoli, le donne siano state relegate alla sfera domestica, a come le città siano ancora oggi inaccessibili a moltissime persone disabili, o a come le amministrazioni cittadine ereggano architetture ostili per espellere i senzatetto dagli spazi pubblici.
“Concentrarsi sulla piazza pubblica come un luogo unico e significativo [per il discorso pubblico] oscura l’importanza dei forum governativi e degli spazi non pubblici in cui vengono generati discorsi democratici, dibattiti ed attivismo, come casa, scuole, luoghi di lavoro, librerie, parrucchieri, club”, continua l’accademica. “Se vogliamo spazi online che non si limitino a replicare le gerarchie esistenti e rafforzino le distribuzioni radicalmente ineguali del potere sociale, economico, culturale e politico, dobbiamo andare oltre il cliché semplicistico e corrosivo della piazza pubblica non regolamentata e impegnarci nel duro lavoro di progettazione per la democrazia. (…) Invece di una piazza pubblica idealizzata, possiamo immaginare lo sbocciare di molteplici spazi – online e offline, pubblici e privati - che forniscono le condizioni necessarie per la libera espressione e la deliberazione democratica”.
Le piattaforme lucrano sul fatto che più gente possibile le percepisca come spazi vitali per scambiare idee, ma sono progettate per servire interessi aziendali, non pubblici.
Di tentativi in questo senso ne sono stati fatti diversi. Nel 2011, l’attivista del Bahrain Esra’a al Shafei, già nota per aver creato diverse comunità digitale dedicate al cambiamento sociale, ha creato Ahwaa, una piattaforma che rappresentasse uno spazio sicuro per i giovani LGBTQ+ del Medio Oriente, disegnata per proteggere l’identità degli utenti vietando la pubblicazione di proprie foto, ma incoraggiando al loro posto la creazione di avatar. Un’altra caratteristica di Ahwaa, pensata per minimizzare le probabilità di molestie e infiltrazioni da parte dei troll, era quella di premiare gli utenti con un sistema a punti: ogni volta che qualcuno rispondeva a una discussione in modo costruttivo o creava contenuti utili agli altri guadagnava più punti. A un certo numero di punti equivalevano dei privilegi, come la possibilità di mandare messaggi privati o di creare gruppi.
Sempre nel Medio Oriente, nel 2014, dopo essere stato uno dei protagonisti delle proteste contro il regime di Mubarak in Egitto, il giovane Wael Ghonim ha creato Parlio, disegnato esplicitamente per incoraggiare discussioni più politiche di quelle che avvenivano su Facebook. Aperto, soltanto su invito, ad altri attivisti, Parlio non aveva l’obiettivo di raggiungere milioni di utenti, ma di creare uno spazio dove giovani attivisti potessero “condividere opinioni ed esperienze che rafforzino l’intelligenza collettiva della comunità”. “Crediamo che la diversità di pensiero sia una virtù e siamo qui per imparare nuove prospettive; non per vincere argomenti”, si leggeva sul sito, poi acquisito da Quora nel 2016.
Ci sono poi social network come Gell.com – creato per dibattere di complessi temi politici premiando le posizioni meglio argomentate e più convincenti, ma all’interno di uno spazio estremamente controllato dai moderatori – o vTaiwan e Decidim, fondati rispettivamente a Taiwan e in Catalogna come strumenti utili di democrazia diretta.
Ethan Zuckermann, direttore del MIT Center for Civic Media, ha scritto che questi social media ad orientamento civico “non sono per tutti, e non sono pensati per essere usati tutto il tempo, ma forniscono spazi di fondamentale importanza per conversazioni difficili da tenere altrove, e ci rendono più ricchi e resilienti come società”.
I social media ad orientamento civico “non sono per tutti, e non sono pensati per essere usati tutto il tempo, ma forniscono spazi di fondamentale importanza per conversazioni difficili da tenere altrove”.
“Le reti civiche sono economicamente sostenibili? In base alle metriche convenzionali, basate sul numero di utenti o sulla vendita di pubblicità, la risposta è semplice: no. Reti come Gell e Ahwaa hanno a malapena abbastanza traffico per essere presenti su siti di misurazione del traffico come Alexa. Non sono in grado di coprire i costi attraverso la pubblicità e la maggior parte non può fare affidamento su investimenti di capitale di rischio per far crescere le proprie comunità fino a quando non sono redditizie”, scrive Zuckermann. Quello che invece si auspica è che questi spazi digitali “vengano considerati come beni pubblici, come aspetti della nostra infrastruttura sociale talmente importanti che scegliamo di sostenerli con i soldi dei contribuenti o attraverso donazioni, così come sosteniamo biblioteche e parchi pubblici”.
Di parchi pubblici parlava anche Eli Pariser quando, due anni fa, scriveva su Wired il pezzo con cui annunciava il suo nuovo progetto: New_Public, organizzazione, comunità e centro di ricerca che parte da teoria del design e urbanistica per pensare a come costruire spazi digitali più accoglienti e rigogliosi.
“Molta della nostra vita di comunità ora si svolge in spazi digitali che sembrano pubblici ma non lo sono”, è il presupposto di Pariser, già noto per teorizzato il concetto di filter bubble. Parlando di come piattaforme come Facebook o Twitter si spaccino come aperti a tutti, ma siano piuttosto assimilabili a “giardini recintati” su cui i proprietari, rigorosamente privati, hanno totale controllo, Parisier esplicita che spazi disegnati per massimizzare i profitti catturando l’attenzione collettiva finiscono per non avere le caratteristiche necessarie per agire da piazza pubblica.
Il lavoro di New_Public, da allora, è stato quello di capire quali sono, allora, le caratteristiche più importanti per costruire parchi, librerie e, sì, anche cose che assomiglino a piazze cittadine online: spazi “dove ci vediamo, ci incontriamo e impariamo ad apprezzare coloro che sono diversi da noi, a riconoscere e affrontare le disuguaglianze e a costruire un senso di comunità e identità”.
Spazi disegnati per massimizzare i profitti catturando l’attenzione collettiva finiscono per non avere le caratteristiche necessarie per agire da piazza pubblica.
La speranza, in fondo in fondo, non è soltato quella di rendere meno tossici, violenti, incivili gli spazi che già abitiamo: è di mettere in moto un esercizio di immaginazione collettivo che finisca per costruire e rafforzare il genere di comunità di cui abbiamo disperato bisogno per affrontare le crisi che marciano a passo spedito nella nostra direzione.