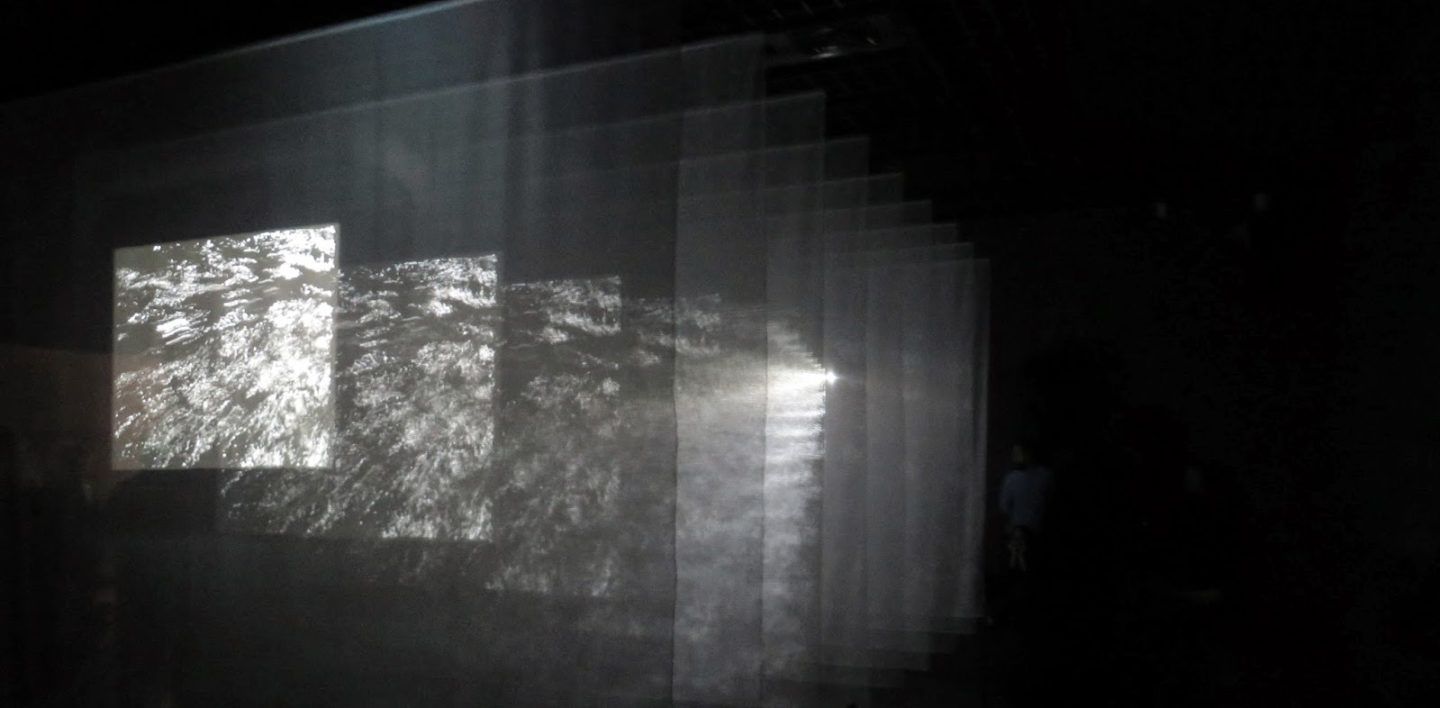
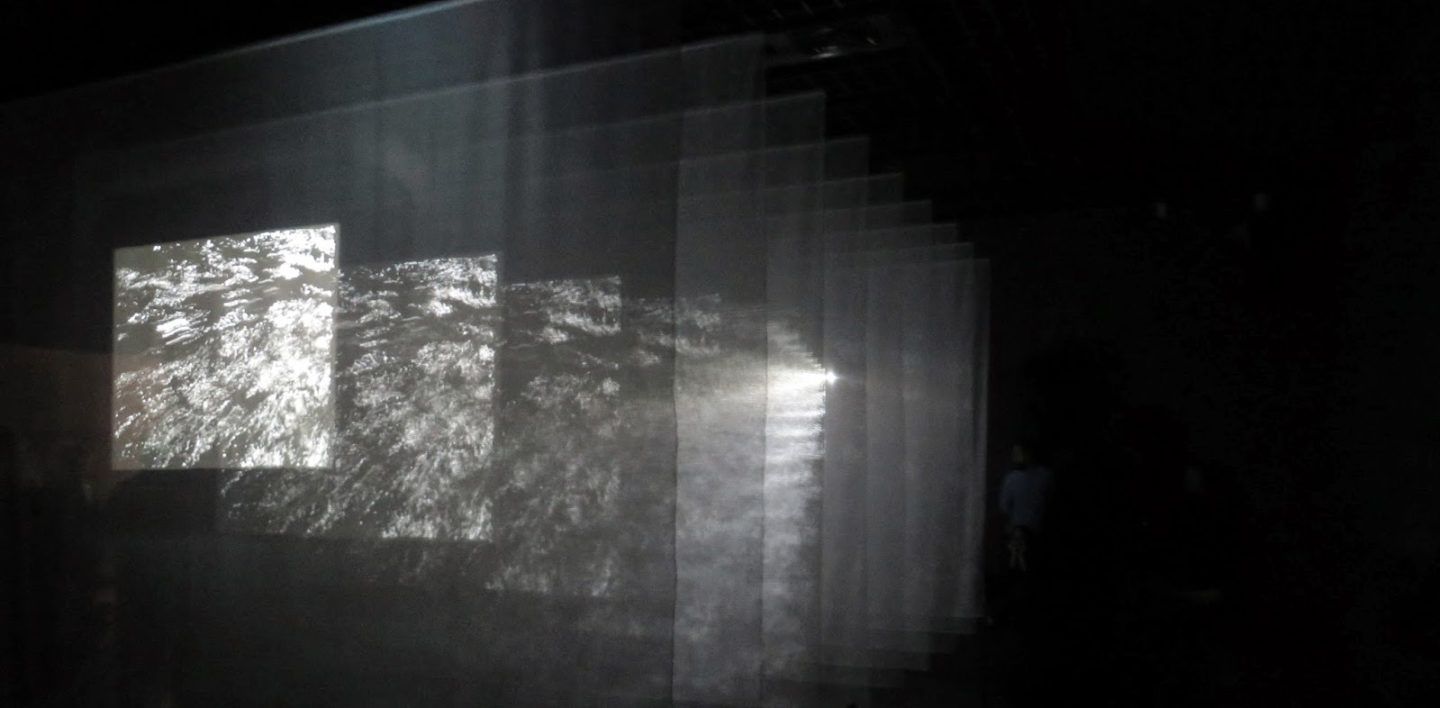
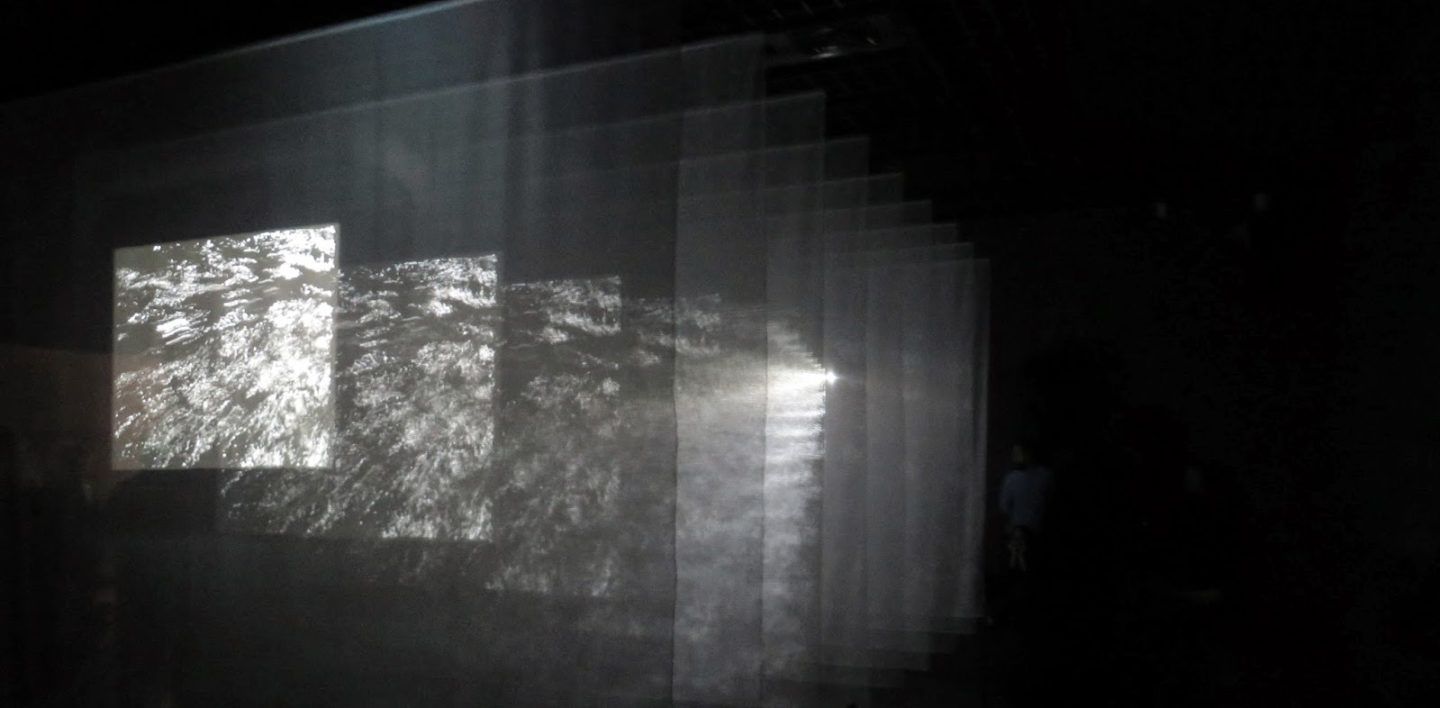
I o parlo con gli spiriti. Con i morti, intendo. E per farlo, non ho bisogno di intrecciare le mie mani a quelle di compagni di seduta, in lunghe catene che convoglino energia spirituale, fino a raddensarla in ectoplasmi. Né di usare esotiche tavole ouija, il cui indicatore mobile possa essere sospinto da forze occulte verso questa o quella lettera per computare frasi monche e sibilline. Niente più penombre e atmosfere rarefatte alla Isabel Allende, dunque. Mi basta il mio smartphone, il quale è perfettamente in grado di mettermi in contatto con i trapassati. E – che ci crediate o no – anche il vostro può farlo. Anzi lo ha già fatto, probabilmente mille volte senza che ve ne siate nemmeno accorti. Perché a separarci dall’aldilà è solo un sottilissimo schermo a cristalli liquidi.
“Anche se è eccessivo, e persino pericoloso, dire che noi siamo i nostri dati”, non molto tempo fa illustrava Stefano Rodotà, “è tuttavia vero che la nostra rappresentazione sociale è sempre più affidata a informazioni sparse in una molteplicità di banche dati”. Così le tracce che disseminiamo nella rete plasmano la nostra “anima informazionale”, la quale è per alcuni versi più completa e analitica di quella “spirituale” consegnataci dalla tradizione. Sempre che si sia disposti ad ammetterla, la spirituale. O comunque più ricca della nostra coscienza, che tende necessariamente a selezionare e a dimenticare. L’anima informazionale invece no. Ricorda tutto, come in Funes el memorioso di Borges. Conserva notizia di quando ho acquistato l’ultimo paio di scarpe cinesi con il 30% di sconto; ma custodisce gelosamente anche le frasi del battibecco – ammetto, un po’ volgarotto – avuto via chat, forse sei-sette anni fa, con uno sconosciuto che sarebbe poi diventato il mio capoufficio; non ha dimenticato il mio “like” a un post razzista non letto ma pubblicato con un titolo tanto figo; e soprattutto non rimuove le preferenze ricavabili dalle mie ricerche online, per intendersi anche quelle condotte in siti – homo sum – in cui la scelta tra categorie di piaceri si fa con una mano sola.
Tutto. L’anima informazionale trattiene tutto, anche se in maniera disorganizzata come una maionese impazzita. E al decesso del soggetto reale a cui essa corrisponde, invece di librarsi verso un altrove metafisico, volente o nolente rimane intrappolata nella rete. Divenendo un fantasma digitale. Quasi che il web possa rappresentare il nuovo Purgatorio dell’attuale società cyber-magico-religiosa: una cabina di depressurizzazione tra vita e morte, in cui le anime degli estinti possano albergare ancora un po’ ed essere evocate attraverso una pratica necromantica sì, ma addomesticata da riti, procedure e click. È successo, ad esempio in Russia, a Roman, il cui “spirito” – essenzialmente, i messaggi di chat – dopo la morte, è stato implementato in un apposito chatbot dall’amica Eugenia. Che l’ha imprigionato come un genio in una lampada. “Come stai, Roman?” gli chiede. “Bene, solo un po’ giù di corda” le risponde lui da un Purgatorio fatto di bit. E il loro rapporto durerà per sempre, come nelle favole. Le quali, beninteso, possono essere anche gotiche, visto che il fatto – reale come le mie mani che stanno pestando sulla tastiera e come i vostri occhi che si stanno sgranando per leggere queste parole – ha tratto spunto da Be Right Back, episodio della seconda stagione Black Mirror, la serie televisiva distopica britannica guardata da Eugenia.
Il web può rappresentare il Purgatorio dell’attuale società cyber-magico-religiosa: una cabina di depressurizzazione tra vita e morte, in cui le anime degli estinti possono albergare ancora un po’.
Casi isolati, si dirà. E a buona ragione. Ma che cos’è YouTube se non un magnifico, pippobaudesco oltretomba, in cui si vedono morti imbellettati recitare sketch e cantare I will survive? Una “adunata di spettri”, come la definisce Maurizio Ferraris, alla quale assistiamo, sicuri, dietro un fragile schermo, che, più della nostra stessa pelle, dà (almeno a chi non abbia mai visto un film di Cronenberg) l’ingenua impressione di conoscere il confine tra carne e bit; reale e virtuale. Comunque, sul piano pratico, davvero basta un cellulare per fare cyber-necromanzia. No, non dicendo “Pronto?”. Un’espressione da anni Ottanta, quella. Ma interagendo con i profili Facebook di chi non c’è più. E sì, perché quando qualcuno scompare, la sua bacheca viene inondata di “r.i.p.” ed espressioni di cordoglio, spesso formulate da quanti per strada, quell’amico social, neanche lo salutavano. E lui… risponde. O meglio, talvolta dal suo profilo replicano i congiunti, che ne hanno le password di accesso. Tant’è che in casi del genere qualche studioso ha parlato di “zombie digitali”. Non finisce col funerale, in ogni caso. Perché alle date prestabilite, il sistema ci ricorda che è il compleanno di questo o quel morto e noi, che in un cimitero reale non ci andiamo da anni, torniamo lì, a riempirgli la bacheca di emoticon, auguri di una miglior esistenza chissà dove, foto che ci ritraggono insieme a lui. Se si tratta poi della morte di celebrities, il fenomeno acquisisce dimensioni planetarie, tali da trasformare un profilo in un vero e proprio mausoleo digitale, aggiornato da professionisti del settore.
Per non parlare dei social, solo parzialmente attivi, esplicitamente dedicati ai morti. Ce ne sono, ce ne sono. Eterni.me, ad esempio, in cui possiamo depositare oggetti digitali, come fotografie, e al quale saremo invitati a comunicare informazioni personali, affinché un software estragga un “me eterno” da far agire, anche postmortem, in situazioni inedite. E il più celebre Eter9, crasi di “Eternity” e “Cloud9”, espressione, quest’ultima, che, come nell’italiano “sentirsi al settimo cielo”, indica una condizione di beatitudine psicofisica. C’è da star tranquilli, dunque. Quel che è strano è che Eter9 sembra davvero un Facebook sub specie aeternitatis: un profilo che si compila lentamente da vivi perché possa esprimere la propria piena e autonoma intelligenza solo quando si sarà morti. Così, come status, non ci viene chiesto “a che cosa stai pensando?”. Ma, “pensa a qualcosa per l’eternità”. Marzulliano.
Tutto un po’ perturbante, davvero. Ma al contempo assai stimolante sul piano antropologico. Specie se riferito a una società, come la nostra, in cui fino a qualche decennio fa, riecheggiando Geoffrey Gorer, si parlava di “pornografia della morte”: di oscenità e indecenza, cioè, di ogni discorso in proposito, al punto di doverlo sistematicamente censurare, indi escludere dalla discussione pubblica. Ecco perché i sociologi, con Thomas Macho ad esempio, parlano di una “nuova visibilità della morte”. Lo dimostrerebbe il caso di Océane, la ragazza francese che nel 2016 si è lanciata sotto un treno, in collegamento con una cinquantina di utenti Periscope, l’applicazione di Twitter che consente di trasmettere in diretta audio e video. E poi ci sono i cosiddetti killfies: i selfies scattati al momento del suicidio. Volontario o no, perché c’è gente che per farsi una foto cool si arrampica in cima a un grattacielo e poi scivola. Sono immagini che cristallizzano l’exitus, forse l’esperienza umana per definizione meno documentabile. Come pure gli snuff movies, video amatoriali in cui è difficile distinguere la realtà dalla finzione, i quali si concludono in genere con la tortura e la morte di qualcuno. Sulla rete se ne trovano, soprattutto di farlocchi per fortuna, ma è in particolare nel deep web – l’insieme delle risorse non indicizzate a cui riesci ad accedere solo se sei davvero esperto e possiedi qualche password che non dovresti avere – che questo materiale grandguignolesco abbonda. È quello il ventre molle della rete.
La chatbot col morto potrebbe essere una mummia tecnologicamente evoluta: il tentativo, al contempo raffinatissimo e maldestro, di mantenere in vita ciò che non lo è.
Perché lo si fa? Mai come in questo caso si potrebbe rispondere, un po’ per celia, un po’ per non morire. Chissà, per esorcizzare. Forse perché l’immagine tende ad addomesticare la realtà, a un certo punto confondendo l’una con l’altra. In tempi non sospetti Susan Sontag svelava che “una cosa è soffrire, un’altra vivere con le immagini fotografate della sofferenza, che non rafforzano necessariamente la coscienza o la capacità di avere compassione. Possono anche corromperle. Una volta che si sono viste queste immagini, si è imboccata una strada che porta a vederne altre, e altre ancora. Le immagini paralizzano. Le immagini anestetizzano”. Più guardiamo la morte e più ne siamo attratti. E non a causa di una genuina pietas nei confronti di chi non c’è più. Ma per mero voyeurismo necrofilo, a cui diamo sfogo quando crediamo di esser da soli, in quell’eremitaggio digitale che è il navigare tra siti che solleticano i visceri. Un’ossessione splatter.
Può far piacere o no, sentirlo. Ma così è (anche se non vi pare). E al di là di quello che ciascuno di noi possa pensarne, è importante che finalmente anche in Italia si incominci a parlare di morte & web. Stanno infatti fiorendo lucide pubblicazioni sull’argomento. L’anno scorso, ad esempio, Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network, scritto da Giovanni Ziccardi per Utet, ha affrontato in particolare questioni socio-giuridiche connesse al tema: chi potrà gestire il mio account dopo il decesso? Qualcuno potrà leggere le mie chattate? Come potranno essere usate le mie foto? ecc. In questi giorni vede invece la luce – o le tenebre, dovrei forse dire – il bel La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale, pubblicato per i tipi di Bollati Boringhieri da Davide Sisto, giovane filosofo heavy metal, che regala un vademecum per chi voglia accostarsi con occhio critico e soprattutto aggiornato ai Death Studies e al modo in cui essi sono stati rivoluzionati dalle nuove tecnologie. Tutto, oscillando tra la filosofia dei dotti e quella delle serie tv, che Sisto, al bando ogni snobismo accademico, pone su uno stesso piano.
Permane, in conclusione, un dubbio. Probabilmente le mie informazioni resteranno stipate in qualche server yankee o su qualche cloud da cui per un po’ non pioveranno. Nondimeno, come osserva Luciano Floridi, “la memoria non è soltanto una questione di immagazzinamento e di gestione efficiente; è anche una questione di attenta cura per le differenze significative e, quindi, di stabile sedimentazione di una serie ordinata di cambiamenti”. In pratica, in barba a ogni desiderio di eternità digitale, milioni sono le pagine abbandonate in internet. Gli aggiornamenti costanti di un sito non conservano neanche memoria del proprio passato. Infine, quei social che adesso paiono tanto trendy, tra qualche anno verosimilmente non esisteranno più. E allora saranno loro a impetrare una second life. In breve, Eugenia potrebbe non aver regalato a Roman alcuna immortalità. Ma soltanto un feticcio di quest’ultima. Come quella che, un tempo, in Egitto, si credeva di ottenere con la mummificazione. Una apparenza. La chatbot col morto potrebbe dunque essere una mummia tecnologicamente evoluta: il tentativo, al contempo raffinatissimo e maldestro, di mantenere in vita ciò che non lo è. Ed è per questo che Davide Sisto, il quale fa propria la lezione di Merleau-Ponty, ritiene che gli spettri di Roman, come quelli di Eter9, “ci mettono nella condizione di fingere di avere ciò di cui non siamo più in possesso”: essi cioè “fingono di tenere aperto il mondo che la morte ha chiuso”. Diamo a vedere di parlare con i morti perché questo fa star meglio noi vivi. Possiamo parlare con gli spettri, sì. Ma per ora solo con quelli che albergano nel nostro animo.