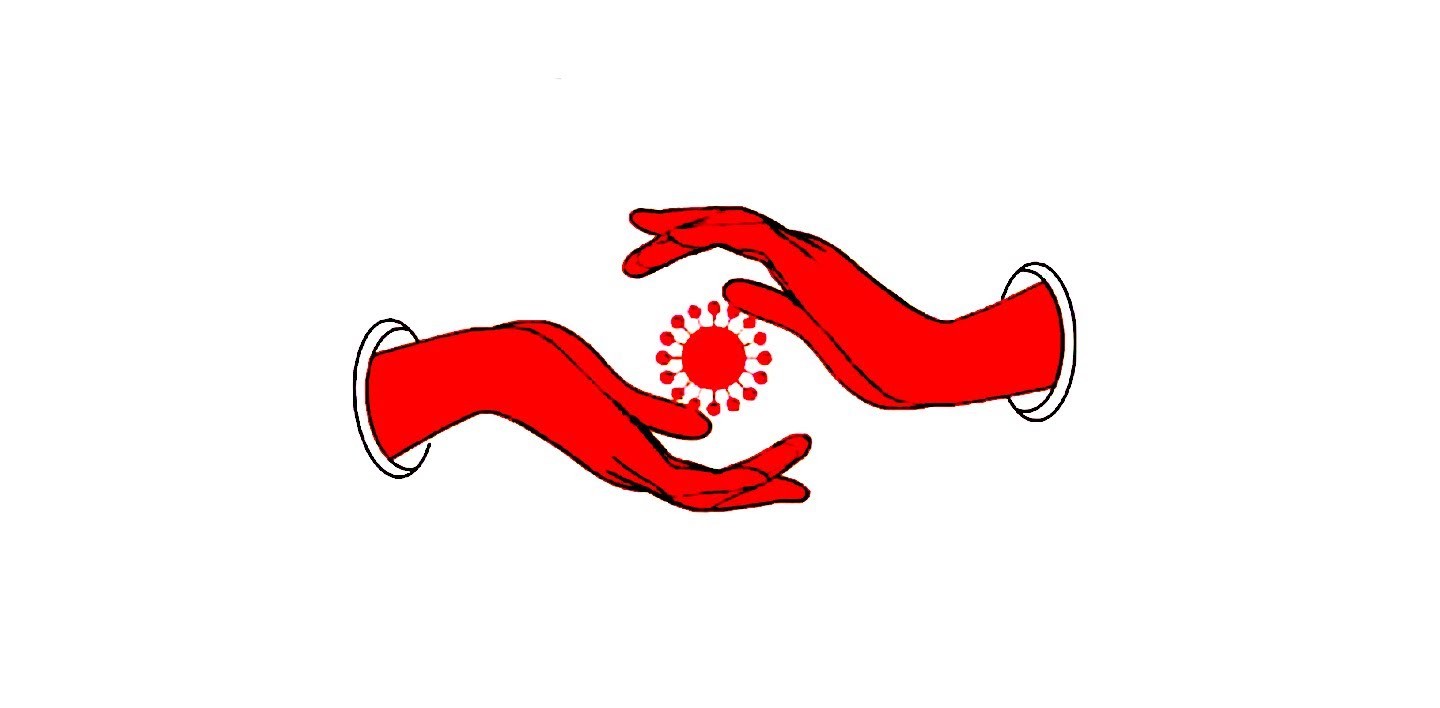
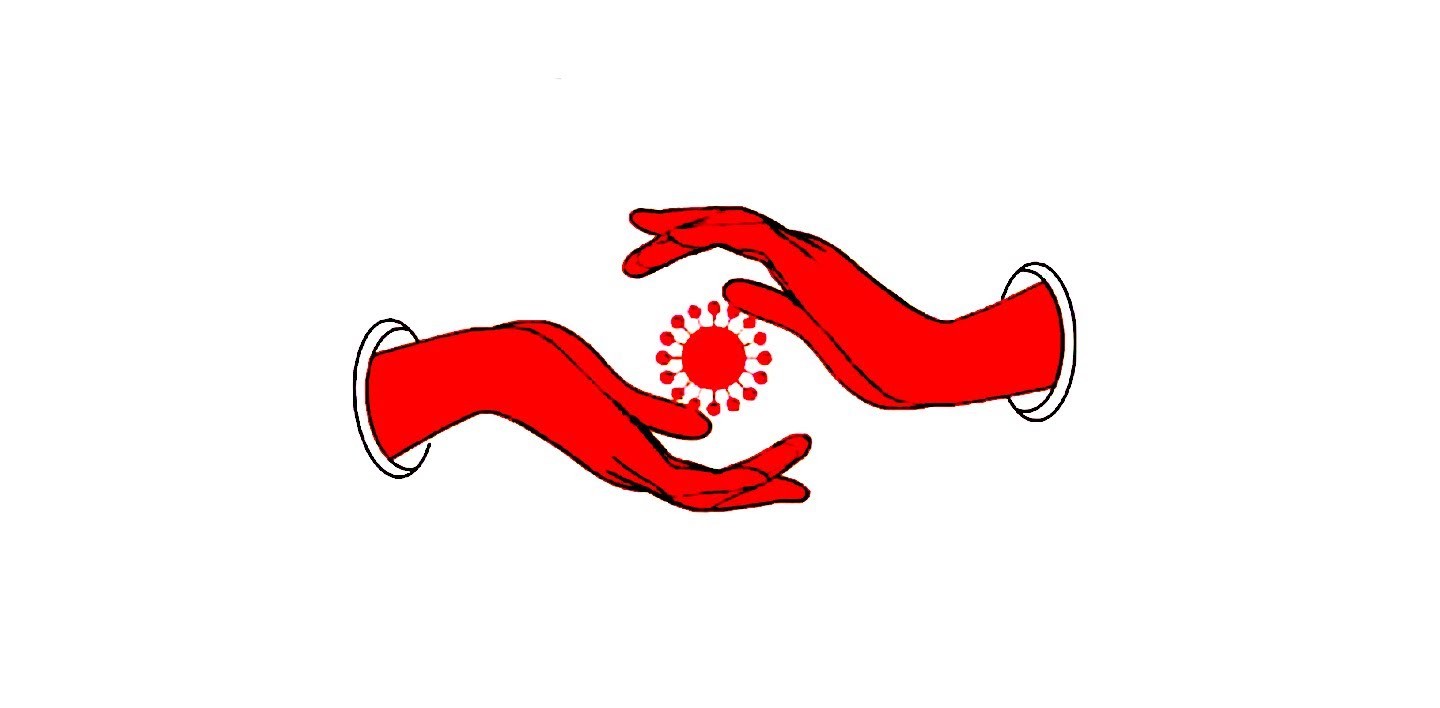
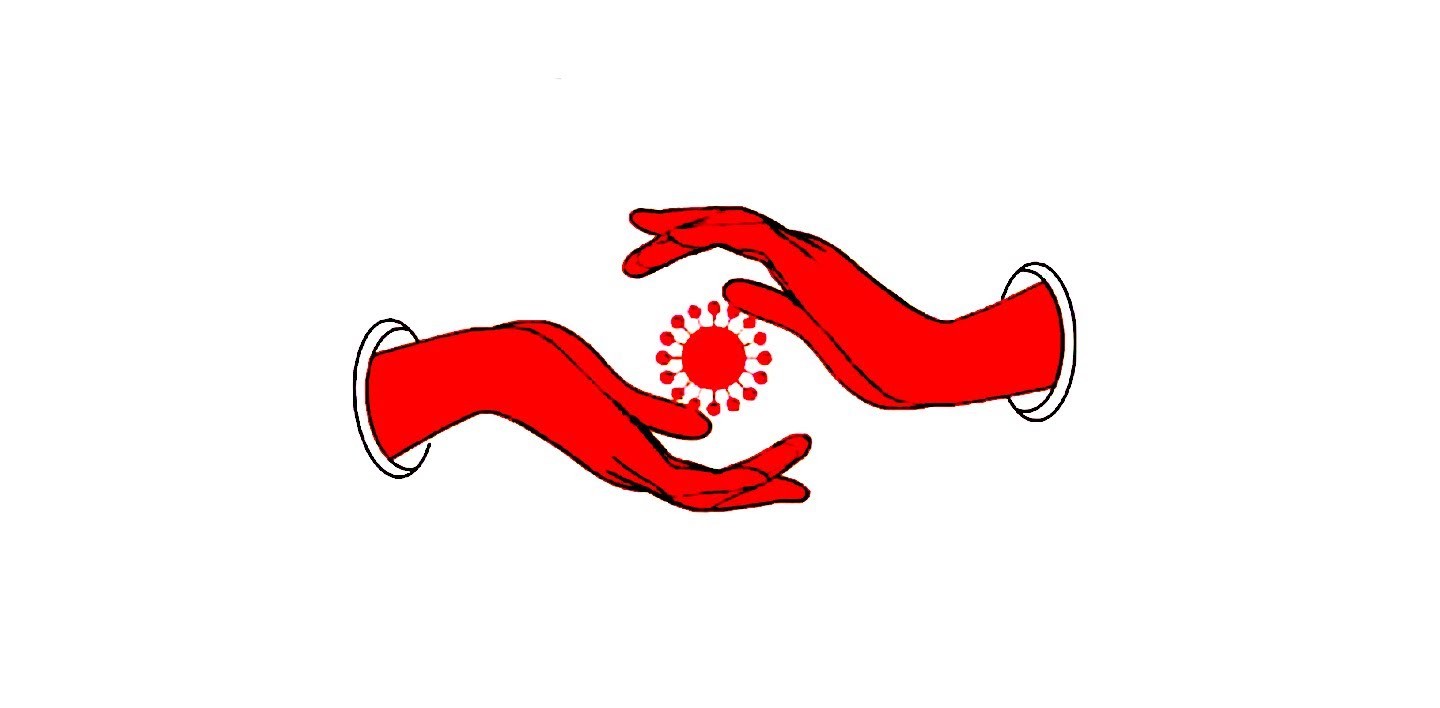
L a pandemia di COVID-19, nel dibattito intellettuale, è stata descritta spesso come un’occasione. Secondo alcuni (uno su tutti il filosofo italiano Giorgio Agamben), è stata infatti l’occasione del potere di sospendere, una volta per tutte, qualsiasi residuo di libertà con la scusa – o addirittura la macchinazione – di un cataclisma sociale che in fondo tanto grave non sarebbe. Secondo altri, come il filosofo sloveno Slavoj Žižek, all’opposto, è stata l’occasione per il rinnovarsi di un senso di comunità che, col tempo, darà forse il colpo di grazia ad alcune delle disuguaglianze più stridenti della nostra società.
C’è chi ha scelto di scardinare questa polarizzazione votata alla semplificazione, cercando di descrivere il profilo disomogeneo, complesso e contraddittorio della vita politica e sociale all’interno della pandemia, in particolare studiose, studiosi e gruppi di ricerca spesso provenienti dal mondo degli studi di genere, post-coloniali e dell’ecologia politica. In un intervento uscito lo scorso 9 aprile, per esempio, Cinzia Arruzza e Felice Mometti, invece di ricorrere a letture teoriche – la lente interpretativa dello “stato d’eccezione” per Agamben; lo sviluppo necessariamente rivoluzionario delle forze produttive della società per Žižek – si sono affidati all’analisi dettagliata della realtà: alle prime avvisaglie del disastro, ricordano, i governi hanno fatto tutto fuorché applicare misure di sospensione della normalità. Il lockdown, in Italia in maniera particolare, è stato deciso anche in seguito a scioperi e pressioni provenienti dal mondo sanitario, contro il cinismo di quella parte di mondo imprenditoriale che, per mantenere in movimento le attività produttive, aveva fino a quel momento messo a rischio l’incolumità dei lavoratori, dei loro cari e della popolazione. Come sottolineano Arruzza e Mometti, questa forza, nata dalla determinazione a tutelare la salute personale e collettiva, ha poi dovuto fare i conti con le ansie, le paure e le difficoltà sopraggiunte insieme a un virus sconosciuto, l’inasprirsi delle disuguaglianze economiche dovuto alla contrazioni dei redditi di singoli e famiglie e, soprattutto, con una clausura di massa difficilmente immaginabile fino a poco tempo prima.
Sulla scia dell’approccio sviluppato da Arruzza e Mometti, questo articolo è un tentativo di ricucire insieme una serie di eventi e fenomeni che i tempi accelerati dell’emergenza hanno finito per celare e confondere. Nasce da un’esigenza di memoria: come ricorderemo questa pandemia e, più nello specifico, il distanziamento sociale? Il che vuol dire anche: chi lo ha decretato? Chi lo ha voluto? Lo ricorderemo come una mossa di autoconservazione, come un’operazione di governo, oppure come un “campo di battaglia” tra l’alto e il basso? Nelle narrazioni che ne faremo in futuro, il ruolo di protagonista spetterà alla scienza, al governo o alla popolazione? Ma soprattutto, cosa ne è stato della libertà individuale nel momento in cui diventava impossibile incontrare i propri cari e attraversare lo spazio pubblico? Dalle risposte a questi interrogativi dipenderà la possibilità di tenere a mente, in futuro, da un lato che le conseguenze della diffusione della COVID-19 si sono distribuite in modi disuguali; dall’altro, che in una situazione di limitazione del movimento fisico si sono tuttavia manifestate altre forme di libertà.
Uscire di casa = libertà?
Nel contesto di un lockdown di più di due mesi, il concetto e la percezione di libertà sono diventati sinonimi di libera uscita dallo spazio domestico. Il rischio di questa equazione è quello di perdere di vista le forti tensioni all’origine della decisione del lockdown: una decisione politica e dunque nient’affatto “naturale”, bensì originata da interessi e posizioni in conflitto tra loro.
L’applicazione del lockdown in Italia è stata anche l’effetto di scioperi e pressioni provenienti dal mondo sanitario.
Un primo elemento che ha giocato un ruolo in questo conflitto emerge dal lavoro di associazioni che da anni si battono per i diritti civili e il rispetto delle garanzie di legge da parte delle forze dell’ordine. In svariati rapporti, le piattaforme Antigone e Acad hanno segnalato numerosi casi in cui, al fine di garantire il “distanziamento sociale” e la riduzione del contagio, i controlli e le operazioni condotti dalle forze di polizia sono sfociati in episodi di violenza ingiustificata e in atteggiamenti di eccessiva discrezionalità nell’applicazione delle norme: comminazione di multe elevate anche in casi di dubbia legittimità – durante il lavoro, andando in ospedale; fermi ordinari tramutati in aggressioni vere e proprie; violenze sui detenuti delle carceri italiane, come risposta alle proteste sorte dalla paura che i luoghi di detenzione si trasformassero in focolai senza uscita.
Un secondo fenomeno è quello della “caccia agli untori”. Media e politici hanno lavorato in maniera minuziosa, con decreti, ordinanze ed esternazioni – famosi sono i termini “passeggiatina” e “corsetta” impiegati dal governatore della Campania De Luca, insieme alle sue minacce di usare il lanciafiamme contro le feste di laurea – al fine di creare un clima di sfiducia e sospetto reciproco nei confronti di chi si fosse concesso qualche momento all’aperto. Nello stesso filone si inseriscono le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala che, pur non volendosi assumere la responsabilità di un prolungamento della chiusura delle attività, ha rimproverato quanti, con l’allentamento del lockdown, si erano dati appuntamento sui Navigli, accusandoli di non rispettare quelle regole di distanziamento che pure rendevano molto complesso un ritorno alla “normalità” dello svolgimento delle attività produttive e commerciali.
A questa ricerca di un capro espiatorio nella condotta indisciplinata della società civile si è aggiunto il tentativo di connotare politicamente la relazione tra libertà e presenza nello spazio pubblico. L’opposizione da destra al governo si è impegnata in una specifica operazione: ricondurre la forte personalizzazione dell’esecutivo sulla figura del presidente Conte – ricercata e voluta dal premier stesso – a una trasformazione in senso totalitario della gestione della crisi, riducendo ogni azione messa in atto dall’esecutivo a una volontà di stampo dittatoriale. È così che il “distanziamento sociale” e il rimanere in casa, nel lessico delle opposizioni, sono diventati enunciati contro la libertà a cui opporre discorsi e iniziative volte a “rompere la gabbia di una quarantena intollerabile”: basti ricordare il tentativo, escogitato da Ignazio La Russa per conto di Fratelli d’Italia, di indire una giornata nazionale di “liberazione dal coronavirus” e dal lockdown proprio nella giornata partigiana per antonomasia, il 25 aprile. Una distorsione resa possibile dalla confusione di fondo, cui tutti siamo stati vittime, relativa a chi abbia effettivamente deciso e voluto la sospensione di mobilità e relazioni sociali, comprimendo indebitamente diffusione del virus, autotutela dal contagio da parte della popolazione e volontà governativa dietro al solo volto del premier.
La destra italiana, cavalcando le difficoltà della popolazione a rimanere chiusa in casa per lungo tempo, ha disegnato l’equivalenza suddetta all’interno di una strategia ben precisa, riassumibile nei punti seguenti: ricostituire una competizione tra governo e opposizione dentro uno scenario in cui la corsa al consenso propria dello scontro tra partiti, che fa dell’Italia un paese in perenne campagna elettorale, sembrava essere messa in ombra da un’emergenza superiore a qualsiasi querelle parlamentare o polemica da social network; rinsaldare la filiazione con con quella parte di elettorato che coincide con la media e piccola imprenditoria che tanto ha risentito della depressione dei consumi dovuto alle restrizioni nella mobilità – commercianti, bottegai, ristoratori, protagonisti della manifestazione di piazza organizzata da Giorgia Meloni il 28 aprile davanti Palazzo Chigi. Conte, dal canto suo, in questo nuovo manicheismo ha fatto propria la semantica della “sicurezza” – in tutte le sue conferenze stampa non ha mai mancato di ricordare, ad esempio, la natura esemplare delle multe previste per i trasgressori delle misure d’emergenza – e dell’unità nazionale tanto care ai suoi avversari e che nessuno era mai riuscito a contendere loro altrettanto efficacemente. Tuttavia, l’effetto del dualismo tra governo e opposizione (di destra), risoltosi a favore del premier in carica, è stato quello di nascondere una realtà più importante: quella di un lockdown differenziato improntato alla necessità di continuare a produrre nonostante i costi in termini di vite e di circolazione del virus, a cui solo la popolazione ha saputo in parte mettere freno.
Lockdown a metà
Per dovere di cronaca è importante riferirsi a un dato statistico. Intorno alla metà del mese di aprile, l’Istat ha rilasciato un rapporto secondo cui il 55,7% della forza-lavoro è rimasta attiva durante il lockdown, spostandosi per andare a lavoro – il dato, dunque, non riguarda chi ha visto continuare la propria attività nella modalità dello smartworking. Percentuali impressionanti, che assumono tratti estremamente tragici se si guarda ai dati sulle città. I livelli più alti si hanno nei grandi centri, dove Milano registra il 67,1%. Avvicinandoci ai focolai principali, i numeri parlano da soli: Lodi 73,1% e Crema 69,2%, che distano solo 24 Km da Codogno, epicentro del virus.
Secondo l’Istat, il 55,7% della forza-lavoro è rimasta attiva durante il lockdown, spostandosi per andare a lavoro.
Ciò si spiega alla luce del DPCM del 22 marzo scorso, relativo allo stop delle attività ritenute non essenziali. Secondo uno studio condotto dalla fondazione Sabattini, il governo ha dato la possibilità alle aziende di definire, in totale autonomia, la propria funzionalità a quanto è definito fondamentale, ovvero sanità, agroalimentare, energia, e così via, come se tutto quanto possa vantare una minima relazione con l’agroalimentare dovesse ritenersi fondamentale. Una scelta, questa, che l’esecutivo compiva accogliendo forti pressioni da parte di Confindustria, cui si aggiungono non poche responsabilità da parte dei sindacati confederali i quali, durante il decorso della pandemia, hanno impostato il loro discorso su posizioni morbide votate alla continuazione della produzione in presenza di strumentazione adeguata – limite facilmente scavalcabile adottando misure magari ben visibili (le fantomatiche mascherine) ma dall’efficacia difficilmente accertabile.
Secondo un’altra statistica, questa volta dell’Inps, nelle province in cui sono concentrate un maggior numero di attività considerate essenziali, i contagi sono cresciuti del 25% in più rispetto alla media. Il dato, è bene sottolinearlo, è a ribasso, visto che i tamponi vengono effettuati solo su coloro che manifestano sintomi avanzati, escludendo gli asintomatici. Insomma, la produzione si è fermata ben poco, mentre i dati lasciano pensare che l’obbligo al lavoro si sia dimostrato determinante nella circolazione del virus e nel suo impatto in termini di vite umane.
#IoRestoACasaMa…
In questo scenario è molto complesso ricostruire, con precisione, il punto di vista dei lavoratori degli ospedali nel momento in cui cominciavano a manifestarsi le prime avvisaglie del disastro. Un’operatrice della sanità lombarda, con la condizione di rimanere anonima, mi ha raccontato la sua esperienza: “Ho trovato, da un giorno all’altro, interi reparti stravolti da cima a fondo senza aver ricevuto comunicazioni preventive. In più, siamo stati costretti a lavorare senza la dotazione medica adeguata ad evitare il contagio”. È ormai noto che chi ha provato a denunciare fatti di questo tipo abbia subito minacce, con l’obbligo di evitare ogni contatto con la stampa. I più coraggiosi si sono impegnati in scioperi spontanei.
La consapevolezza si è costruita lungo traiettorie che partivano dagli operatori della sanità preparando quel senso di autotutela presto diventato determinante per indirizzare le scelte del governo.
Altrettanto importanti sono stati gli appelli di medici e infermieri, circolati soprattutto su Facebook, prima dell’estensione del lockdown a tutto il paese, con l’obiettivo di contrastare lo scetticismo verso l’effettiva aggressività del virus. Prese di parola, queste, che individuano posizioni molto distanti da quelle che hanno guidato alcune operazioni di mistificazione, come il tanto famoso video #MilanoNonSiFerma, uscito il 27 febbraio. Insomma, ben prima che l’Italia diventasse un’unica zona rossa, la consapevolezza sulla situazione si è costruita anche lungo traiettorie più o meno informali che dagli operatori della sanità arrivavano ai loro parenti, amici e followers, preparando quel senso di autotutela diffuso presto diventato determinante per indirizzare le scelte adottate dal governo da lì in avanti. I dati del Ministero della Salute sul numero dei contagiati nel mondo della sanità – che ammontavano al 10% del totale alla fine di aprile – mostrano che i moniti provenienti da quel contesto rispondevano a reali esigenze di salvaguardia e non certo di opportunismo. Analizzandoli in dettaglio, il 43,2% dei contagiati sono infermiere/i – soggetti che, normalmente, ben poco hanno potuto incidere in questi anni sulle politiche in ambito sanitario e che hanno invece fatto esperienza diretta della precarietà delle condizioni di lavoro nella sanità italiana.
Un altro fronte di rilievo è stato quello del mondo della produzione. I motivi che rendono difficile ricostruire il punto di vista dei lavoratori stanziati nelle zone prossime al focolaio sono principalmente due: la Commissione di garanzia degli scioperi, a fine febbraio, ha chiesto la sospensione di ogni iniziativa di astensione dal lavoro; Confindustria, a livello sia nazionale che locale ha esercitato forti pressioni per tenere aperte le fabbriche. A tal proposito, fanno testo l’iniziativa del 28 febbraio di Confindustria Bergamo che, al fine di tranquillizzare i partner commerciali esteri, rilascia il video “Bergamo is running”, in cui si annunciava: “gli attuali avvertimenti sanitari dei dipartimenti governativi italiani indicano che il rischio di infezione è basso”; nonché la chiara volontà “di tenere aperte le aziende, dando continuità a tutte le attività produttive e alla libera circolazione delle merci”, firmato Confindustria Lombardia, dell’11 marzo scorso, quando i casi accertati erano già oltre dodicimila. I lavoratori stavano diventando evidentemente via via più consapevoli del pericolo: il decreto che ha disposto la chiusura delle sole attività commerciali, permettendo tuttavia alle fabbriche di rimanere aperte, senza predisporre interventi concreti per garantire la sicurezza degli operai è stato accolto (nonostante il divieto della Commissione per gli scioperi) da numerosissimi scioperi organizzati da Nord a Sud, che hanno colpito Amazon, Leonardo, Fincantieri e altre grandi aziende, costringendo il Premier a convocare, per il giorno successivo, un tavolo con sindacati e industriali. Le iniziative di contestazione non si sarebbero arrestate per tutto il mese di marzo, registrando, in molti appuntamenti, picchi del 90% di adesione, con una semplice richiesta: chiusura di tutte le attività non essenziali. Se non c’è sicurezza, che si resti a casa.
Distanziamento fisico, solidarietà sociale
Il panorama fin qui tratteggiato, per quanto frammentato, mostra un fatto inequivocabile: la decretazione del lockdown, nonché i confini della sua estensione, sono stati il campo di conflitto privilegiato tra potere politico, interessi economici e autotutela sociale – dunque niente affatto ascrivibile ad una sola volontà di stampo “dittatoriale”. Il lockdown non è stato lo stratagemma perfetto per rendere sistemica una nuova servitù volontaria al regnante di turno, ma lo spazio di conflitti tanto disarmonici quanto rinnovati nelle proprie priorità.
Lo dimostrano una serie di iniziative che, a modo loro, hanno definito altrettante traiettorie di mobilitazione. La prima è quella della solidarietà popolare. Fin dai primi momenti dell’emergenza, nelle città italiane sono nati importanti comitati di cooperazione sociale per il sostegno alla cittadinanza: le cosiddette “Brigate volontarie per l’emergenza”. Una rete di volontari che, a partire dalla disponibilità degli attivisti di alcuni centri sociali, ha portato a termine migliaia di commesse al giorno di beni di prima necessità. Nate con l’obiettivo di sostenere le persone più esposte alla violenza del virus (soprattutto gli anziani) la loro azione è diventata vettore di redistribuzione della ricchezza per chi, a causa dell’obbligo di distanziamento, ha perso il proprio reddito. “Le persone che stiamo andando ad aiutare sono quelle famiglie che non sono state tutelate dalla crisi. Tante consegne, infatti, le abbiamo fatte a colf e badanti”, spiega Francesco, volontario della brigata milanese “Franca Rame”. Un lavoro a tal punto prezioso che il comune di Milano è stato spinto a conferire alle brigate dei permessi speciali e fondi pubblici per esaudire le innumerevoli richieste.
Il lockdown è stato lo spazio di conflitti tanto disarmonici quanto rinnovati nelle proprie priorità.
Il secondo fronte è quello dei saperi ecologici. In molti hanno raccontato l’attuale crisi sanitaria come imprevista e imprevedibile, e di natura esogena, ovvero, legata a fattori non dipendenti dalle modalità in cui è organizzato il sistema economico. Tuttavia, com’è ormai noto, una pandemia di questo tipo era già prevista da anni, da molti ricercatori, e le radici del salto di specie di virus di questo tipo possono essere rintracciate, tra le altre cose, all’erosione dell’habitat naturale di molti animali, dovute alla deforestazione, l’urbanizzazione, la macellazione di animali selvatici e la sovrabbondanza degli allevamenti intensivi.
Anche l’inquinamento potrebbe giocare un ruolo importante, un fattore che può incrementare la virulenza e capacità di uccidere di un virus. Un primo segnale in questo senso è venuto da una ricerca dell’Università di Harvard, secondo la quale alle zone ad alta concentrazione di polveri sottili corrisponde un tasso di mortalità da COVID-19 superiore del’8% rispetto alla media.
Tornando all’Italia, bisogna ricordare il lavoro svolto dai gruppi di studio “Ecologia politica”, impegnati a ricostruire gli inneschi ambientali alla base della pandemia. Attraverso webinar molto partecipati, attivisti ambientali e studiosi si sono interrogati, ad esempio, sui motivi per cui la Pianura Padana (una delle aree più inquinate d’Europa) sia stata lo scenario del focolaio più critico a livello globale, evidenziando l’insostenibilità in termini di salute pubblica di un modo di produrre basato su combustibili fossili e alte emissioni. Al di là del servizio di divulgazione offerto alla cittadinanza, questi gruppi di ricerca si sono attivati per invertire una delle tendenza più problematiche che, secondo Rob Wallace, biologo e autore di Big Farms Make Big Flu, caratterizzano storicamente la gestione politica e medica delle pandemie: “ci si focalizza talmente tanto sulle nuove emergenze da non curarsi delle cause strutturali che stanno portando numerosi agenti patogeni marginali a diventare vere e proprie celebrità”.
Insieme al fronte del mutualismo e dei saperi ecologici, va citato l’impegno dei movimenti sociali per l’autodeterminazione riproduttiva delle donne. Con lo scoppio dell’emergenza, la riconversione degli ospedali ha finito per compromettere un diritto già molto difficile da vedersi riconosciuto in Italia: quello all’interruzione di gravidanza. A lanciare l’allarme è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità che, preoccupata da possibili regressioni nell’ambito dei diritti riproduttivi, agli inizi di aprile ha invitato gli stati a trovare soluzioni per garantire l’accesso alla contraccezione. Come è noto, il nostro paese sconta tassi di obiezioni di coscienza molto alti – circa 7 ginecologi su 10 sono obiettori – , nonostante la legge 194 del 1978 permetta l’interruzione volontaria di gravidanza.
Fortunatamente, anche in Italia sono state molte le associazioni pro choice e i collettivi femministi che fin da subito si sono attivati per sostenere le donne in questa fase di emergenza – tra questi la piattaforma Obiezione Respinta. Grazie ad un apposito canale Telegram, questo progetto di mappatura dell’obiezione ha ricevuto centinaia di segnalazioni che mostrano come l’emergenza sanitaria in corso abbia aggravato l’accesso ai diritti riproduttivi: “Ci sono stati segnalati ospedali in cui il servizio di IVG è stato soppresso o trasferito. Alcuni medici sono in quarantena o sono stati impiegati per far fronte all’emergenza in atto”. Secondo le attiviste, è mancata la volontà politica di garantire un diritto fondamentale senza sovraccaricare il sistema sanitario: “Durante una pandemia l’aborto farmacologico potrebbe essere uno strumento risolutivo: un tempo ridotto di ospedalizzazione di persone sane comporta un minor rischio di contrarre infezioni e virus, più risorse economiche impiegabili, nonché più posti letto disponibili”.
Obiezione Respinta fa parte di una rete di mutuo soccorso di dottoresse e attiviste che in questi mesi ha fornito informazioni e aiuto pratico per trovare in tempi rapide luoghi disponibili a prescrivere pillole abortive, sostenendo molte donne nel vedersi garantiti i propri diritti fondamentali.
Gli esempi della mobilitazione dal basso indicano la via per pensare un nuovo modello di organizzazione della vita pubblica.
Nell’insufficienza di soluzioni strettamente emergenziali, a breve termine e non universalistiche che, oltre ad essere inefficaci, creano nuove disuguaglianze (basti pensare alla frammentazione degli aiuti previdenziali), questi esempi indicano invece alcune vie per pensare un nuovo modello di organizzazione della vita pubblica: una società coinvolta in un evento pandemico deve porsi giocoforza il problema della partecipazione attiva della popolazione alla gestione della crisi, dentro un quadro di intervento in cui sviluppare una cooperazione tra gli istituti del welfare e i meccanismi dell’ecosistema.