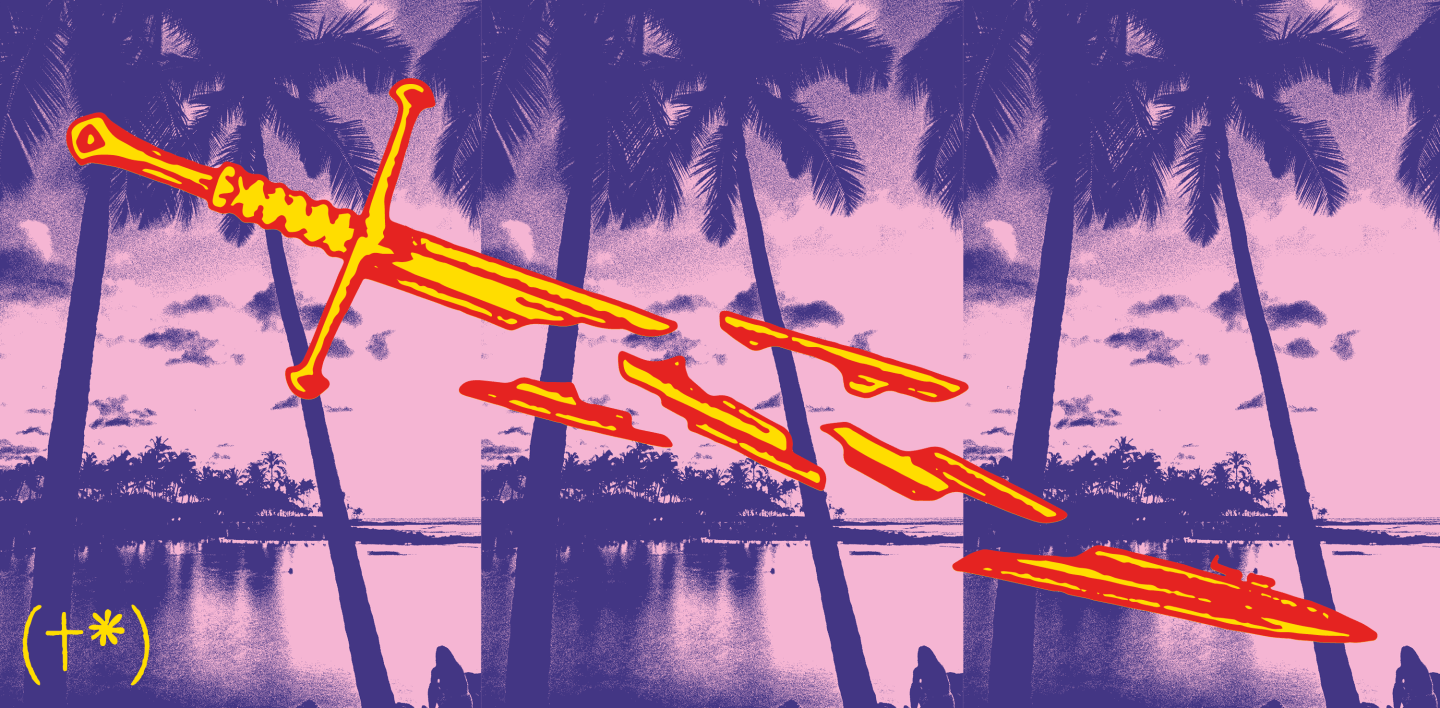
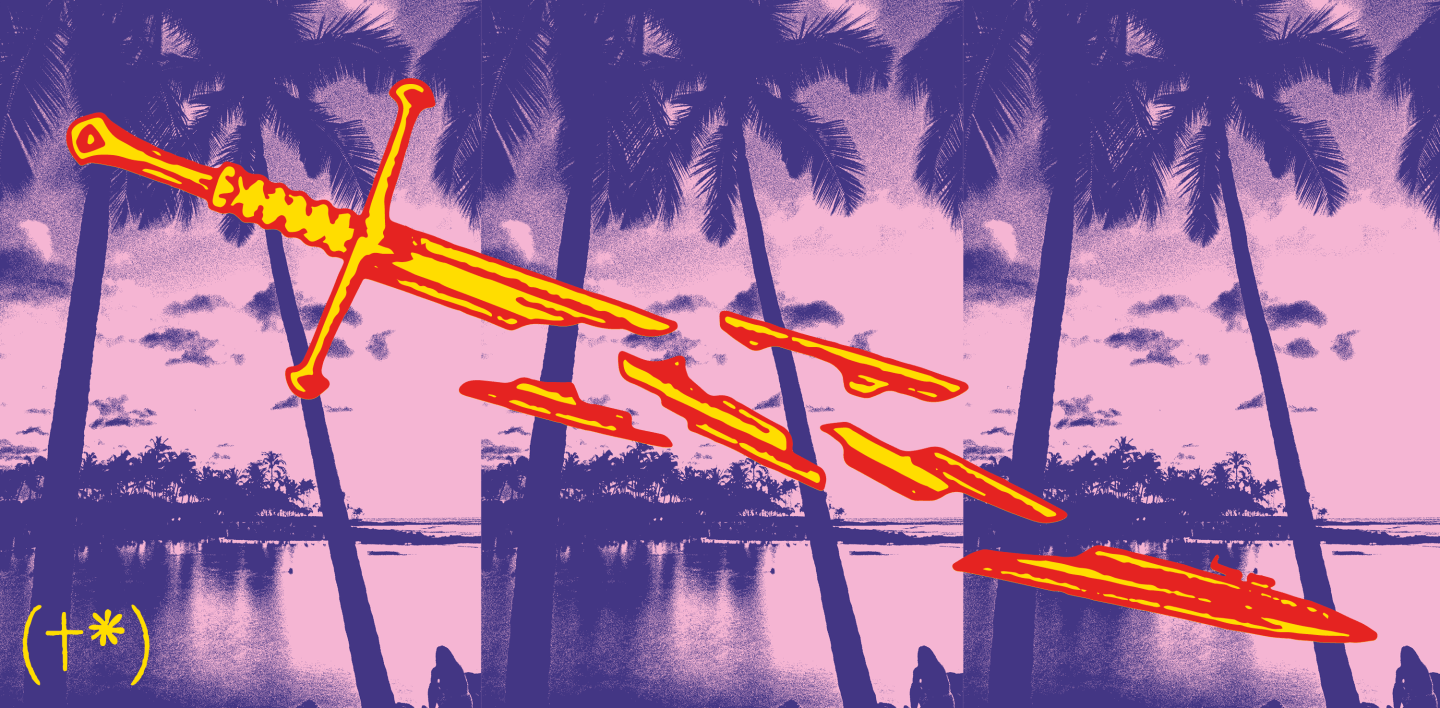
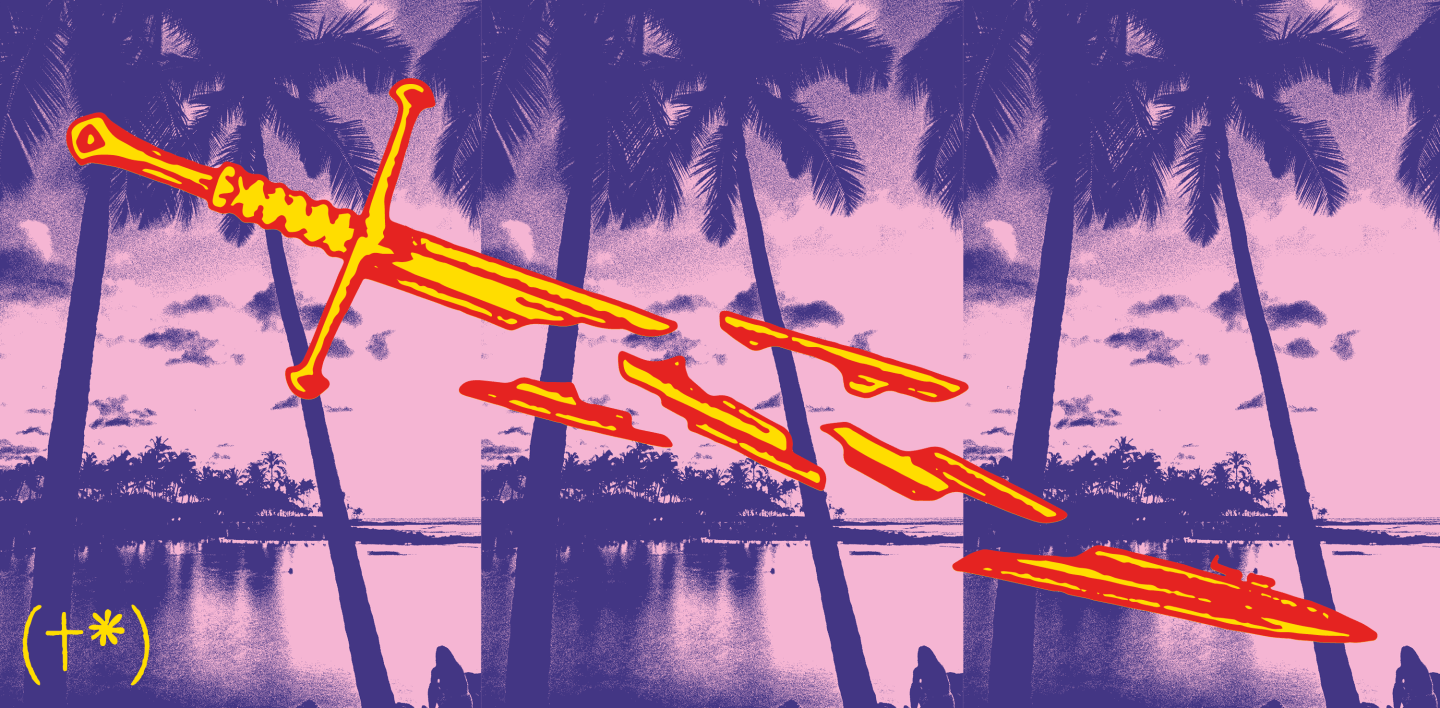
C omposta a vario titolo da Federico Antonini, Federico Campagna, Assunta Martinese e Corrado Melluso, Timeo vuole ispirare un dibattito che restituisca un nuovo senso alle pratiche utopiche e diventi così sempre più ampio, fino a stravolgere il modo in cui pensiamo al mondo”. Già nelle parole che Timeo ha scelto per presentarsi ai lettori, si intuiscono le ambizioni di Melluso e soci. Mossi dalla curiosità intorno ai primi titoli dell’editore (l’utopia di Moro, la Bibbia delle criptovalute, la pratica sonora di Pauline Oliveros, un pamphlet di Bifo) abbiamo chiesto di raccontarci la casa editrice, e siamo finiti – molto presto – a parlare di dinamiche editoriali e strategie culturali e politiche molto più ampie.
Nicolò Porcelluzzi: Dopo esperienze editoriali molto diverse tra loro, come sei arrivato all’idea di Timeo?
Corrado Melluso: All’inizio mi è stato utile affrontare il mainstream, quello vero, con una casa editrice generalista e commerciale come Baldini&Castoldi, che fa una grande quantità di libri l’anno – ai tempi miei erano settanta – divisi più o meno per ogni genere: dalla narrativa letteraria, ai gialli, ai romanzi storici, a quelli sentimentali, a vari tipi di saggistica (che andava da quella sportiva a quella televisiva: abbiamo fatto libri di Masterchef, di Mara Maionchi e così via, fino alla saggistica più politica, accademica e radicale). Quel catalogo che vedeva dentro Faletti, Belinelli, appunto Masterchef, e in cui poi si riuscivano a inserire cose migliori: penso agli annuari de L’Ultimo uomo, Heroes, Omicidi e suicidi di massa e Gerontomachia di Franco Berardi, Superonda di Valerio Mattioli, poi penso anche a libri come Shadow works, che abbiamo fatto all’epoca, un tipo di saggistica che cercavamo di collegare alla narrativa commerciale, come ad esempio l’esordio di Stefania Auci.
Elisa Cuter: Dentro a Baldini&Castoldi avevi la tua specialità o dovevi occuparti di tutto?
CM: A Baldini&Castoldi arrivai a trent’anni, prima avevo fatto uno stage da minimum fax, lavorato freelance per varie case editrici e aperto un’agenzia letteraria. Tutte queste posizioni comportano delle decisioni di secondo livello. Quando hai un’agenzia letteraria devi pensare a trovare il titolo nella maniera più nobile possibile, però, se non hai enorme potere politico dentro i cataloghi nelle singole case editrici, i tuoi margini decisionali sono scarsi. Quando fai l’editor freelance o il ghost writer si tratta di libri che ti vengono consegnati e magari tu non li avresti pubblicati, o magari lavori per una casa editrice che non ha alcuna affinità con la tua sensibilità. Poi capita spesso che i libri migliori se li lavora l’editor principale. Quando hai la possibilità effettiva di decidere cosa pubblicare? Quando assumi il potere politico nel catalogo per farlo? Le case editrici hanno un’anima profonda, difficilmente modificabile, difficilmente sostituibile e in una struttura come Baldini&Castoldi sarebbe stato impossibile in soli tre anni e mezzo cambiare radicalmente il piano editoriale, così come cambiare la produzione. Era una casa editrice che per sua storia aveva fatto da un lato Murakami, Tom Robbins, Burroughs, Paura e delirio a Las Vegas, e dall’altro aveva fatto Va’ dove ti porta il cuore oppure Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano e Jack Frusciante è uscito dal gruppo, i libri di gran cassetta, ai quali era difficile rinunciare in quell’ottica specifica di mercato.
Quello che mi ha spinto a fare altro è che innanzitutto la maggior parte dell’intrattenimento puro si è spostato su altri media, e bisogna capire quale sia lo spazio specifico di pertinenza culturale dei libri. Sono dell’idea che l’unico spazio che hanno è l’approfondimento serio, lo spazio dello studio profondo, cosa che non condividono con nessun altro medium.
La maggior parte dell’intrattenimento puro si è spostato su altri media, e bisogna capire quale sia lo spazio specifico di pertinenza culturale dei libri.
Quando affronti il puro mainstream e il puro intrattenimento devi avere una grandissima penetrazione di mercato: il mercato attuale dell’economia libraria e la questione della gestione della distribuzione, delle copie, delle prenotazione e della gestione dei rapporti con le librerie, è un settore che si possono permettere solo le major che hanno poi degli interessi specifici anche nella distribuzione e nella promozione, senza considerare che hanno delle proprie catene di librerie, e possono imporre l’attenzione su determinate narrazioni che sono di loro natura blockbuster, mainstream, ecumeniche: insomma, funzionano su grandissima scala. O riesci a fare tutto questo, oppure è inutile metterci mano.
Se si vanno ad analizzare scientificamente i dati (cosa che purtroppo non sembrano fare i direttori di marketing delle grandi casi editrici), la crisi dell’editoria italiana non avviene su titoli di pertinenza specificamente libraria, quello spazio di approfondimento di cui dicevo prima, ma riguarda i primi posti delle classifiche settimanali. Io uccido di Faletti vendeva tre milioni di copie, ora quello spazio lo occupa I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, un titolo che vende tantissimo ma si assesta sulle ottocentomila copie vendute. Questa flessione sul primo in classifica – viene più che dimezzata la vendita netta, e il primo posto di oggi equivale al terzo posto di qualche anno fa – determina una flessione complessiva sulle case editrici più grandi, che mantengono la loro quota di mercato solo acquisendo altri marchi e diminuendo la quota. Come è successo con Mondadori e Rizzoli. È un caso curioso in cui la concentrazione editoriale mantiene la stessa quota acquisendo dei marchi: una situazione da cui emergono dettagli importanti e interessanti.
NP: Per esempio?
CM: La cosa più interessante dell’editoria italiana degli ultimi decenni è il fatto che ciclicamente ci sono state delle fondazioni di case editrici che nel tempo si sono ritagliate una propria identità e attenzione secondo un principio non di marketing largo ma di complicità, di progetto culturale che c’è in atto. Penso a minimum fax, a Isbn (che poi è andata come è andata), ultimamente pure case editrici come L’orma, di cui non si può non dire che le persone che ci lavorino siano le persone più competenti nella narrativa francese in Italia. Anche Atlantide, NN o Effequ e altre, sono queste le cose più interessanti accadute, sono gli esempi che rendono il comparto editoriale italiano vitale. Avendo un diverso approccio rispetto a quello classico, si scopre guardando i numeri che si possono fare delle strutture sostenibili con la possibilità inoltre di intervenire sul dibattito pubblico. A questo proposito volevo citare, come caso di studio, due cose che sono successe più o meno contemporaneamente e che mi hanno riguardato.
Da un lato come ha funzionato il romanzo di Stefania Auci: quella dei Florio era una storia che il pubblico aspettava, una perfetta storia di capitalismo etico, adattissima a quel tipo di mainstream, una storia che riusciva a dare un senso nostalgico, parlandoci di un’età dell’oro naufragata per tutta una serie di questioni intricate. Un what if? che permetteva di realizzare la possibilità di una forma di capitalismo etico e umano.A quel punto è successo però che si è smesso di poter parlare dei Florio senza citare Stefania: i Florio sono diventati Stefania Auci, attraverso un processo di personalizzazione tipico del mainstream.
Nel frattempo, dall’altro lato, si afferma la locuzione “realismo capitalista”, che oggi puoi usare sui giornali, in articoli, in una discussione, senza neanche spiegare la sua provenienza, il suo significato, perché è diventato un concetto entrato nel lessico collettivo, però spersonalizzandolo dal suo autore iniziale.
Avendo un diverso approccio, si scopre guardando i numeri che si possono creare delle strutture sostenibili con la possibilità inoltre di intervenire sul dibattito pubblico.
Questo doppio processo di personalizzazione e spersonalizzazione è un caso di studio secondo me molto interessante: penso innanzitutto che sia più incisivo il secondo processo, quello di spersonalizzazione. È un discorso che si può fare soltanto a partire da una posizione di svantaggio, come se giocassi sempre a carambola, ma la saggistica in questo momento credo stia offrendo la maggiore vitalità in termini di linguaggio collettivo, per quanto riguarda la sperimentazione tematica, linguistica, compositiva. Siamo arrivati a considerare la Theory Fiction un genere a sé stante, quando in realtà sotto questa definizione dovrebbero rientrare Le confessioni di Sant’Agostino e milioni di cose nella letteratura di ogni tempo. Noi stiamo incasellando sotto questa definizione tutte le cose più interessanti nella produzione culturale, proprio perché quella parte di intrattenimento di chi avrebbe fatto narrativa romanzesca è passata altrove, e chi avrebbe scritto dieci anni fa queste cose oggi sta scrivendo sicuramente un podcast, o una serie televisiva, o un programma televisivo.
NP: Intendevi questo, all’inizio, quando parlavi di “narrativa letteraria” come genere?
CM: Appunto: è diventato un genere a sé, del tutto astratto e che definisci di per sé secondo canoni frasali e mode specifiche, dei canoni di bellezza astratti per cui si stacca dalla narrativa di genere. Questo canone astratto è implicitamente aristocratico e implicitamente di destra.
EC: Ed è molto legato al discorso di personalizzazione dove tutto è basato sul brand dell’autore stesso…
CM: Si, anche se poi se vai a guardare bene la lingua letteraria media si è nettamente appiattita, quando si dice che qualcuno scrive particolarmente bene ed è “letterario”, è perché sta complicando un periodo che potrebbe risolversi molto più semplicemente.
NP: Non sono d’accordo. Restano ancora aperti nel romanzo, a mio avviso, spazi poetici che non sono mai stati premiati dal mercato, e forse non si premieranno mai. E va bene così.
CM: A proposito di poesia, ritengo che la poesia avrà uno spazio sostanziale nei prossimi dieci anni. Sarà un settore che recupererà molto spazio. Lo dico osservando i paesi stranieri e considerando che noi funzioniamo sempre con un delay rispetto all’estero.
NP: Su questo invece sono d’accordo. Quindi Timeo non si occuperà di narrativa?
CM: No, Timeo si occuperà anche di narrativa. Però il punto è sfuggire alle tassonomie semplificatorie del mercato librario. Nelle case editrici generaliste ci sono delle strettissime competenze. Un editor di narrativa italiana, di una grande casa editrice, deve fare sette romanzi l’anno e magari sono sette romanzi storici. Una casa editrice, per esempio, anche se si dedicherà esclusivamente alla narrativa sportiva dovrà sempre fare un tot di numeri.
NP: Puoi spiegare meglio questo aspetto, la necessità dei numeri?
CM: L’editoria non è letteratura. Quello che fai è connaturato a quello che sei. Se io domani volessi iniziare a stampare e distribuire delle cose lo potrei fare da solo con una fotocopiatrice. Nel momento in cui decido che dobbiamo essere più persone e determinare una struttura professionale in cui c’è un editor, un direttore commerciale, un ufficio stampa, tutto ciò determina dei costi, costi che vanno tradotti in un numero di copie che devo vendere per un prezzo medio che devo impostare. L’editoria ti impone di entrare in determinate dinamiche, quindi se gestisco una casa editrice che ha determinate dimensioni, o faccio un tot di titoli di venduto alto che mi coprono tutte le spese oppure devo allargare il numero di titoli per potermi abbassare il venduto medio. Questa è una cosa un po’ trita, ma è risaputo che il sistema delle rese spinge le case editrici alla sovrapproduzione. D’altro canto le stesse librerie sono divise per tassonomie specifiche in cui c’è marketing, economia, storia, filosofia, musica, come se fossero degli ambiti di pertinenza diversissimi e come se esistessero lettori che leggono solo romanzi inglesi, libri di economia ecc. Si tende quindi, assecondando la posizione in libreria, a fare dei piani editoriali molto stretti che stiano insieme e finisci per avere case editrici il cui carattere è determinato da quel che si trovano a pubblicare, mentre invece con Timeo vorremmo fare la cosa opposta, pubblicare secondo le nostre convinzioni politiche, secondo nostre convinzioni di rappresentazione; abbiamo deciso quindi di avere un solo formato che guida l’intera casa editrice, ma di cambiare ogni volta radicalmente le modalità di rilegatura, le quarte di copertina e la stampa, così da considerare pienamente la grafica, la merceologia di un oggetto, come una pratica significante. Ad esempio, un libro come Deep Listening che è un preziosissimo eserciziario deve essere un cartonato di quel tipo. Mentre invece su Tommaso Moro abbiamo fatto una copertina fantascientifica, usando uno specchio che “parla” di Le Guin e Mieville in contrapposizione a un lettering “medievale”, dopodiché abbiamo recuperato l’isola centrale da un videogioco, e l’abbiamo seppiata come se fosse stata incisa su una pergamena. Mentre il White Paper di Satoshi Nakamoto invece lo abbiamo fatto come se fosse una Bibbia, perché è la Bibbia dei Cripto Bros, il testo fondativo di ogni cosa.
EC: In questo momento il vostro piano è quello di sfuggire alle necessità tassonomiche anche grazie ai finanziamenti pubblici?
CM: I finanziamenti pubblici sono stati al massimo una facilitazione per l’accesso al credito, ma bisogna comunque restituirli. In una normale economia di mercato questa cosa l’avrebbe fatta una banca senza essere parata dall’Unione Europea. Non avere però fondi privati ci costringe a entrare a regime in un tempo molto più breve: mentre stando al manuale del buon editore uno può sperare che le cose inizino a trovare un punto armonico a tre anni, per noi questo tempo sarà molto più ridotto.
EC: Quindi diresti che si tratta di un “sacrificio” per motivi politici? Speravo aveste trovato un sistema per sfuggire a certe logiche, invece mi pare di capire che non sia così…
CM: Si tratta più che altro di evitare certe logiche all’interno di determinate strutture. Il contesto di produzione determina il cosa fai e il come lo fai: non è detto che se stiamo facendo la stessa cosa per motivi diversi allora non possiamo arrivare a comporla ugualmente. Secondo me una casa editrice di saggistica deve avere una presenza nel dibattito e questo significa una quantità di cose fatte, di libri pubblicati. Con Not riuscivamo a farne cinque, sei l’anno, perché c’era Nero accanto che seguiva le sue dinamiche. Noi vogliamo fare esclusivamente questo, pubblicare libri, quindi amplieremo il piano editoriale a quindici libri l’anno già dal 2023, sperando di riuscire ad avere sempre più presenza; non strettamente editoriale ma culturale, la possibilità di un discorso culturale più articolato, con la libertà che può nascere da un collettivo orizzontale, libertà di discussione immediata e risoluzione di problemi comuni. Questa cosa ideologica la vogliamo un po’ dimostrare su più piani: una cosa è la struttura che stiamo tentando di costruire, ridisegnandoci da capo le pratiche lavorative, i posti di lavoro. Per esempio: non mi stanno simpatici i direttori commerciali, e infatti non li abbiamo, perché quel lavoro si può dividere altrimenti. Era una sperimentazione che avevo già fatto in Not e che sto portando avanti in maniera più radicale. O di dividerci completamente l’ufficio stampa, perché avendoli decisi tutti insieme i titoli, tanto vale andare a parlarne noi.
Nelle case editrici che hanno la proprietà classica gli obiettivi sono diversi. Prendi Mondadori: anno record ma hanno licenziato tantissime persone, abbassato i compensi per i redattori esterni, e nel frattempo chiedono agli operativi interni di aumentare il carico di lavoro del 10-15%. Qual è l’obiettivo? Diventare il più grande hub di creazione di contenuti al mondo, sostituire Netflix, Google e conquistare l’universo?
Il nostro obiettivo è lavorare tanto per assumere un’altra persona, e non fare più libri del necessario. Farci dei contratti migliori e assumere una persona alle stesse condizioni… abbiamo prospettive diverse, cerchiamo di creare una struttura sostenibile all’interno del mercato editoriale.
NP: Parliamo allora delle persone che fanno Timeo.
CM: C’è Federico Campagna, scrittore, filosofo, ha pubblicato in Italia con TLON e in Inghilterra con Bloomsbury e lavora come rights manager per Verso Books, invece per noi fa l’acquisition editor. Poi c’è Federico Antonini come art director, che ha curato molti cataloghi e mostre, pubblicato con Corraini, e insieme al quale avevo già lavorato per fare Not. C’è Assunta Martinese, che lavora come redattrice per minimum fax, e per noi fa la revisione delle traduzioni, perché è anche una traduttrice straordinaria, come si può vedere nel lavoro fatto con l’opera di Sadie Plant per LUISS University Press.
E poi c’è time0.zone che è anche la trasposizione di questa forma dialogica: una risposta provvisoria all’interrogativo sulla presenza in rete ideale di una struttura culturale come la nostra, che per via verticale ha detto ciò che deve attraverso i libri che ha fatto.
EC: Parliamo di time0.zone, infatti. Quando ad esempio su Facebook si cerca di fare riflessioni critiche o per intenderci anticapitaliste, arriva sempre chi dice: “Però queste cose le scrivi su Facebook?!”. Obiezione ingenua e spesso in malafede, ma che riassume i limiti dell’utilizzo critico di piattaforme in mano a privati. time0.zone ha anche l’ambizione di offrire una piattaforma alternativa ai social media per come li conosciamo adesso? E a che pubblico vi rivolgete, chi sperate arrivi ad animarla?
CM: Nel momento in cui siamo una nazione di circa sessanta milioni di abitanti e un libro che diciamo che è andato bene ha venduto al massimo diecimila copie: quello è il pubblico. Ed è il motivo per cui vi dicevo che tramite questo tipo di saggistica le cose riusciamo a farle arrivare di rimbalzo al grande pubblico, in maniera quasi anonima se ci riusciamo, perché vengono fagocitate da un cognitariato più o meno produttivo che poi le rimette in circolo sotto altre forme: penso a Donna Haraway, ad esempio, e alle mostre che ha generato. Mi ha molto stupito essermi ritrovato al centro sociale La Strada, con tutti i circoli accelerazionisti che si sono formati in giro per l’Italia, da Bari, dalla Sardegna, a Roma per incontrarsi, sulla base di alcuni libri che avevamo pubblicato. Poi non ero d’accordo su nulla di quello che dicevano quei ragazzi lì, ma è stata per me una cosa molto bella, mi ha fatto riflettere perché ho girato l’Italia presentando questi libri, in situazioni scollegate tra loro, in una forma di autismo in cui ognuno fa il proprio; e ora hanno trovato, secondo alcune perverse pieghe, un legame in certi libri. A questo punto perché non tentare di usare questi libri come un collante di un discorso collettivo che possiamo definire nostro?
Qual è l’obiettivo dei grandi gruppi editoriali? Diventare il più grande hub di creazione di contenuti al mondo, sostituire Netflix, Google e conquistare l’universo?
EC: A proposito di Donna Haraway: un sacco di temi e discorsi di “theory” sono confluiti abbastanza facilmente nel mondo dell’arte. E tanti che si occupano di queste cose si rivolgono a fondazioni e gallerie per poter transitare in quell’ambito lì, dove ci sono evidentemente più soldi. Viceversa il mondo eterogeneo dei centri sociali sembra essere molto lontano da quell’ambiente, che invece sussume parte dei loro discorsi rivolgendosi però a tutt’altro pubblico e circuito. Puntate alla convergenza fra questi due mondi? O vi interessa di più la costellazione “dal basso” di cui parlavi?
CM: Parlerei più a quella costellazione ma non soltanto, quelle sono solo le parti più evidenti e organizzate. Poi ci sono collettivi artistici che fanno pratiche diverse da quelle strettamente museali, fanno qualcosa più strettamente inerente alla politica e non al mercato. Per questo dico che il contesto in cui produci certe cose determina anche cosa stai producendo. Se il tuo punto è convincere anche un singolo gallerista, sfugge la funzione culturale di quello che stai facendo. Dall’altro lato se è vero che non c’è un Indymedia, è anche vero che non c’è più – a causa di un processo di specializzazione iniziato negli anni Settanta e Ottanta nelle grandi case editrici – una struttura editoriale aperta come Einaudi (penso ai mercoledì in cui potevi andare e visitare la redazione), non c’è più una casa editrice aperta come Feltrinelli, non ci sono più case editrici di bandiera. Le riviste culturali, e ancora di più le newsletter, sono monodirezionali. Addirittura si sono tolti i commenti perché era una cosa che non si voleva gestire e si rimanda tutto il dibattito a Facebook. Oppure, parlare con le case editrici è una cosa misteriosa in Italia: trovare un referente o una mail che ti risponda davvero. Il lavoro culturale a mio avviso dovrebbe essere completamente l’opposto, oggi è un lavoro elitario, verticale e anti-dialettico. L’obiettivo invece dovrebbe essere riuscire a passare dal consenso alla complicità, dal like al dialogo, dovrebbe essere questo il compito centrale del lavoro delle strutture di produzione culturale.
NP: Quello che dici mi sembra agganciarsi ai tempi in arrivo, stiamo vivendo la fase terminale del mondo social nato dieci-quindici anni fa. Facebook è un vespaio mezzo morto, Twitter si sta sfasciando, mentre i social che hanno un futuro sembrano quelli che non sono agganciati alla produzione di testi ma a quella di estetiche. È come se fossimo alla fine di un episodio di delirio, anche se non escludo che ne siano in arrivo di nuovi. È finita però l’età dell’ingenuità nell’utilizzo dei social, non si può più fingere di ignorarne i meccanismi…
CM: Però a volte si continua a ignorarne i meccanismi. A me fanno impazzire cose tipo la retorica di Repubblica, “I giovani non leggono abbastanza, non capiscono un testo complicato”, e poi il fenomeno più rilevante degli ultimi anni sono i booktoker, che hanno portato case editrici serie come Sellerio e Laterza ad aprirsi un account TikTok, senza rendersi conto di non avere gli strumenti per dominare quello spazio e producendo una posizione grottesca. Non tutto può essere traslato in ogni dove. È il problema dei programmi culturali sui libri in televisione: su RaiPlay ci sono cose dignitose, ma perché le fanno con un altro piglio, ma “Splendida cornice” con Geppi Gucciari, che dovrebbe essere lo spazio dei libri, poi finisce per invitare Ermal Meta e usare quello spazio per spostare le cose su un binario diverso. Credo sia più utile rinunciare a questo piano e riportare le cose a un livello di complicità e di dialogo. Adesso abbiamo fatto un calendario con gli eventi da mettere su time0.zone perché mi interesserebbe molto avere Marta di Bologna che mi scrive per chiedermi che concerti ci sono.
EC: Oltre agli eventi, time0.zone lo userete anche come rivista? C’è anche una specie di blog, giusto?
CM: La parte blog la dovremo sbloccare ai singoli utenti che ce ne fanno richiesta. Non intendo che ci sarà una selezione dei contenuti stringente, non controlleremo nessuna delle cose che verranno pubblicate. In quella sezione stiamo anche tentando di affrontare la questione termini di servizio delle piattaforme: secondo la quale se Facebook volesse fare un libro con le foto delle vacanze potrebbe farlo, o se Medium volesse pubblicare un libro con le cose scritte da te in teoria potrebbe farlo, senza chiederti nulla. Dentro time0.zone c’è la possibilità di timestampare l’articolo e di fare afferire la proprietà intellettuale a chi lo ha postato, anche per rivendicare la proprietà intellettuale di un contenuto postato da un account fake. Infatti non chiediamo email definitivi, nomi e cognomi, per evitare la customizzazione social che porta alle classiche minacce “Dimmi come ti chiami che ti denuncio”.
Riuscire a passare dal consenso alla complicità, dal like al dialogo, dovrebbe essere il compito centrale nel lavoro delle strutture di produzione culturale.
NP: Qual è stata la prima reazione del pubblico di lettori? Cosa sta succedendo in queste settimane?
CM: C’è grande affetto da parte dei librai, dei lettori e delle lettrici. Le nostre presentazioni sono state molto partecipate e si stanno creando delle belle discussioni. Forse anche la formula con cui abbiamo presentato Utopia ha funzionato. Praticamente ho considerato che la cosa più noiosa che possa esistere al mondo sono io che parlo per un’ora e mezza di Tommaso Moro. E in considerazione del fatto che il libro lo abbiamo pubblicato dicendo che l’utopia non è vero che è una cosa che non si realizza, e basta vedere ciò che accaduto con il colonialismo inglese, andiamo a vedere quali sono le pratiche iperstizionali e utopiche che già mettiamo in atto tra di noi, nel nostro privato, sotto forma associativa, artistica. Quindi arrivo in una città e faccio venti inviti ad associazioni, artisti e militanti e dico che è un invito aperto e se dunque vogliono portare altre persone è bene che lo facciano e che non ci sarà una lista di interventi e che sostanzialmente ci sarà un microfono aperto. Tentando quindi di non fare polemica politica ma dire semplicemente quello che si sta facendo. A Palermo è venuta Mediterranea a parlare del soccorso in mare, è venuta TerraTerra a parlare di agricoltura biologica e sono venute le Ragazze del Mercoledì del Piacere. A Milano si è parlato più di transizione e di senso utopico, è stata una discussione molto diversa. L’idea era quella di presentazioni molto partecipate e molto sentite.
NP: Interessante che a Palermo si parlasse di piacere mentre a Milano, nonostante il rispetto profondo e l’ascolto di cui abbiamo goduto, ci fosse invece un’atmosfera più grave e pensierosa, da cui si può intuire lo stato di salute di un pezzo di città. Immagino che grazie a Utopia tu abbia visitato realtà che danno risposte molto diverse.
CM: A Palermo c’era quella sensazione di fare la cosa per qualcun altro, a Milano invece un vorrei ma non posso. A Palermo la cosa è stata fatta da BK, una biblioteca di quartiere autogestita a La Kalsa, pieno di bambini che vanno lì a fare doposcuola. A Milano invece la presentazione è avvenuta da KINLab, che è un posto avanzatissimo a livello di teoria, in cui tutte persone di collettivi queer hanno trovato il modo di riunirsi ma in uno spazio di co-working, e questo già è significativo: quello che un tempo sarebbe stato un gruppo di affinità politica e di produzione culturale complessiva, si riunisce per fare ognuno la propria commessa. Ed è amaro.
EC: Per concludere, vuoi raccontarci brevemente i titoli e le prossime uscite?
CM: Il prossimo titolo sarà Disertate di Bifo, che poi per noi è anche uno dei migliori libri scritti da Bifo negli ultimi anni, per quel mix di speculazione filosofica, esortazione politica, pagine di preoccupazione civile, pagine di autobiografia e di riattualizzazione della sua stessa filosofia in virtù del suo vissuto. Poi faremo Filosofia della cura di Boris Groys che ragiona su cosa sia il corpo fisico e il corpo simbolico, nostro, comune e collettivo e di come vengono governato l’uno e l’altro dalle strutture di potere che abbiamo intorno. Poi Jane Bennett, penso la cosa di filosofia femminista più avanzata che c’è in questo momento – assurdo non sia stato ancora pubblicato in Italia, poi Cruel Optimism di Lauren Berlant che uscirà a giugno a due anni dalla scomparsa dell’autrice, un libro fondamentale soprattutto per la discussione che era venuta fuori a Milano. Faremo Andrea Bellini, il direttore di arte contemporanea del centro di Ginevra, che ha già scritto un libro che si intitola Storie di arte contemporanea: è un libro di racconto a là Flaiano, di vigliaccherie e miserie dell’arte contemporanea facendole coincidere con la storia dell’arte contemporanea in sé.Sempre per quanto riguarda gli italiani, nel 2024 pubblicheremo un libro di Claudio Kulesko intitolato Il pensiero suicida. Poi avremo Isole, un libro di racconti di Nicolás Jaar davvero sorprendenti, e poi abbiamo preso Undrowned di Alexis Pauline Gumbs, una meditazione poetica sulla relazione tra i mammiferi marini e il femminismo nero che uscirà a luglio. Stiamo tentando, insomma, di impostare un piano editoriale che sappia costringerci a rincorrere continuamente noi stessi.
