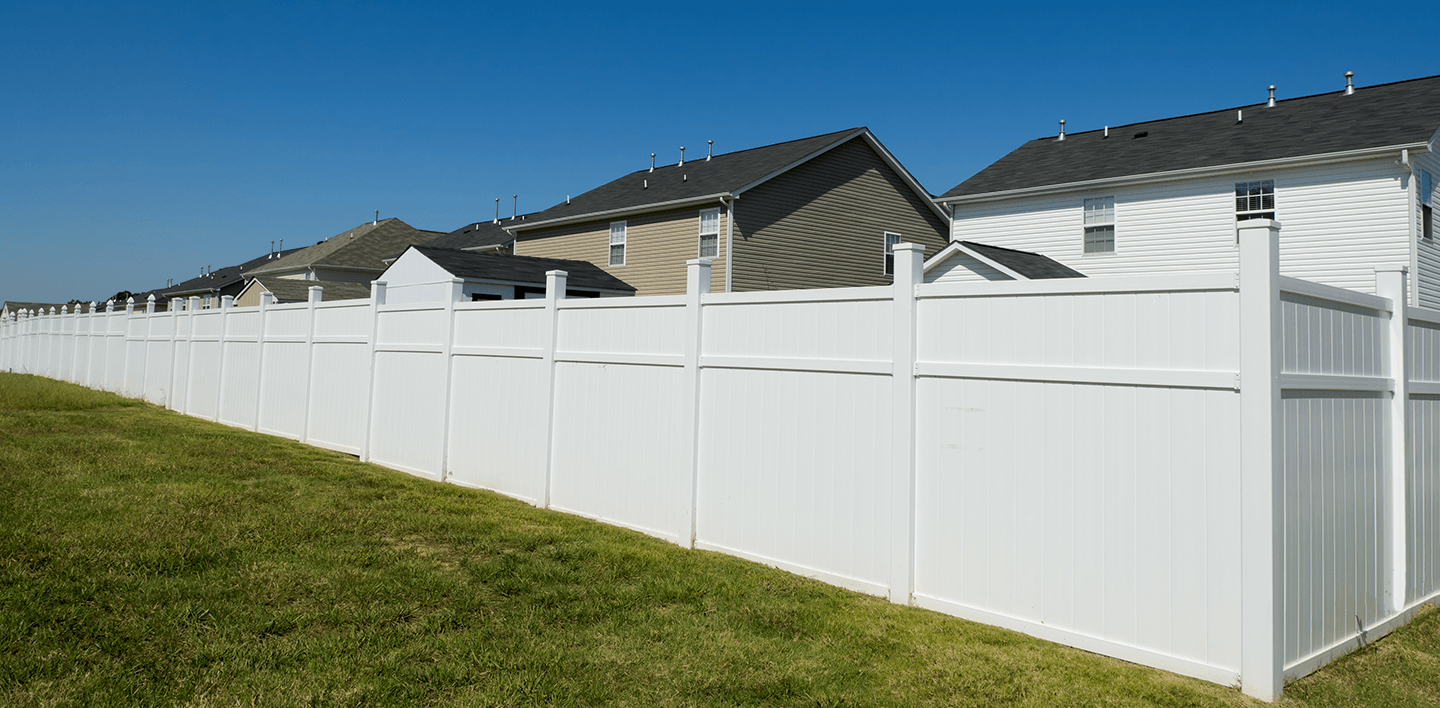
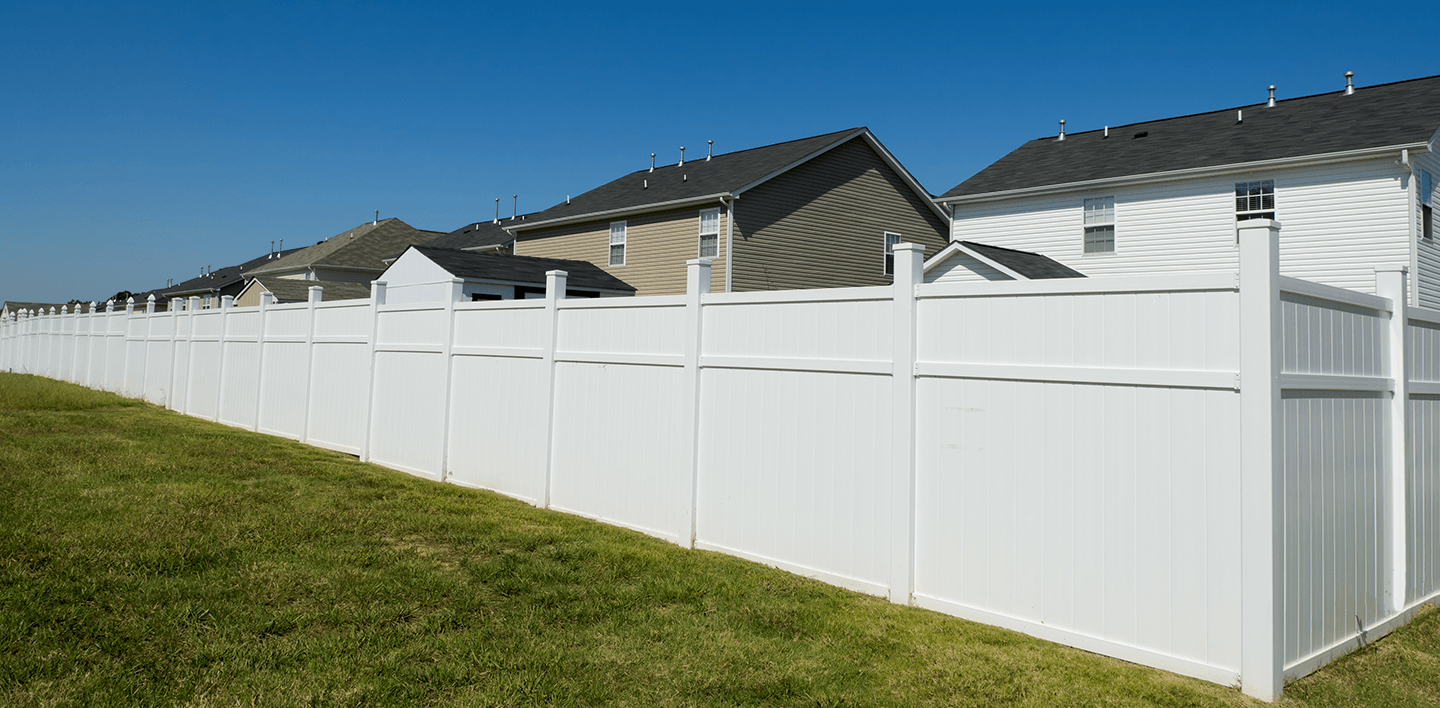
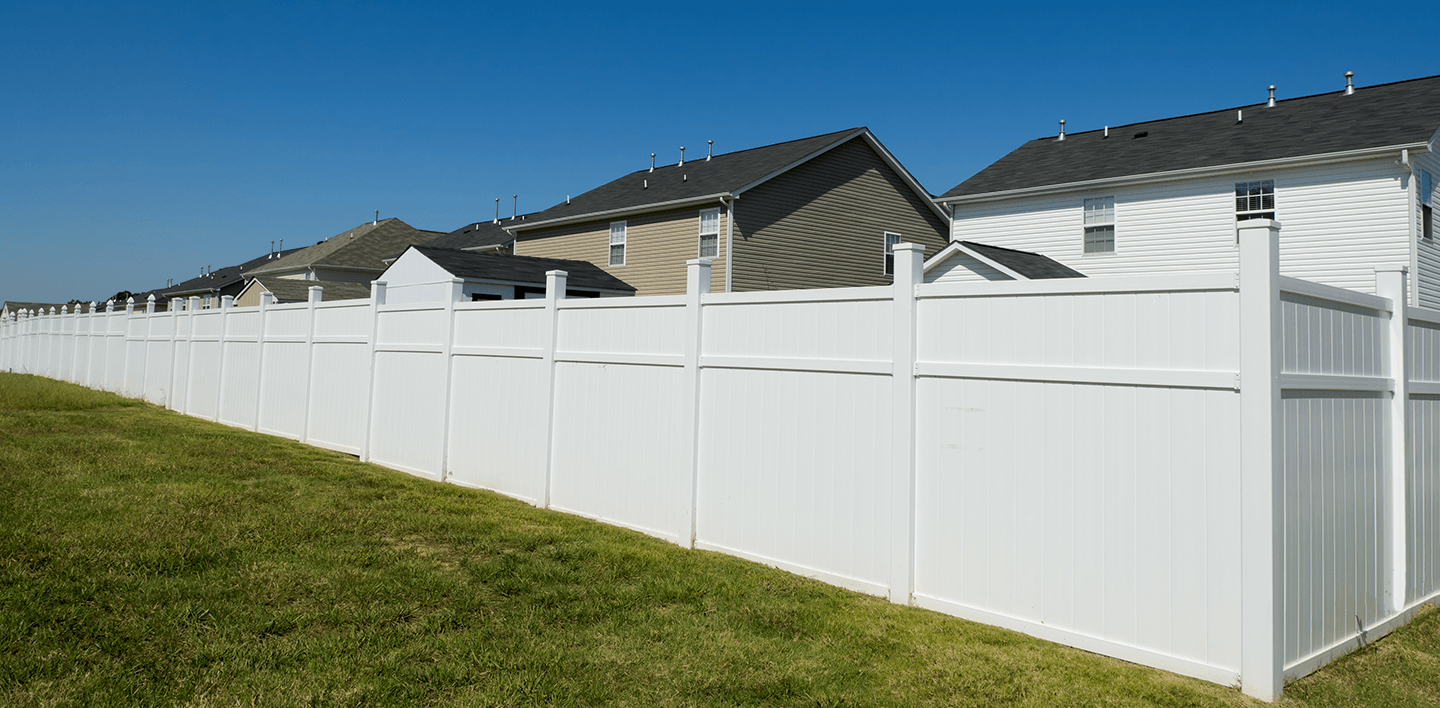
I
l 27 aprile scorso, al Brookings Institute di Washington, è stato pronunciato uno dei discorsi più commentati di questi anni. L’oratore non era nessuno di celebre, né un Presidente, né un leader di partito, né un Papa. Il suo nome era – è – Jake Sullivan e nella vita fa “soltanto” parte dello staff dell’amministrazione Biden. Nello specifico il discorso di Sullivan presentava le linee guida della presente e futura politica economica degli Stati Uniti (da alcuni ribattezzata Bidenomics) e tra le altre spiccavano frasi come: La visione di investimenti pubblici che aveva dato energia al progetto americano negli anni del dopoguerra – e in effetti per gran parte della nostra Storia – era svanita. Aveva lasciato il posto a una serie di idee che sostenevano il taglio delle tasse e la deregolamentazione, la privatizzazione rispetto all’azione pubblica e la liberalizzazione del commercio fine a sé stessa
E ancora: Ora nessuno – certamente non io – sta scontando il potere dei mercati. Ma in nome di un’efficienza di mercato eccessivamente semplificata, intere catene di approvvigionamento di beni strategici, insieme alle industrie e ai posti di lavoro che li hanno realizzati, si sono spostate all’estero. E il postulato che una profonda liberalizzazione del commercio avrebbe aiutato l’America a esportare beni, non posti di lavoro e capacità, era una promessa non mantenuta
Queste parole hanno spinto numerosi commentatori, anche molto autorevoli, a definire l’intervento di Sullivan come una “pietra tombale” sul neoliberismo, la “dottrina” economica a cui si imputano i problemi di (in)giustizia sociale e ridistribuzione della crescita emersi nei paesi avanzati negli ultimi decenni.
Le parole di Sullivan hanno spinto numerosi commentatori, anche molto autorevoli, a definire il suo intervento una “pietra tombale” sul neoliberismo.
Detto che tali disuguaglianze sono innegabili e che molte di esse hanno radice nel modello teorico di riferimento, vale la pena chiedersi se davvero il discorso di Sullivan sia una “pietra tombale” su di esso. Soprattutto se lo sia per le ragioni che alcuni hanno individuato. Peccando di wishful thinking, nelle ultime settimane, innumerevoli analisi hanno infatti voluto scorgere nelle parole di Sullivan un giudizio etico-politico, e una resa dei conti, filosofica e culturale, col “neoliberismo”. Un giudizio e una resa dei conti che il discorso non contiene. Può sembrare una questione di lana caprina ma non lo è. Se si fa confusione su questo punto, non solo si rischia di fraintendere il presente ma anche il contesto storico in cui il neoliberismo riuscì ad ascendere a cavallo tra anni Settanta e Ottanta del Novecento.
Ma andiamo con ordine. Cosa si intende per Bidenomics? Essenzialmente l’idea che lo Stato torni a intervenire (e investire) in materia di politiche economiche e industriali, proprio come faceva nei decenni “keynesiani” del dopoguerra (“la visione di investimenti pubblici” di cui sopra). Scopo primario di questa politica è di restituire una prospettiva a quella classe media occidentale che, più di tutte, ha subito il contraccolpo della iper-globalizzazione di fine Novecento-inizio Duemila. Come hanno dimostrato fenomeni quali Trump e Brexit, l’erosione della sicurezza economica delle classi medie occidentali – un fenomeno connesso allo spostamento della bilancia dei rendimenti dal lavoro ai capitali, dalla produzione agli investimenti – non ha ingenerato solo problemi socio-economici ma anche culturali e di governance. Come l’ha definita senza giri di parole Sullivan, la Bidenomics è una “politica per la classe media”. Un’enfasi sul “per”, come fosse una sorta di servizio, molto più esplicita rispetto a quella “politics of the middle class” con cui nel 2016 si era presentata, e aveva perso le elezioni, Hillary Clinton.
Il recupero, economico e politico, della middle class americana, che da anni va verso derive sempre più problematiche, è, come detto, una delle prerogative più spiccate della Bidenomics. E lo è perché non sono rimaste alternative al dare una risposta all’insofferenza dei ceti medi. Se non si vuole che salti definitivamente il tappo della “più grande democrazia del mondo”, non è più prorogabile l’imperativo di calmare le acque dentro la bottiglia.
La domanda semmai è: chi pagherà il costo di questo enorme progetto, che richiederà di fatto coperture finanziarie colossali? E soprattutto, aldilà della retorica, in che modo esso dialoga con il cosiddetto “green deal” e con quale profondità? Le risposte a queste domande determineranno non solo la fattibilità e il successo dell’intera “operazione” ma anche la sua dimensione concreta, aldilà della retorica. Un successo che, ovviamente, è legato anche alla continuità politica di Biden. Se dovesse perdere le prossime elezioni, è probabile, se non certo, che il suo successore invertirà la direzione del processo.
Il recupero, economico e politico, della middle class americana è una delle prerogative più spiccate della Bidenomics. E lo è perché non sono rimaste alternative al dare una risposta all’insofferenza dei ceti medi.
Il discorso di Sullivan dedicava inoltre grande spazio alla dimensione internazionale dell’economia. In particolare, presentava un nuovo piano di governance economica globale: un “nuovo Washington Consensus”, di segno opposto all’originale. Laddove quello perorava un’iper-liberalizzazione di merci e capitali, e l’integrazione in un singolo grande mercato, al cui interno ogni Stato svolgeva funzioni commisurate al suo grado di sviluppo socioeconomico, il “nuovo Washington consensus” propone il ritorno a economie interne più autarchiche e bilanciate, meno interdipendenti e più prudenti in termini di flussi di capitali, cose e, soprattutto, tecnologie. Si tratta di un ripensamento dei principii del trentennio 1980-2010 di iper-globalizzazione ed è, tra tutti i punti toccati da Sullivan, quello che maggiormente giustifica la tesi che la Bidenomics rappresenti un’abiura concettuale del “neoliberismo”.
Ma perché la prima economia al mondo decide di allontanarsi dalle idee che hanno caratterizzato, bene o male, gli ultimi decenni della sua crescita? La risposta è nella “job description” di Sullivan. Nonostante la natura del luogo in cui parlava, Sullivan non è un consulente del Tesoro, della FED o di un’altra grande istituzione finanziaria. Il suo titolo è “National Security Advisor”. Non è uomo di calcoli ed economia ma di legge e diplomazia. Il suo percorso racconta una carriera tra campagne elettorali e negoziati internazionali, tra cui l’accordo sul nucleare iraniano. Cosa ci faceva un simile personaggio al Brookings, ovvero uno dei più importanti think tank economici dell’Occidente? La risposta è che il mondo, in questi ultimi anni, è cambiato al punto che l’economia – neppure la prima al mondo (anzi, soprattutto la prima al mondo) – non può più permettersi di vivere in un regno a parte, rispetto alle preoccupazioni della sicurezza e della difesa.
Le ragioni del cambiamento le ha spiegate lo stesso Sullivan: Ignorare le dipendenze economiche che si sono costituite nei decenni di liberalizzazione è diventato troppo pericoloso – dall’incertezza energetica in Europa alle vulnerabilità nelle filiere medicinali, dei semiconduttori e dei minerali critici. Questi sono i generi di di dipendenze che possono essere sfruttate per ottenere leva economica o geopolitica.
Come scrivo nel mio libro La signora delle merci (LUISS University Press), le prime avvisaglie di questa vulnerabilità si sono fatte sentire durante la pandemia. Quando si è, per esempio, scoperto che la produzione di principi attivi farmacologici è ormai concentrata quasi solo in pochi distretti produttivi asiatici (principalmente in Cina e India). Una volta finiti in lockdown questi distretti, si è rischiata l’interruzione di filiere farmaceutiche da cui dipendeva la produzione di farmaci da banco quanto salvavita. Il covid è stata una fatalità ma la situazione ha aperto gli occhi sui rischi di sabotaggi e ricatti sanitari (la “leva geopolitica” di cui parla Sullivan) che comportano simili strutture produttive, figlie delle politiche industriali promosse dal Washington Consensus.
Perché la prima economia al mondo decide di allontanarsi dalle idee che hanno caratterizzato gli ultimi decenni della sua crescita?
Sebben Sullivan la nomini quasi solo indirettamente, il “rimosso” che aleggia sul suo discorso, e ne tiene insieme i diversi lembi, è ovviamente la Cina. La cui ascesa è figlia di quelle stesse politiche industriali. A partire dal 1979 – anno della svolta di Deng Xiaoping – è stata infatti l’inclusione del gigante asiatico nelle filiere industriali della globalizzazione a innescare il processo di crescita che, oggi, rende la Cina la più seria candidata a rimpiazzare gli USA nella scala egemonica globale.
Come ammette Sullivan, quell’inclusione fu frutto di un calcolo che a posteriori si è rivelato errato. Ovvero che, col tempo, le logiche dell’integrazione economica avrebbero portato anche a un’omogenizzazione dei sistemi politici, smussando quindi le “caratteristiche” del “socialismo” cinese meno compatibili con l’Occidente. Ciò non è evidentemente avvenuto. Anzi, con Xi Jinping, la Cina ha intrapreso una Machtpolitik che ormai non si limita più soltanto alla crescita del benessere ma ha chiare ambizioni “geopolitiche”. Ambizioni che dipendono, anche, dalla continuità nella traiettoria di sviluppo, economico e tecnologico, del gigante asiatico. Una traiettoria rispetto alla quale, la Bidenomics punta a mettersi di traverso con provvedimenti come l’ormai famigerato CHIPS and Science Act.
Nel suo discorso Sullivan ha ribadito la necessità di continuare sulla stessa linea. Il che, ha precisato, non significa tuttavia smettere di fare affari con la Cina. Anche perché, a conti fatti, negli ultimi mesi una politica di totale decoupling (disaccoppiamento) si è rivelata impossibile e, anzi, osteggiata da forti gruppi d’interesse sia in USA che in Europa. La nuova parola d’ordine, nelle ultime settimane, è dunque diventata derisking. Non un “protezionismo” generico, dunque, ma tanto mirato quanto rigido. È questo il senso dell’espressione “small yard, high fences” (“cortile piccolo, steccati alti”) con cui Sullivan ha definito la politica di controlli sulle esportazioni hi-tech che Washington intende imporre alla Cina.
Date queste considerazioni, più che come una “pietra tombale” sul neoliberismo, o un’abiura concettuale dei suoi presupposti, il discorso di Sullivan ci appare per ciò che è. Ovvero il tentativo dell’egemone in carica, di rintuzzare, con ogni mezzo, le aspirazioni del suo principale sfidante. Più che una politica economica, il Washington Consensus risalta come una “politica politica”, una politica in cui le prerogative del mercato vengono riconsiderate alla luce di quelle del puro potere (si veda in tal senso il concetto di “capitalismo politico” sviluppato in questi anni da Alessandro Aresu). E del resto come scriveva lo stesso Adam Smith, nume di ogni liberista: “la difesa conta più dell’opulenza”.
La cosa interessante di questa lettura “realista” dell’attuale transizione di modello è che essa ci aiuta a leggere, e rivisitare sotto una nuova luce, anche quella che, ormai più di quarant’anni fa, portò all’ascesa del cosiddetto “neoliberismo”. Un’ascesa che viene spesso presentata come frutto di una mera ingordigia di profitti da parte di élite imprenditoriali, manageriali e finanziarie che, in qualche modo, riuscirono a dirottare Washington (e a cascata a Londra etc) verso una “dottrina” economica in realtà profondamente antipolitica e anti-Stato.
Più che una politica economica, il Washington Consensus risalta come una “politica politica”, una politica in cui le prerogative del mercato vengono riconsiderate alla luce di quelle del puro potere.
La realtà è che l’ascesa del “neoliberismo” fu preceduta da quasi un decennio d’impasse e profonda incertezza, non solo socioeconomica ma anche geopolitica. Un’incertezza legata essenzialmente a tre fenomeni chiave degli anni Settanta: l’inflazione della sterlina e del dollaro, la fine di Bretton Woods e l’aumento del costo dell’energia, connesso alla crisi del ’73 e ai sabotaggi OPEC durante la guerra dello Yom Kippur. Nel loro insieme questi fenomeni minacciavano di compromettere l’ordine egemonico del tempo, in senso politico quanto economico. Basti ricordare come, tra anni Settanta e Ottanta, l’economia americana fosse stata superata in produttività da quella tedesca e giapponese. Per non dire che, con la fine degli accordi di Bretton Woods, la posizione del dollaro nei meccanismi finanziari internazionali era tutto fuorché chiara ed assicurata. A questo si aggiunga che, negli anni Settanta, la Guerra Fredda era in pieno svolgimento, seppure in una fase interlocutoria, e la rinascita del panarabismo aveva reso scaldato il fronte mediorientale. Il tutto mentre il disastroso conflitto del Vietnam aveva messo in discussione, anche sul piano morale, il primato militare americano, ereditato dalla Seconda Guerra Mondiale.
Negli anni Settanta era dunque grande la confusione sotto il cielo. Un aumento di entropia sociopolitica che, in quasi tutto l’Occidente, si tradusse tra l’altro nell’emergere di varie spinte eversive. Una confusione da cui sembrava, già allora, sul punto di sbocciare un nuovo ordine geopolitico. Dal punto di vista degli USA, la cosa più “preoccupante” era che, di fronte alla complessità di questa “policrisi”, il modello macroeconomico keynesiano non sembrava più in grado di fornire risposte. Di fatto si aveva la sensazione di essere giunti all’esaurimento di un ciclo e della sua inerzia.
Fu da quel crogiolo problematico che, attraverso una lotta intellettuale e politica endogena ai vertici accademici della teoria economia (una lotta ben raccontata dal libro The Economist’s Hour), negli Stati Uniti emerse il cosiddetto “noeliberismo”. Una dottrina che riprendeva concetti sviluppati nell’Europa degli anni Venti, considerati a lungo carboneria in USA e tenuti in vita soltanto grazie a un indefesso lavoro di promozione ed evangelizzazione di alcuni think-tank e del dipartimento di economia dell’Università di Chicago. L’atto con cui il “neoliberismo” prese il potere fu il “Volcker shock” del 1979, quando il direttore della FED Paul Volcker decise un rialzo dei tassi d’interesse che, implicitamente, rappresentava l’abiura dello status quo keynesiano e dei suoi assunti riguardo al rapporto tra deficit, investimenti e moneta.
Rompendo, attraverso la estraniazione della Banche Centrali, il meccanismo di traduzione dell’azione politica in assistenza economica, il Volcker shock stimolò indirettamente la ricerca di maggiori efficienze produttive nel settore industriale. Fu da questa congiuntura che nacque, di fatto, la globalizzazione delle supply chain, ovvero il mondo in cui abbiamo vissuto negli ultimi decenni, in cui tutto si produce cercando di spremere il massimo da ogni centesimo investito. Il mondo del primo Washington Consensus. Che, del resto, non fu che una manovra politico-finanziaria per garantire l’apertura di nuovi mercati del lavoro sottocosto nel Global South e, attraverso essa, la capillare diffusione del dollaro.
Il neoliberismo ascese poiché, in primis, la politica americana riconobbe la pericolosità della crisi economica degli anni Settanta e la sfida che essa rappresentava per la sua egemonia e la sua sicurezza.
Quello che va ribadito è che il primo motore immobile di questo meccanismo non fu soltanto la “ragione economica” o gli interessi specifici delle elité industriali e/o finanziare. Il neoliberismo in altre parole non ascese soltanto perché una ristretta cerchia di privilegiati decise di arricchirsi. Ascese poiché, in primis, la politica americana riconobbe la pericolosità della crisi economica degli anni Settanta e la sfida che essa rappresentava per la sua egemonia e la sua sicurezza. Nel momento in cui la “vecchia” ricetta keynesiana non si dimostrò in grado di dare soluzioni adeguate alla crisi, Washington decise di affidarsi a una nuova “medicina” (la metafora del neoliberismo come medicina amara ma efficace era ampiamente circolata all’epoca, a cominciare da Milton Friedman). E fu la politica americana a deciderlo. In primis per estendere la longevità della sua influenza economica e finanziaria nel pieno della Guerra Fredda.
L’ascesa del neoliberismo fu dunque anche, se non soprattutto, un riflesso di una svolta nelle politiche di potenza degli Stati Uniti. La stessa cosa si può dire oggi della Bidenomics. Se essa dovesse riuscire ad affermarsi – cosa non scontata – lo farà principalmente perché sembra fornire una risposta a un rischio, reale o percepito, di declino del potere americano, palesato da una serie di indicatori interni ed esterni. Oggi che pare, forse, tramontare la sua epoca è importante tenere a mente questi aspetti relativi alle circostanze dell’ascesa del neoliberismo. Specie perché le ricostruzioni successive tendono a focalizzarsi soltanto su class struggle endogeni al sistema economico occidentale o a proporre una denuncia meramente ideologica della questione. È invece proprio mantenendo i piedi nella Realpolitik che si capisce meglio come funzionò quella svolta e cosa davvero rappresenta, o rappresenterebbe, quella attuale.
Non un’abiura morale o culturale del sistema precedente – un’abiura che sarebbe utile, visto fino a che punto disvalori etici di una versione da “discount” del neoliberismo sono penetrati in profondità nella cultura contemporanea – ma un atto di Realpolitik teso, in primis, a sortire effetti (geo)politici. Proprio come fu il neoliberismo a suoi tempi (per un’analisi del neoliberismo come progetto di potenza, con un chiaro retaggio imperialista, consiglio l’eccezionale Globalists di Quinn Slobodian). Dall’Ottocento in poi, per capire le grandi svolte economiche ed industriali, non vale infatti quasi mai il vecchio adaguo di “seguire il denaro” ma si rivela di solito molto più utile seguire il filo d’Arianna del potere.