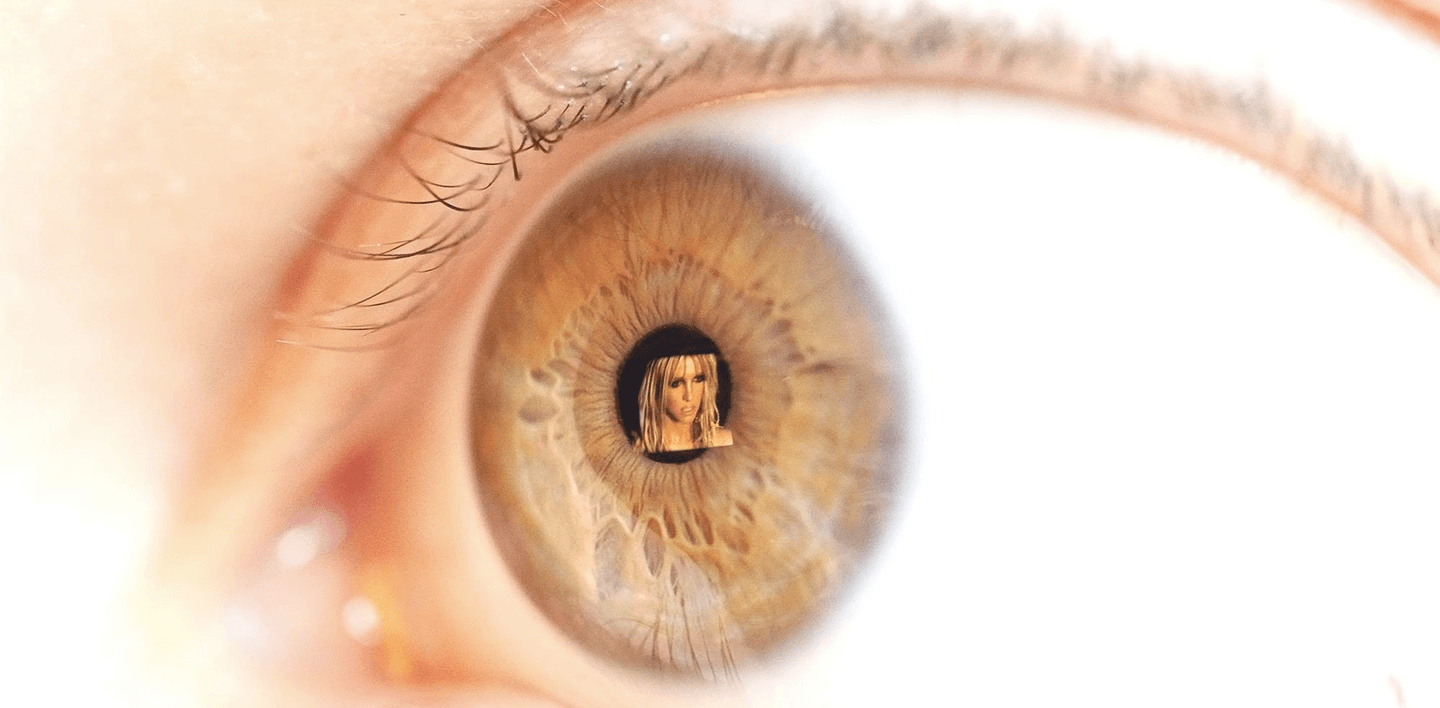
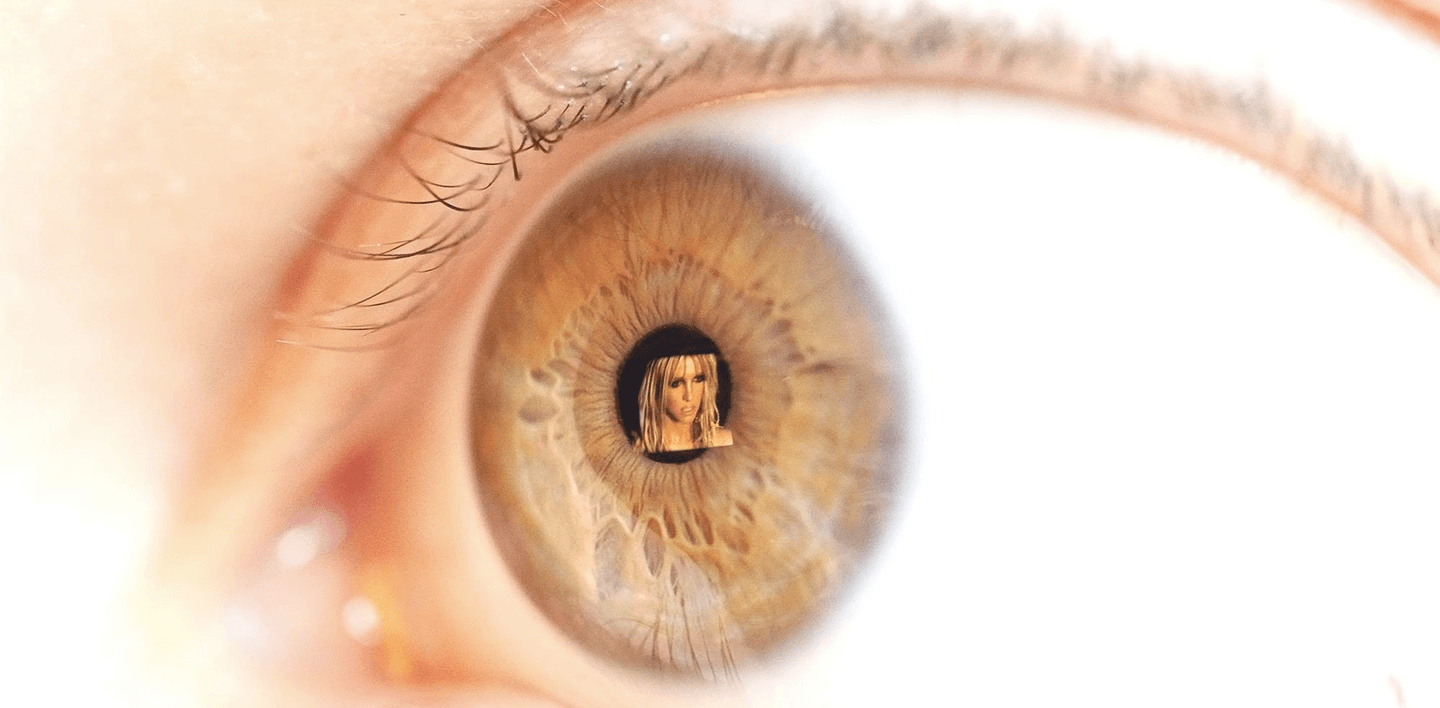
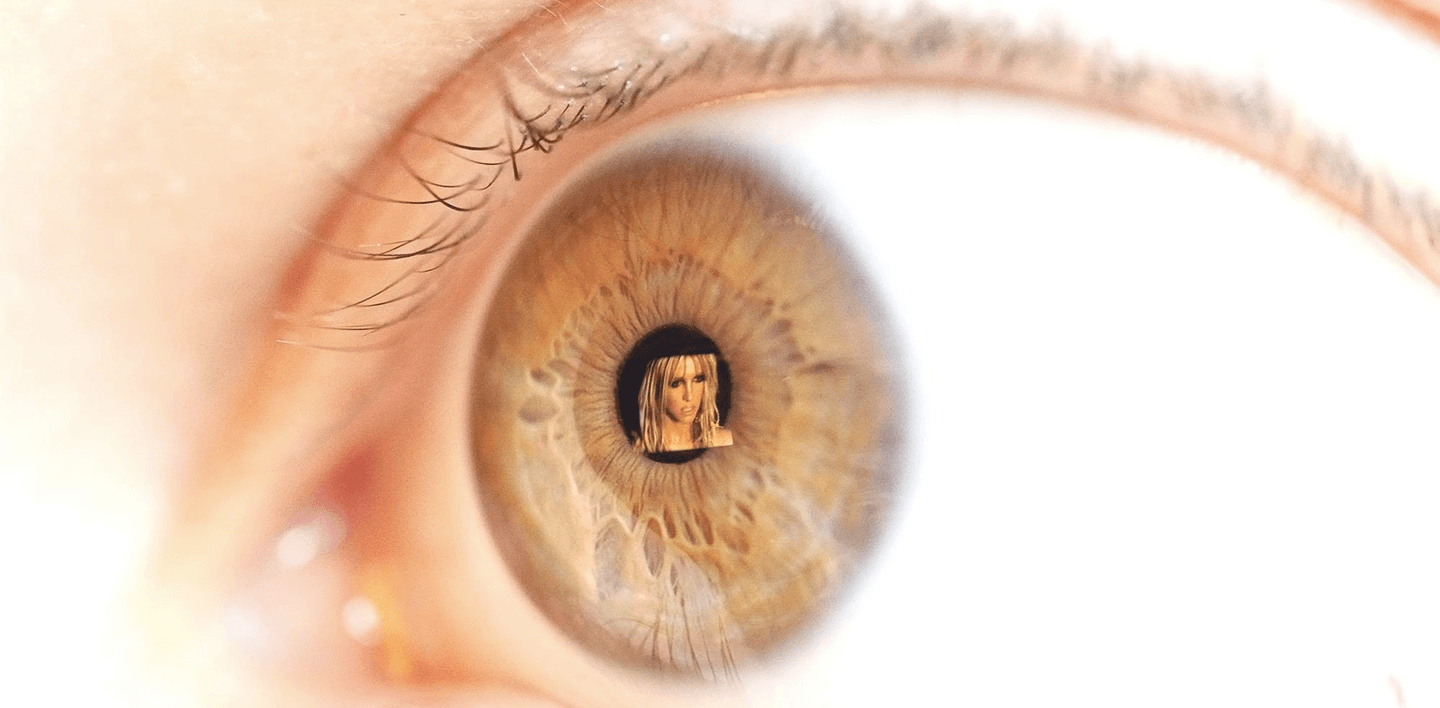
D i solito mi alzo alle 5 o alle 5.15 del mattino. In passato cominciavo a mandare email appena alzato. Però non tutti hanno i miei stessi ritmi, perciò adesso cerco di aspettare fino alle 7. Prima di inviare mail faccio esercizio fisico, leggo e utilizzo i nostri prodotti. […] Non sono un dormiglione e non lo sono mai stato. La vita è troppo eccitante per dormire. Do una rapida occhiata alle email mentre mio figlio viene nel nostro letto a bere il suo latte. Rispondo subito ai messaggi urgenti. Ne segno altri che leggerò lungo il tragitto verso il lavoro. […] Ricevo in media di cinquecento email al giorno, per cui continuo a scambiare messaggi nel corso di tutta la giornata”.
Le due descrizioni, entrambe provenienti da un articolo del Guardian intitolato “A che ora si sveglia un amministratore delegato?”, sembrano concepite per illustrare le tesi di teorici post-Autonomia come Toni Negri, Paolo Virno e “Bifo” Berardi. Il lavoro è essenzialmente comunicativo. I confini tra lavoro e vita sono permeabili. Le incessanti richieste del semio-ca-pitalismo conducono gli organismi umani ai limiti della loro resistenza. Con l’email non esiste più luogo di lavoro o giornata lavorativa. Cominci a lavorare nel momento in cui ti svegli al mattino.
Tali descrizioni della giornata di un dirigente dimostrano anche l’affermazione contenuta nell’anti-Edipo di Deleuze e Guattari, secondo cui nel capitalismo
non c’è più neppure padrone; solo degli schiavi, ora, comandano agli schiavi […] il borghese ne dà l’esempio […]: più schiavo dell’ultimo degli schiavi, primo servo della macchina affamata, bestia da riproduzione del capitale […]. Anch’io sono schiavo, ecco le parole del nuovo padrone.
Al vertice della piramide non c’è liberazione dal lavoro, soltanto altro lavoro, l’unica differenza è che magari a quel punto ti piace (la vita è troppo eccitante per dormire). Per questi dirigenti il lavoro somiglia più a una dipendenza da droga che a un obbligo. In via provvisoria, potremmo provare a immaginare un nuovo modo di concepire l’antagonismo di classe. Esistono oggi due classi: quella di chi intrattiene un rapporto di dipendenza con il lavoro, e quella di chi è costretto a lavorare. Ma il quadro non è ancora preciso. La maggior parte di noi, che lavori per un datore di lavoro (che ci paga) o per Mark Zuckerberg (che non ci paga), si trova irresistibilmente irretita negli imperativi del capitalismo comunicativo (controllare le email, aggiornare il proprio stato). Queste modalità di lavoro fanno sembrare pittoresche le interminabili fatiche di Sisifo: Sisifo perlomeno era condannato a ripetere all’infinito lo stesso gesto. Il semiocapitalismo è molto più simile allo scontro con l’Idra mitologica: tagli una testa e ne crescono altre tre, a più email rispondi e più ne ricevi.
I bei vecchi tempi dello sfruttamento, quando al capo interessava del lavoratore solo quel tanto che bastava a produrre una merce che potesse essere venduta per ricavarne un profitto, sono ormai tramontati da tempo. All’epoca lavoro significava annientamento della soggettività, riduzione della persona a impersonale parte di una macchina. Il tempo lontano dal lavoro ormai non esiste più, e il lavoro non si contrappone più alla soggettività. Tutto il tempo è imprenditoriale perché la merce siamo noi, quindi tutto il tempo che non trascorriamo a vendere noi stessi è tempo perso. Perciò, come i personaggi del film Limitless, siamo costantemente alla ricerca di nuovi metodi per aumentare il tempo a nostra disposizione: per mezzo di stimolanti, della riduzione di sonno, del lavoro svolto mentre ci spostiamo… Neanche i disoccupati sfuggono a questa condizione: i test di simulazione del lavoro che oggi sono invitati a compiere per riuscire a ottenere un sussidio sono più che un gesto di preparazione alla futilità del lavoro salariato, sono già essi stessi lavoro (perché cos’è gran parte del lavoro “vero” se non un gesto di simulazione? Non devi soltanto lavorare, ma anche far vedere che lavori, anche quando non c’è nessun vero “lavoro” da svolgere…).
Essere sfruttato non è più sufficiente. Oggi la natura del lavoro è tale per cui quasi a tutti, indipendentemente dall’umiltà della mansione svolta, viene chiesto di esibire un (super)investimento nelle proprie occupazioni. Non veniamo semplicemente costretti a svolgere un lavoro, nel vecchio senso di compiere un’attività che non abbiamo voglia di svolgere: no, ora siamo costretti a comportarci come se ci piacesse svolgerla. Anche se intendiamo lavorare in un fast food, proprio come i concorrenti di un reality televisivo dobbiamo dimostrare di volerlo fare davvero. La famigerata transizione del Nord Globale verso il lavoro affettivo significa che oggi non è più possibile presentarsi al lavoro depressi. L’infelicità dev’essere occultata: chi vuole parlare con un operatore di call center depresso, farsi servire da una cameriere triste o seguire le lezioni di un docente infelice?
Eppure neanche questo è interamente vero. Le soggioganti forze libidiche che ricavano piacere dall’attuale culto del lavoro non desiderano vedere del tutto camuffata la nostra infelicità. Perché quale godimento possono trarre dallo sfruttamento di un lavoratore che prova davvero piacere in ciò che fa?
[…]
La ragione per cui è tanto facile suscitare avversione per i “parassiti dei sussidi” sta nel fatto che, nella fantasia dei reazionari, queste persone sono riuscite a sfuggire alla sofferenza cui chi di noi ha un lavoro è invece costretto a sottomettersi. È una fantasia rivelatrice: l’odio nei confronti di chi richiede un sussidio rivela in realtà quanto la gente odi il proprio lavoro. Gli altri devono soffrire come soffro io: è lo slogan della solidarietà negativa, incapace di immaginare una via d’uscita all’immiserimento del lavoro.
Per riuscire a comprendere il lavoro oggi, considerate la pratica pornografica del bukkake. In questa pratica sessuale diversi uomini eiaculano sul volto di una donna, la quale deve comportarsi come se le piacesse, leccandosi sensualmente il seme sulle labbra come se si trattasse del miele più delizioso. Ciò che si vuole sollecitare nella donna è un atto di simulazione. L’umiliazione non è sufficiente finché non si vede che la donna esibisce un piacere che in realtà non prova. Paradossalmente, però, la sottomissione non è completa se non vi sono anche tracce di resistenza. Un sorriso allegro, una sottomissione ritualizzata: è tutto inutile, a meno che nello sguardo della donna non si colgano anche i segni della sofferenza.
Un estratto da Il nostro desiderio è senza nome – Scritti politici. k-punk/1 di Mark Fisher (minimum fax, 2020).