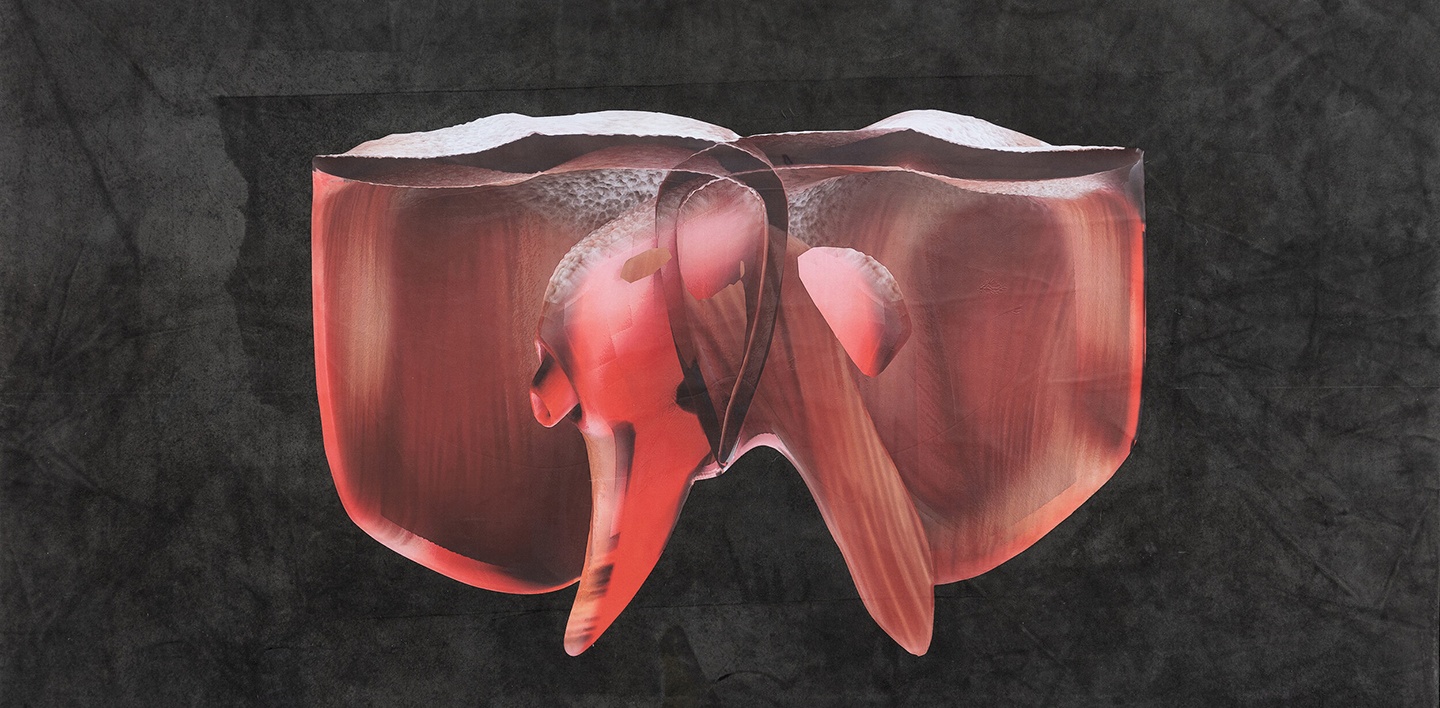
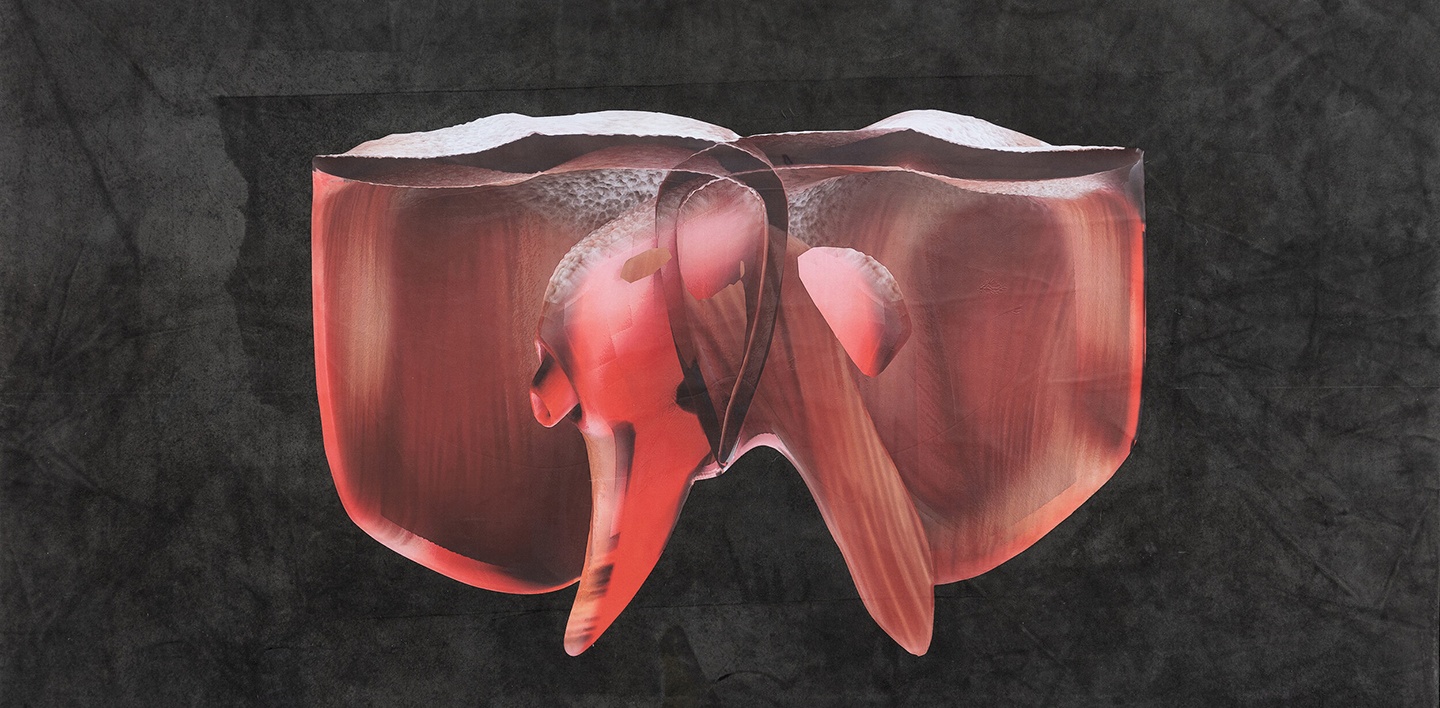
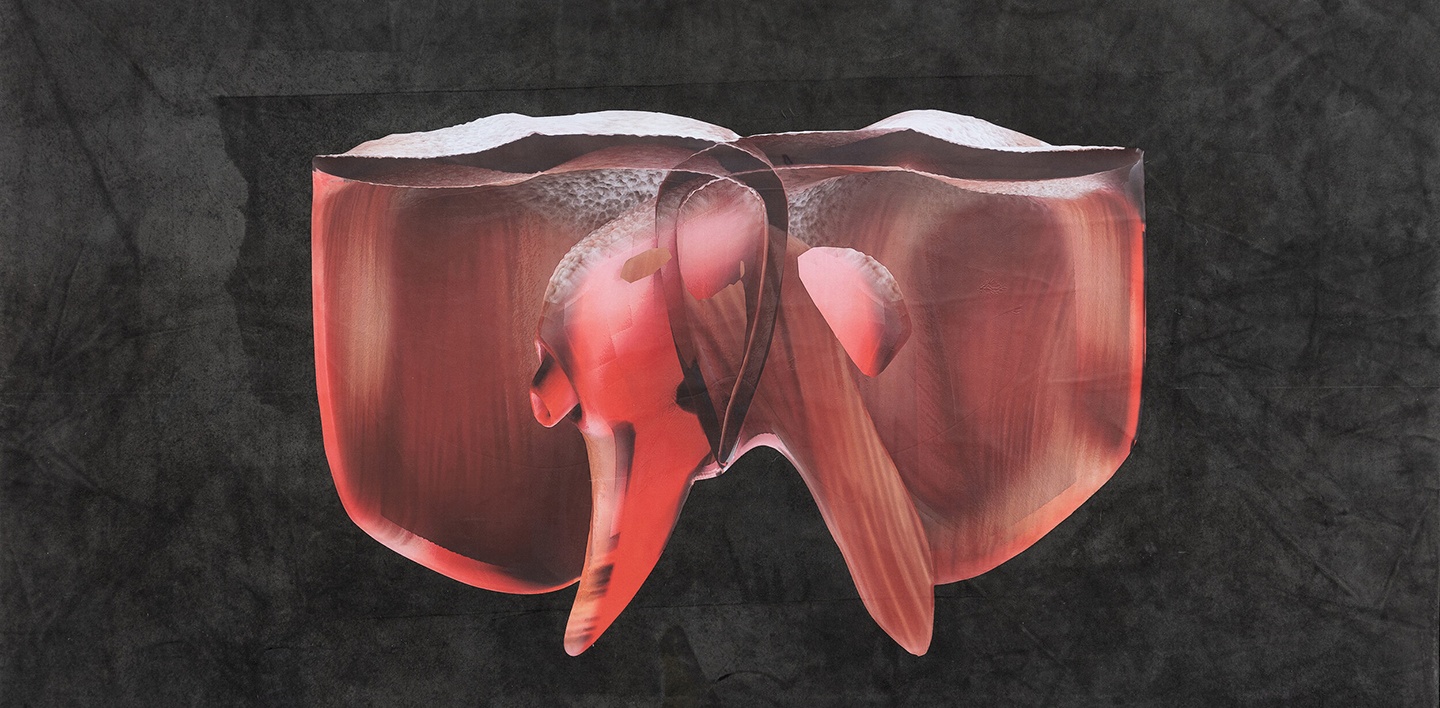
O gni congiuntura storico-politica ha le sue parole passe-partout, la cui forza sembra però a volte sbiadire con l’uso. Succede anche in filosofia: un concetto viene caricato di significati al punto da voler dire tutto e il suo contrario. È ciò che sembra sia successo con il concetto foucaultiano di biopolitica. Per questo, Ottavio Marzocca, filosofo e professore di Filosofia etico-politica dell’Università di Bari, ha intitolato la sua ultima pubblicazione Biopolitics for Beginners. Knowledge of Life and Government of People.
Dall’ambivalenza del titolo, come se fosse una ricerca di un “principiante” per “principianti”, si sviluppa innanzitutto uno studio dei testi e dei corsi in cui Michel Foucault ha abbordato la questione della biopolitica e del biopotere. A partire da questa analisi fedele al filosofo francese, Marzocca ne problematizza gli eccessi interpretativi contemporanei. Ma il testo, come dimostra questa conversazione, è molto più di un manuale per chi voglia ripercorrere il cammino foucaultiano e quello delle sue interpretazioni.
L’ironia del titolo (che si propone di riprendere il tema della biopolitica “da principianti”) può essere spiegata alla luce del primo capitolo, il commentario delle riflessioni foucaultiane, in cui fai anche una premessa metodologica: parlare, oggi, di biopolitica necessita di un ritorno rigoroso ai testi, per impedire slanci soggettivisti e manipolazioni deformanti del concetto.
Cosa ti ha portato, a trent’anni dall’inizio dell’uso inflazionato del concetto di “biopolitica” e dopo anni di tue ricerche in proposito, a riprendere “da principiante” i testi foucaultiani? Dietro l’ironia del titolo, c’è anche una qualche autoironia?
Detto questo, resta la necessità di definire in modo non generico cosa intendiamo quando parliamo di biopolitica. L’esigenza di ripartire da Foucault, cui cerco di rispondere nel primo capitolo, non è dettata da una preoccupazione di fedeltà al verbo, ma assume come irrinunciabile la specificità che il filosofo francese ha saputo attribuire al concetto, senza la quale diventa un attrezzo analitico inservibile, un’arma spuntata, oppure un’idea che risponde semplicemente all’ultima sua declinazione che si è affermata sul mercato editoriale. E qui preciserei, molto sinteticamente, quella che mi sembra la definizione generale della biopolitica, che può essere ricavata dal percorso di Foucault: la biopolitica consiste in un insieme dinamico di strategie e relazioni di potere di cui la vita, intesa innanzitutto come fenomeno biologico nel senso moderno del termine, rappresenta l’oggetto privilegiato in quanto risorsa del corpo individuale e collettivo. A partire da una definizione come questa, noi possiamo elaborare ulteriormente, ridare efficacia e attualità all’idea di biopolitica. Cosa che, nella situazione creata dalla pandemia, mi sembra particolarmente urgente e utile.
A parte il fatto che, recentemente, vari giuristi hanno posto in luce la differenza fra stato di eccezione e stato di emergenza (che è quello con cui ci confrontiamo nella pandemia), qui è importante rimarcare che per Foucault il potere sovrano in quanto tale non è biopolitico, poiché non è un potere esercitato soprattutto in modo positivo e protettivo sulla vita; rispetto alla vita esso è “semplicemente” un diritto di vita e di morte, un potere che si limita a “lasciar vivere” e a “far morire”. In altre parole, nell’idea di biopolitica bisogna riconoscere la relazione che si dà fra pratiche di governo tese a proteggere o a potenziare la vita biologica e l’articolarsi di quest’ultima attraverso la singolarità degli organismi individuali e la totalità del corpo collettivo. Da questo punto di vista, se vogliamo stare alla terminologia agambeniana, l’uccidibilità o la riduzione a nuda vita dell’esistenza di certi individui o gruppi sociali non rappresentano gli esiti necessari o le finalità primarie della biopolitica, ma piuttosto sono gli effetti perversi che possono prodursi a partire dall’intento innanzitutto positivo e protettivo della biopolitica. Secondo me, se non cogliamo questa specificità della biopolitica, non riusciamo neppure a distinguere la varietà di forme che essa può assumere e che vanno ben oltre l’ambito politico-giuridico di una sovranità. Così rischiamo anche di perdere di vista la molteplicità di problemi che la biopolitica ci pone, oltre che le opportunità di beneficiarne o di svincolarcene che possiamo trarne.
Limitandomi ancora ai tre autori – senza tornare su Agamben di cui abbiamo già parlato – direi che forse Esposito è quello che si è sforzato più degli altri di mettere a fuoco questa specificità della biopolitica attribuendo centralità all’uso politico del sapere biomedico come elemento cruciale perché si dia appunto una biopolitica. Dal suo punto di vista, il nazismo in particolare arriva a promuovere delle pratiche di sterminio proprio in quanto regime disposto a biologizzare oltre ogni limite l’esercizio del suo potere totalitario e, perciò, anche a trattare come agenti di infezione e corruzione biologica da eliminare gli ebrei e gli altri portatori di alterazione dell’integrità del corpo razziale del popolo.
Uno degli aspetti problematici della riflessione di Esposito è di attribuire valore paradigmatico al concetto di immunitas, ossia all’idea che la biopolitica funzioni soprattutto mediante l’immunizzazione della società dalle figure sociali ritenute “pericolose” o dalle relazioni che contrastano con il predominio dell’individualismo; perciò, secondo lui, essa finisce per produrre effetti mortiferi quando spinge l’immunizzazione fino alla discriminazione radicale di certe figure. In realtà, attribuendo questo tipo di importanza al concetto di immunità, Esposito innanzitutto sottovaluta il fatto che la biomedicina contemporanea, ormai da molti decenni, esprime e realizza il suo potenziale biopolitico andando molto al di là delle sue finalità immunitarie; essa infatti tende sempre più a potenziare, a conservare o a “correggere” le capacità somatiche degli individui mediante la farmacologia molecolare, la manipolazione cellulare, la ricerca genetica e le biotecnologie. Inoltre, l’uso che Esposito fa del concetto di immunitas, malgrado la sua riflessione si basi sul riconoscimento della centralità del sapere medico, è un uso largamente metaforico: egli, appunto, pensa che l’immunizzazione biopolitica consista nella protezione della società non tanto dagli agenti infettivi, quanto da individui e gruppi percepiti come minacce per l’ordine e il benessere collettivo. Perciò rischia di essere illusoria l’idea espressa recentemente dall’autore, secondo la quale la pandemia e le biopolitiche messe in campo per arginarla confermano il valore paradigmatico che egli attribuisce al concetto di immunitas. Non si può non osservare, infatti, che l’immunizzazione che queste biopolitiche perseguono non consiste tanto nella discriminazione delle figure portatrici di pericoli sociali, quanto nell’uso di farmaci e strumenti vaccinali per la neutralizzazione di quelle presenze non-umane che sono i microrganismi patogeni. Non si può non aggiungere inoltre che oggi è la manipolazione tecnica della materia vivente, più che la semplice immunologia, a svolgere un ruolo cruciale in questo senso, come possiamo constatare facilmente attraverso la vicenda dei vaccini, in cui l’uso del cosiddetto “Rna messaggero” ha prevalso su quello del semplice “vettore virale”. Il che significa che la medicina immunitaria è solo un elemento di un quadro più ampio, articolato e complesso, di una pratica e di una ricerca biomedica dominate dall’approccio biotecnologico finalizzato al potenziamento attivo, oltre che l’immunizzazione negativa, della vita.
In generale direi che sia Esposito sia gli altri autori di cui stiamo parlando tendono a vedere nella biopolitica una condizione essenziale della politica contemporanea, con la quale essa avrebbe finito per identificarsi sostanzialmente e che perciò rappresenterebbe ormai una sorta di orizzonte invalicabile. Da parte mia, oltre a essere scettico su questo scenario, penso che si debba comunque cercare di restituire alla politica i margini di autonomia non solo dalla biopolitica, ma anche dall’economia, ai quali tendiamo a rinunciare troppo facilmente da troppo tempo.
Rispondo alla prima finalità soprattutto in modo indiretto, vale a dire mettendo in discussione le tesi di chi attribuisce un carattere biopolitico alla nostra intera tradizione politica a partire dalle concezioni classiche dell’antichità. A tal proposito non mi riferisco solo ad Agamben, che rintraccia nella visione aristotelica della politica la vocazione biopolitica dell’Occidente, ma anche e soprattutto a Mika Ojakangas che recentemente ha pubblicato uno studio intitolato On the Greek Origins of Biopolitics. Per lui sia Platone che Aristotele elaborano e promuovono una visione essenzialmente biopolitica della politica, che verrebbe ripresa e rilanciata nella modernità. L’idea di biopolitica che Ojakangas propone è piuttosto appiattita sulla sua declinazione razzista e tanatopolitica che ha trovato nel nazismo le sue applicazioni estreme. Di conseguenza, volendo individuare soprattutto in Platone il precursore del biopotere moderno, questo autore finisce per vedere nello Stato ideale teorizzato nella Repubblica un progetto di formazione e salvaguardia di una comunità politica depurata dalla presenza di individui deboli o malati. Secondo me, invece, per quanto non sia esente da aspetti decisamente problematici, l’utopia platonica è e resta un progetto di moralizzazione della polis, che non richiede la trasformazione biopolitica della sua collettività in una specie di “razza superiore”, ma piuttosto la formazione di una élite di governanti capaci moralmente e fisicamente di perseguire il bene comune rinunciando ad avere una proprietà e una famiglia propria in quanto dimensioni dell’interesse privato.
Nel libro, d’altra parte, cerco di fare emergere in modo diretto la modernità della biopolitica evidenziando la complementarità delle strategie di protezione delle risorse umane dello Stato moderno ai processi di profonda economicizzazione che la razionalità di governo della nostra società ha subito negli ultimi tre secoli. In questo senso, non si tratta semplicemente di dire che lo Stato moderno si è posto al servizio del capitalismo sin dalla sua nascita. Bisogna riconoscere piuttosto che in molti casi esso si è formato e consolidato governandosi come insieme di forze la cui potenza, a partire da quella del corpo collettivo della popolazione, doveva essere attivamente salvaguardata e accresciuta. Da questo punto di vista, è il capitalismo ad aver trovato nello Stato le condizioni per svilupparsi e per rendersi poi relativamente autonomo dal suo potere. La biopolitica, peraltro, non si è affermata come risultato spontaneo di queste trasformazioni. Essa è stata il frutto di grandi processi di medicalizzazione della vita della società e degli individui; processi che hanno trovato i loro fattori determinanti sia negli strumenti di governo dello Stato – più che nella sua sovranità –, sia in saperi, tendenze e organizzazioni più o meno indipendenti. Penso al ruolo della polizia medica nel XVIII secolo, della filantropia, della psichiatria e del movimento igienista nel XIX secolo, o ai grandi sistemi sanitari creati nell’ambito del welfare state nel XX secolo.
Il quadro in cui la nascita e gli sviluppi della biopolitica devono essere collocati, dunque, è molto articolato e composito, oltre che storicamente preciso. Esso comunque non implica che la biopolitica sia il paradigma o la chiave decisiva per comprendere la storia o il presente della nostra società. Persino le biopolitiche antipandemiche, che caratterizzano la nostra attualità, sono motivate in gran parte da priorità ed esigenze diverse da quelle strettamente biopolitiche: esigenze economiche, di consenso politico, di ordine pubblico, oltre che meramente sanitarie.
Nel quadro della governamentalità neoliberale, dunque, la medicina non soltanto ha teso a privatizzarsi, ma ha anche radicalizzato l’individualizzazione della cura al punto di restringere il suo ambito al microcosmo genetico, cellulare e molecolare del singolo organismo. Tutto questo, d’altra parte, non sarebbe stato possibile senza una progressiva individualizzazione dell’ethos dell’uomo contemporaneo, ossia del suo modo di essere, di comportarsi e di stare al mondo, che il neoliberismo ha promosso e stimolato in ogni modo. Per inciso aggiungo che molti elementi utili a questo ragionamento vengono offerti – sia pure da posizioni molto diverse – da due autori importanti come Melinda Cooper e Nikolas Rose che approfondisco nel quinto capitolo del libro.
Che i processi che ho richiamato coincidano sostanzialmente con una “alienazione dal mondo” o con una “de-cosmicizzazione” dell’esistenza individuale e collettiva è dimostrato dal fatto che oggi le presunte soluzioni della catastrofica crisi ecologica, con cui ci confrontiamo anche attraverso la pandemia, vengono delegate volentieri agli stessi ceti politico-economici che ci hanno governati e guidati fino a ieri. In tal modo, di fatto continuiamo a tenere separata la cura della nostra vita da quella del mondo in cui abitiamo e viviamo.
D’altra parte, la pandemia ci offre anche un’occasione, che però stiamo rischiando di sprecare, per imboccare la strada di una “eto-poiesi” che sia anche una “eco-poiesi”, ovvero di una conversione etico-politica verso la ricostruzione del nostro rapporto con la dimensione mondana, ecologica e collettiva: l’occasione è quella di prendere coscienza del carattere ecosistemico delle cause della stessa pandemia attuale e di quelle che si annunciano per il futuro. Più in generale, con questo voglio dire che dovremmo innanzitutto fare avanzare la riflessione sulle profonde alterazioni ecologiche che causano due grandi problemi della nostra epoca, problemi che i nostri governanti ignorano o fingono di voler risolvere: le malattie infettive emergenti e riemergenti di cui da tempo sono ben consapevoli gli organismi mondiali di tutela della salute umana ed animale; il caos climatico che i governi e le potenze economiche intendono superare con strumenti tecnologici “green” da produrre nei prossimi trenta/quarant’anni con gli stessi combustibili fossili che ci hanno portato fino a questo punto. Dovremmo renderci conto che le “strategie” per superare questo stato di cose non possono essere lasciate nelle mani dei tecnocrati della “transizione ecologica”; esse richiedono soprattutto – anche se non solo – una conversione etico-politica collettiva, la promozione attiva di nuove forme di vita, di nuove forme di soggettività.
Sia in Biopolitics for Beginners che in altre sedi ho insistito sulla necessità di ricollegare l’idea di ethos come “modo di condursi” con quella di “modo di abitare”, che è compresa anch’essa nel significato originario del termine. Se siamo d’accordo sulla necessità di elaborare nuove forme di soggettività etico-politica, dobbiamo considerare che tale necessità non può non richiedere anche la riconquista della dimensione concreta e terrestre del nostro abitare. Dobbiamo evitare, perciò, di pensare che la dimensione adeguata alla ri-mondanizzazione del nostro ethos e alla soluzione dei problemi ecologici della nostra vita sia quella virtuale e astrattamente globale in cui siamo proiettati costantemente dalla rete.
Dovremmo chiederci, insomma, se siamo capaci e disposti a ricollocare la nostra esistenza nei luoghi, nelle città, nei territori, negli ecosistemi che abitiamo e se siamo pronti a prendercene cura politicamente ed eticamente, partendo dalla contestazione radicale dei modelli dominanti di urbanità, mobilità, produzione, commercio, consumo, che di fatto sono le condizioni in cui il disastro pandemico ha trovato le sue cause e il suo ambiente ideale.