


F ino allo scorso inverno e per più di settecento anni, il possente e venerando ghiacciaio Okjökull ha dominato la cima del vulcano Ok, in Islanda. Negli ultimi tempi lunghe e profonde crepe si erano aperte come piaghe sul suo corpo secolare, ammorbato da un’aria divenuta insopportabilmente acida e calda. Quelle membra un tempo compatte, maestose, si erano decomposte al susseguirsi di estati sempre più lunghe.
Quando, alla fine del 2019, di Okjökull non sono rimasti che dischi di ghiaccio infissi nel fango, gli abitanti del limitrofo villaggio di Borgarfjordur hanno deciso di risalire il vulcano per celebrare le esequie del gigante scomparso. Hanno inciso una targa di metallo – con su scritto: “A letter to the future” e “415ppm CO2” – e hanno scelto una roccia su cui apporla al centro del cratere rimasto sgombro. Si è trattato probabilmente del primo rito funebre in onore di un ghiacciaio estinto.
Ma si potrebbero raccontare altre storie ed evocare immagini altrettanto eloquenti del collasso ecologico che incombe: Milne, l’ultima piattaforma di ghiaccio intatta del Canada, risalente a quattromila anni fa, è collassata l’estate scorsa per il troppo caldo, poche settimane prima che i cieli della California si tingessero di un arancione sulfureo e surreale, nell’anno degli incendi record. Ovunque, nel mondo, i grandi alberi antichi si stanno disseccando a un ritmo impressionante, mai registrato prima, e a causa del riscaldamento delle acque gli invertebrati del benthos hanno lentamente cominciato a migrare in cerca di correnti più fresche, ma verso Sud, nella direzione sbagliata. L’aumento delle temperature medie sta anche assottigliando in maniera preoccupante lo spessore delle nuvole, scombussolando i cicli riproduttivi di molte specie animali e alterando la pigmentazione dei fiori, col pericolo che risultino invisibili agli impollinatori. È oltremodo difficile provare a dare un nome a quello che succede, alle imponderabili implicazioni del clima che si scalda, ma, a volerli riconoscere, i segnali ricorsivi di una crisi imminente ci sono già tutti.
Qualche anno fa, in Esiste un mondo a venire?, Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros de Castro facevano esercizio di accettazione e invitavano anzitempo a guardarsi intorno, più che avanti: in larga parte il collasso degli ecosistemi “è già iniziato e non è reversibile, può al massimo diminuire la propria accelerazione”, scrivevano. Il futuro è arrivato, avvertivano la filosofa e l’antropologo, che si sia pronti o no ci siamo tutti immersi. Stiamo oltrepassando i punti di non ritorno uno dopo l’altro, sempre più velocemente, con conseguenze per la nostra vita che saranno immense e imprevedibili. In molti si diffonde la sensazione che, non più eccezione, le catastrofi naturali stiano rapidamente diventando la nuova norma. È come se vivessimo intrappolati a metà tra il sentimento di un collasso ormai in corso e la paura di riconoscerlo appieno.
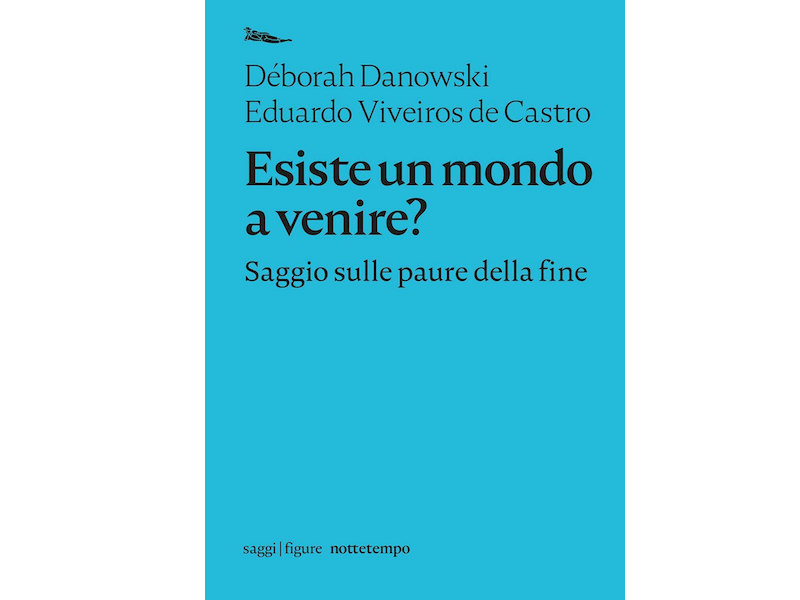
Nel loro saggio, “attraverso le mitologie attuali sulla fine del mondo e dell’umanità”, Danowski e Viveiros de Castro premettevano che l’idea della civiltà spazzata via da un cataclisma improvviso e definitivo è datata quanto il mondo: ne erano intrise già molte cosmologie antiche, dal Ragnarǫk norreno all’Armageddon giudaico-cristiano. Eppure la sua presenza nella cultura contemporanea si è intensificata notevolmente negli ultimi anni – non da ultimo per ragioni prosaicamente commerciali, legate cioè alle forme di intrattenimento dominanti nell’industria culturale: è diventato un argomento di moda. Quando pensiamo alla fine del mondo per come lo conosciamo, si attiva oggi il repertorio dei futuri collassati immaginati dalla più recente fantascienza distopica e (post)apocalittica, ma si tratta spesso di simulazioni fortemente stereotipate e caricaturali: a decretare l’eventuale tracollo dell’umanità, non sarà uno stravolgimento unico e repentino come una crisi nucleare, una pandemia globale, una rivolta delle macchine o un’invasione aliena; semmai il progressivo accumularsi di catastrofi ambientali locali che faranno regredire gli standard di vita degli esseri umani e metteranno in crisi l’ordine sociale. Non una terza guerra mondiale o un attentato bioterroristico, una congiura di hacker che paralizzerà il mondo o il suo impatto ominoso con un asteroide smisurato, ma istanti ripetuti e intermittenti di un lento collasso dei regimi ambientali. Il riscaldamento globale come accumulazione di “piccole apocalissi” o come “apocalisse in slow motion”, hanno scritto alcuni. Più che una deflagrazione di luce, una decadenza buia e incrementale.
Secondo Danowski e Viveiros de Castro, con il collasso climatico gli umani saranno chiamati a vivere in un ambiente impoverito e squallido, un deserto ecologico e un inferno sociologico.
A dispetto di ogni entusiasmo accelerazionista per il collasso della civiltà, ogni utopia eremitica o sogno campestre post-apocalittico, siamo alle soglie di un cambiamento catastrofico delle condizioni materiali di esistenza della specie. I più fatalisti profetizzano che il crollo degli ecosistemi porterà l’umanità sull’orlo dell’estinzione – un po’ come avvenne 74 mila anni fa, quando a una portentosa eruzione del Toba seguì un inverno vulcanico che ridusse drasticamente la popolazione umana sul pianeta, forse fino a poche migliaia di individui. Secondo Danowski e Viveiros de Castro, il collasso climatico non consisterà in un annientamento totale della specie, un mondo-senza-noi, ma più probabilmente in un noi-senza-più-il-mondo: gli umani chiamati a vivere in “un ambiente impoverito e squallido, un deserto ecologico e un inferno sociologico”. Lo scrittore Rob Nixon ha parlato al riguardo di slow violence, il lento sprofondamento nella barbarie, la graduale regressione verso un’esistenza materialmente e moralmente degradata a cui lo storico Christof Mauch, meno disfattista, contrappone l’etica della slow hope, la resistenza strenua anche se fallibile all’ansia climatica e all’estinzionismo senza scappatoie dei doomer, gli apocalittici ormai rassegnati all’ineluttabilità e irrimediabilità del collasso ambientale.
Il nichilismo apocalittico dei doomer è soltanto una delle reazioni umane possibili. Diversa è quella degli spettatori agnostici, increduli o negazionisti che si risolvono a condurre un’esistenza “normale”, come se la fine del mondo non fosse già in corso e l’orizzonte catastrofico non avesse ancora cominciato a interferire con le loro scelte di vita – l’acquisto di una casa non troppo vicino alla costa, la decisione di non avere figli in un mondo che potrebbe anche diventare invivibile… E poi ci sono le comunità di individui che, al contrario, si stanno adoperando fattivamente per adattarsi al futuro collasso o provare a mitigarne gli effetti: la risolutezza organizzativa di questi gruppi segnala una presa di coscienza della catastrofe climatica come possibilità reale, una circostanza consistente rispetto alla quale non è più possibile avere soltanto una posizione astratta.
A loro, a queste subculture o “tribù” del collasso, guardano due libri recenti e complementari: Appunti da un’Apocalisse di Mark O’Connell e Un’altra fine del mondo è possibile dei “collassologi” Gauthier Chapelle, Pablo Servigne e Raphaël Stevens. Il primo è un lungo reportage sugli hot-spot del collasso ambientale e sulle comunità di prepper, i “survivalisti” che si preparano alla catastrofe annunciata rifugiandosi in bunker anti-apocalittici superattrezzati. Il secondo un saggio a metà strada tra un manuale di sopravvivenza e una teoria scientifica del collasso che attinge a piene mani dai saperi dell’ecopsicologia, della psicologia delle catastrofi e delle altre survival sciences. Il merito comune a entrambi è quello di mostrare quanto sia ormai variegato l’universo dei climate collapsers, o “collassonauti”: quegli individui che accettano la prospettiva della crisi ambientale in maniera razionale e consapevole, navigano nell’incertezza presente e provano a rimanere a galla, adeguando già da oggi le loro vite al collasso che sarà. Non più minoranze eccentriche e sparute di fanatici ambientalisti, ma realtà in forte espansione come quella dei prepper, appunto, o quella degli “zadisti”, attivisti della terra che all’orizzonte del collasso oppongono la resistenza deep green con la mobilitazione collettiva in difesa degli ecosistemi.
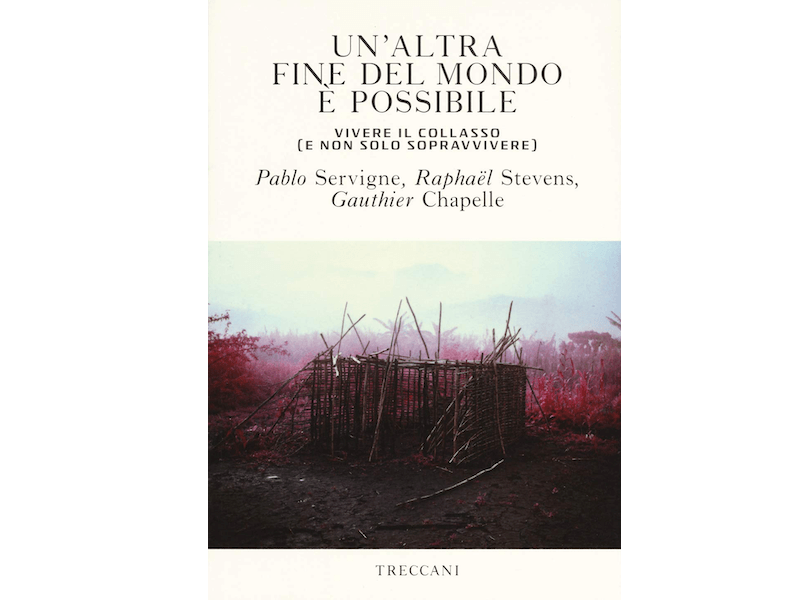
“Tra chi è pronto all’azione e chi rimane in una dimensione di negazione, ritroviamo tutta una serie di persone in difficoltà”, precisano Servigne, Stevens e Chapelle. Al loro inventario assortito di comunità del collasso potremmo ascrivere anche i “riparazionisti”, apologeti dei technological fixes con cui intendono rimettere a posto i regimi climatici, e i “compostisti”, le nuove comunità di terrestri che la filosofa Donna Haraway immagina abitare un pianeta “infetto” e per molti versi irrestaurabile. Modi diversi di riconoscere e di approcciare il collasso ambientale, di viverlo e di sopravviverlo, con attitudini variabili e scelte di vita alternative di fronte alla minaccia della crisi climatica. A dar credito ai tre collassologi di Un’altra fine del mondo è possibile, si tratterebbe per noi tutti di decidere da quale parte intendiamo stare, quale tipo di atteggiamento mentale siamo disposti a fare nostro al cospetto della catastrofe che avanza: “se il mondo dovesse crollare, con quale collettività vorreste passare il resto della vostra vita?”.
Prepararsi al collasso
Nel suo Appunti da un’Apocalisse, Mark O’Connell si pone grosso modo la stessa domanda: “come vivere tenendo conto della distinta possibilità che la nostra specie, la nostra civiltà, sia già spacciata? Dovremmo semplicemente ignorare la fine del mondo?”. O’Connell comincia la sua indagine sui prepper che si equipaggiano in vista del collasso ambientale quando sta ancora ultimando Essere una macchina, il suo reportage su transumanisti, biohacker, crionauti, singolaristi e altri tecno-utopisti con “la generale ambizione di sconfiggere la morte” trascendendo tecnologicamente i limiti della fisiologia umana. Con sua sorpresa, O’Connell finisce per rintracciare nell’universo survivalista alcuni dei personaggi incontrati in quello transumanista. Un nome per tutti: Peter Thiel, cofondatore di PayPall e plurimiliardario finanziatore di Facebook, oggi tra i maggiori investitori di progetti per la bioestensione e fervido promotore dei rifugi di lusso per survivalisti danarosi.
Come spiega O’Connell, il “tecno-millenarismo” di molti super-ricchi della Silicon Valley alla Peter Thiel, che mescola transumanesimo e survivalismo, è solo apparentemente contraddittorio: a risolvere il paradosso è la magnificazione del darwinismo sociale, le élite cognitive che prima, più e meglio degli altri intendono sopravvivere alla catastrofe ambientale e magari vivere in eterno. In questo brutale scenario da survival of the richest, Thiel & Co praticano il survivalismo nella sua variante luxury: fondano resort e gated communities in città galleggianti off-shore o si ritirano in compound isolati, esclusivi, supersorvegliati. Nei suoi “pellegrinaggi perversi” in giro per il mondo, O’Connell li insegue fino in Nuova Zelanda: un’isola-rifugio benestante e politicamente stabile, una terra remota ma non troppo lontana dalla California, fertile, scarsamente popolata, con aria fresca, acqua pulita, amenità naturali e una cintura di insuperabili falesie che la mettono al riparo dall’innalzamento del livello dei mari e pure dall’approdo disperato di migranti climatici. Negli anni, questa “arca di Noè degli stati-nazione”, una sorta di moderna Ararat come la definisce O’Connell, si è guadagnata la fama (in realtà idealizzata) di essere la destinazione ottimale per i plutocrati che intendono anticipare il collasso ambientale – o evitarsi la seccatura di altri disordini politici, più o meno catastrofici, che minaccino il loro privilegio.
Le visioni apocalittiche di molti super-ricchi della Silicon Valley alla mescolano transumanesimo, survivalismo e darwinismo sociale.
Assieme al compagno in affari Elon Musk, Thiel compare anche nel panel di super-finanziatori del “piano B” che intende fare di Marte una off-world colony, un pianeta di “riserva” per la diaspora umana qualora i cambiamenti climatici dovessero rendere inabitabile la Terra – Nuova Zelanda compresa. O’Connell ricorda che, anche nel peggiore degli scenari oggi immaginabili, le condizioni di vita sulla Terra rimarrebbero comunque meno ostili di quelle di Marte, sprovvisto di atmosfera e con un livello di radiazioni cento volte superiore. La fantasia escapista, classista e antisociale dei survivalisti affluenti, pronti nel caso ad abbandonare il pianeta prima che precipiti nel disordine, riflette così un ottimismo irragionevole e un entusiasmo acritico per le potenzialità della tecnologia: come se, anziché alla fine della storia, ci trovassimo al suo inizio, armati di una scienza che può portarci ovunque nell’universo. In opera c’è il solito mito della frontiera e della wilderness da conquistare, la retorica dello spirito umano che occupa le terre vergini e marca un nuovo punto zero della storia su cui rifondare la civiltà.
L’immagine esecrabile di questi facoltosi expat che acquisiscono acri di terra in Nuova Zelanda e coltivano il sogno di allestire un’oasi marziana cozza tremendamente con il luogo comune del survivalista indigente e frugale, dallo stile di vita retrocesso agli standard del contadino medievale. Eppure, come spiega lo stesso O’Connell, i transfughi plurimiliardari costituiscono soltanto una frazione minoritaria della subcultura survivalista, più largamente rappresentata dalla piccola borghesia americana, bianca e cattolica. È in particolare a questa, alla sua dilagante paranoia per la fine del mondo, che si rivolge il mercato dei rifugi anti-apocalittici sempre più diffusi negli Stati Uniti. Talvolta sono silos missilistici dismessi e riconvertiti alla meno peggio; più spesso bunker anti-fallout costruiti negli anni tra la presidenza Kennedy e quella Regan, quando in piena Guerra Fredda si viveva sull’orlo di un’apocalisse nucleare e si registrò un vero e proprio doom boom dei rifugi antiatomici privati. In altri casi ancora si tratta di complessi residenziali sotterranei, fortificati e dotati di tutti i comfort borghesi, progettati dal nulla con impianti energetici indipendenti, sistemi di filtraggio dell’aria e purificazione dell’acqua, magazzini per le scorte di cibo e orti per l’agricoltura idroponica.

La richiesta di questi rifugi anti-apocalittici si è impennata l’anno scorso, al diffondersi della pandemia di COVID-19. Per molti prepsteaders – altro appellativo col quale vengono definiti i survivalisti della classe media – l’ansia indotta da minacce sanitarie, economiche e politico-sociali si sovrappone infatti alla paura del collasso climatico, col bunker privato che finisce per essere la soluzione a tutti i mali, una sorta di assicurazione sulla vita tua e della tua famiglia, qualunque cosa succeda. Si è parlato al riguardo di “capitalismo della cospirazione”, la mercificazione della paura di un collasso imminente, il business di luoghi iper-protetti che diano ai prepper l’illusione del controllo e dell’autosufficienza. A detta di O’Connell c’è in gioco anche l’apoteosi patriarcale del maschio alfa che mette al sicuro la prole da un ipotetico ritorno allo stato di natura, un ideale di mascolinità che feticizza la famiglia a fortezza contro i pericoli del mondo.
I survivalisti sono in genere convinti che l’interdipendenza non protegga ma anzi esponga agli esiti peggiori del collasso: a motivarli è una tensione egoistica alla sopravvivenza che non guarda in faccia la sofferenza degli “altri” – i deboli, gli affamati, gli impreparati. Per O’Connell, al contrario, “[sono] proprio le persone più oppresse e marginalizzate dalla società a capire fino in fondo cosa [significhi] vivere in un mondo post-apocalittico, e [sono] quindi le più preparate a farlo”. Il mito dell’indipendenza e dell’autosufficienza dei prepper si scontra poi col carattere intrinsecamente precario e velleitario di ogni tentativo di farsi trovare pronti alla catastrofe: da soli “possiamo sopravvivere qualche giorno, qualche settimana, ma poi?”, si chiedono Servigne, Chapelle e Stevens nel loro Un’altra fine del mondo è possibile. “Come possiamo mangiare quando l’approvvigionamento viene interrotto? Come possiamo bere acqua potabile se il rubinetto non funziona più? Come possiamo riscaldare senza combustibile, gas naturale o elettricità?”.
Quello di cui molte comunità di survivalisti non si curano è come conservare la propria umanità dopo un eventuale collasso, quando l’istinto dominante sarà la sopravvivenza.
Per i tre collassologi, l’euforia organizzativa dei prepper si esaurisce in aspetti di natura materiale: si ferma cioè ai primi due gradini della piramide dei bisogni di Maslow, fisiologia e sicurezza. Ma l’equipaggiamento materiale non sarà in ogni caso sufficiente a vivere in un pianeta incerto, c’è da attrezzarsi anche politicamente e psicologicamente, per non dire spiritualmente ed emotivamente. “Sarà necessario forgiare una morale d’acciaio (o piuttosto di giunco, dipende) per resistere alle tempeste future”: non si tratta soltanto di avere cibo di scorta e una solida garitta sotto la quale proteggersi dalle intemperie, ma anche di conservare l’umanità quando l’istinto dominante sarà quello di curarsi esclusivamente della propria sopravvivenza. In un mondo in cui i cambiamenti climatici potrebbero rendere ogni abitazione privata un potenziale bunker anti-apocalittico, “dobbiamo chiederci, oltre a cosa possiamo fare, chi possiamo essere”.
Restaurare il pianeta
Se per i survivalisti non resta altro da fare che prepararsi materialmente al collasso inevitabile, i riparazionisti sono invece dell’idea ci sia ancora tempo per invertire il corso dei cambiamenti climatici e restaurare tecnologicamente le condizioni planetarie utili allo sviluppo e alla prosperità della specie. Il loro motto è: se non puoi cambiare le cose individualmente o politicamente, puoi sempre farlo tecnicamente. Per questo sono stati chiamati alternativamente “ambientalisti positivi”, “transizionalisti ottimisti”, “tecno-ottismiti”, “ecopragmatisti” o “ecomodernisti”, dal titolo del documento che per primo ne ha tematizzato l’ethos, l’Ecomodernist Manifesto, reso pubblico nel 2015. Lì si può leggere che gli esseri umani hanno il dovere di allentare il loro impatto ambientale, non tanto imponendo degli ininfluenti limiti alla crescita e al consumo – come sostengono certi “ecologisti negativi” sin dagli anni Settanta – quanto attraverso radicali trasformazioni tecnologiche. La soluzione al riscaldamento globale è nella liberazione, non nella repressione del progresso tecnico della specie.
La sfida che si pongono gli ecomodernisti è quella di realizzare il “disaccoppiamento tra sviluppo sociale e impatto ambientale” con l’intensificazione tecnologica di molte attività umane – urbanizzazione, acquacoltura, desalinizzazione… – per diminuire l’utilizzo antropico di suolo, contenere le pressioni sulla biosfera e rendere meno distruttiva la nostra dipendenza dalle risorse naturali. Questo processo di disaccoppiamento, scrivono gli autori del Manifesto, “scardina l’idea comune che la presenza dell’uomo primitivo sul pianeta Terra fosse più innocua di quella del suo omologo moderno”. A parere degli ecomodernisti, le tecnologie ancestrali avevano un’impronta ambientale molto più rovinosa delle tecnologie in uso nelle società contemporanee. Ma nella prospettiva della “modernizzazione ecologica” non è nemmeno vero che le motivazioni estetiche e spirituali inducano ad avere cura della natura più dei convincimenti utilitaristici.
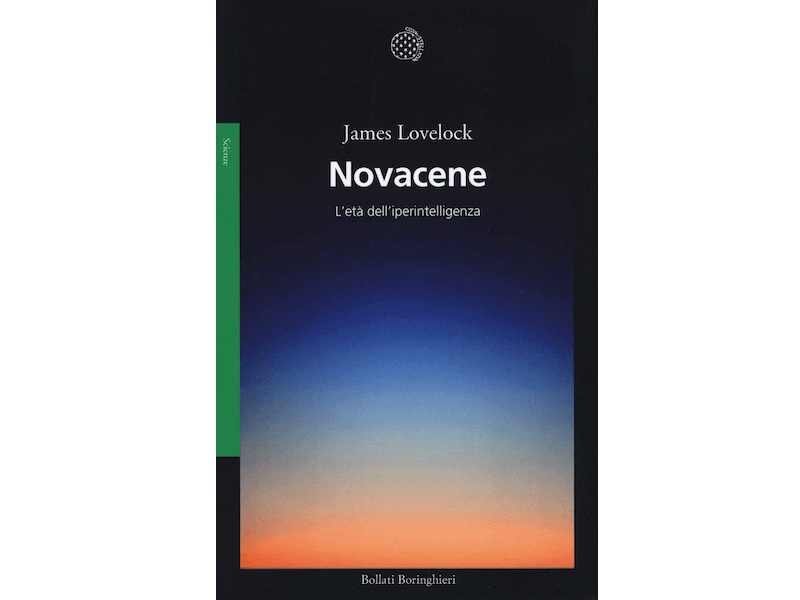
Tra i primi firmatari del Manifesto ecomodernista spicca il nome di Michael Shellenberger, fondatore del Breakthrough Institute – centro di ricerca internazionale che promuove soluzioni tecnologiche ai problemi ambientali – e fresco autore di Apocalypse Never, sottotitolo: Why Environmental Alarmism Hurts Us All. Nel suo libro Shellenberger si scaglia contro l’ambientalismo apocalittico di quanti professano la decrescita, la re-ruralizzazione, l’agricoltura biologica e persino la transizione verso fonti rinnovabili di energia. La tesi degli ecomodernisti è che solo l’energia nucleare abbia i requisiti di scalabilità e intensità sufficienti a soddisfare il fabbisogno mondiale ed evitare il collasso ambientale. Dopotutto, spiega Shellenberger, nella storia dell’umanità è sempre successo che passassimo da fonti di minore a fonti di maggiore densità energetica: l’escalation è legno, carbone, petrolio, gas e infine uranio. In quest’ottica, eterodossa e scientificamente discutibile, tornare alle fonti energeticamente diluite come vento e sole sarebbe una catastrofe perché si rederebbe necessario un maggior consumo di suolo a parità di energia prodotta.
Di “rinascimento nucleare” tratta anche James Lovelock nella sua ultima fatica, Novacene. “La mia linea di pensiero è più vicina agli ecomodernisti che ai loro oppositori”, dichiara fin da subito lo scienziato centenario e fautore dell’ipotesi Gaïa – la biosfera terrestre come un unico super-organismo capace di autoregolarsi, adattandosi ai fattori che ne turbano la condizione di equilibrio e mantenendo un clima terrestre favorevole alla vita. In Novacene, il riparazionista Lovelock alza la posta e parla di “Gaïa 2.0”, un pianeta di là da venire e regolato da forme di vita non più organica, ma elettronica: “ci stiamo avvicinando al momento in cui i nostri artefatti tecnologici, meccanici e biologici riusciranno a far funzionare il Sistema Terra da soli”. L’orizzonte cui allude Lovelock è quello di impiegare l’intelligenza artificiale nella mitigazione dell’impatto ambientale e nella regolazione dei regimi climatici. Un’intuizione che non poggia sul nulla, ma su decine di esperimenti scientifici in corso d’opera.
I riparazionisti sono dell’idea ci sia ancora tempo per invertire il corso dei cambiamenti climatici e restaurare tecnologicamente le condizioni planetarie.
In un lungo paper di fine 2019 dal titolo Tackling Climate Change with Machine Learning, un pool internazionale di ricercatori stilava una rassegna esaustiva dei progetti per l’applicazione dell’intelligenza artificiale al contrasto dei cambiamenti climatici. L’elenco è fitto e potenzialmente sterminato: sistemi di previsione delle calamità naturali, app per misurare l’impronta ecologica individuale e le emissioni domestiche, satelliti per mappare la deforestazione, sensori per la gestione delle smart grid, sistemi di ottimizzazione dei trasporti, agricoltura di precisione, tecnologie intelligenti per il sequestro dell’anidride carbonica, modelli automatici di finanza “verde”, simulazioni virtuali di interventi di geoingegneria. Basta poi una rapida consultazione della letteratura più recente e si scoprono altri progetti analoghi come Destination Earth dell’Unione Europea, TRACE ed Environmental Insights Explorer di Google, Landsat della NASA, AI for Earth di Microsoft e Green Horizon di IBM. I giganti tecnologici sono insomma già tutti in pista nell’ambiziosa corsa a progettare “esseri inorganici”, come li chiama Lovelock, più abili di noi umani a regolare la temperatura terrestre e dunque a sventare il collasso ambientale – sempre a patto che non si valichi la temperatura-soglia dei 47° C: “se questa venisse superata, perfino un’intelligenza basata sul silicio si troverebbe ad affrontare un ambiente impossibile”.
Tecno-ottimista incrollabilmente fedele alla legge di Moore, Lovelock è certo che i progressi dell’intelligenza artificiale nella mitigazione del riscaldamento globale verranno compiuti dapprima in pochi anni, poi in pochi mesi, e alla fine in pochi secondi. Nel suo libro ambizioso e visionario immagina esseri telepatici a forma di sfere che trasformeranno l’energia solare direttamente in informazione e compiranno calcoli a una velocità inconcepibile per gli esseri umani, con il solo scopo di raffreddare il pianeta e di riparare i guasti climatici che abbiamo causato. “Potremmo fare cose simili già adesso”, ammette Lovelock, “ma i cyborg le faranno presumibilmente meglio, con una maggiore accuratezza e capacità di controllo”. Le forme di intelligenza artificiale collaboreranno necessariamente con gli umani, su questo lo scienziato non ha dubbi. Saranno la nemesi che riscatterà qualunque danno abbiamo mai inflitto alla biosfera prolungando ad oltranza la presenza della vita organica sulla Terra.
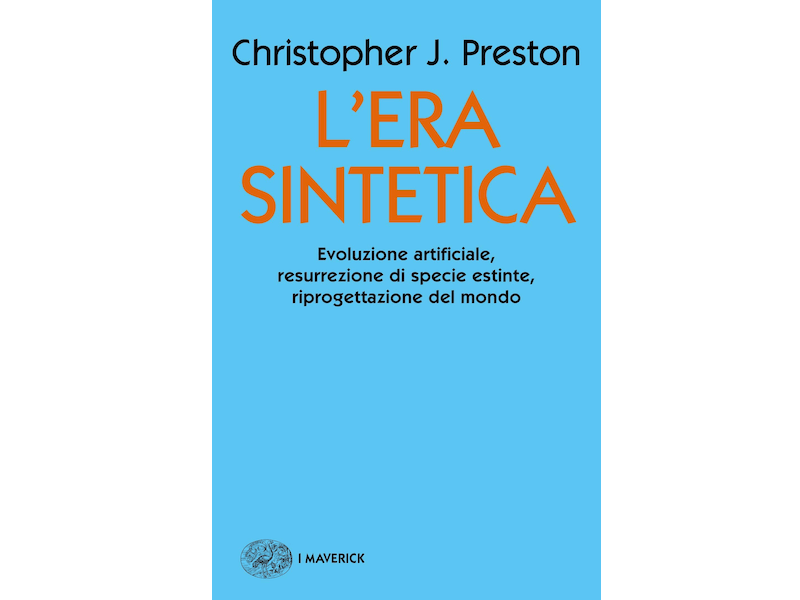
In aperta contraddizione con le sue tesi passate, la proposta di Lovelock di delegare le sorti climatiche della Terra a sistemi di intelligenza artificiale collide con la teorizzazione di una biosfera terrestre in grado di autoregolarsi. Lo spiega bene anche il filosofo della scienza Cristopher Preston nel suo ultimo L’era sintetica, un libro che ha il pregio di chiarire quale sia l’ontologia del pensiero ecomodernista. Secondo Preston, a muovere i riparazionisti è la convinzione che l’equilibrio naturale sia soltanto un mito, che la natura pristina e incontaminata non esista più e sia dunque moralmente accettabile ogni tentativo umano di rimodellarla. “Le nostre azioni hanno compromesso molto tempo fa l’integrità e l’indipendenza dell’atmosfera”, scrive Preston per giustificare il carattere inevitabile e necessario degli interventi correttivi a una natura dipinta come già irrimediabilmente corrotta. “La nostra sola speranza per riassestare le cose è quella di spingerci a fondo in questa direzione e fare ingegneria inversa dell’atmosfera”.
Per i collassonauti riparazionisti è giunto il tempo di seppellire definitivamente i fantasmi di Leopold, Thoreau, Humbold e degli altri “ambientalisti pastorali” che di fronte a una natura perturbata e guasta erano soliti anteporre le meditazioni filosofiche e spirituali alle soluzioni tecnologiche. L’ambientalismo ecomodernista è invece meno una questione di conservazione della natura e più di riprogettazione, per esempio facilitando l’adattamento delle specie animali e vegetali ai cambiamenti climatici per mezzo dell’evoluzione assistita. In questa prospettiva, opinabile e irta di falle, spetterebbe ovviamente alle tecno-élite ecomoderniste decidere fino a che punto intervenire.
L’ambientalismo ecomodernista è una questione di riprogettazione: facilitare l’adattamento delle specie animali e vegetali ai cambiamenti climatici per mezzo dell’evoluzione assistita.
A sentire i riparazionisti, l’influenza antropica sull’ambiente è ormai troppo estesa per essere attenuata, figurarsi invertita. Allora tanto vale ricomporre gli ecosistemi, ma intelligentemente e deliberatamente, secondo un nuovo disegno. “Non dovremmo vergognarci di tagliare e piantare, importare e ibridare, reintrodurre e rielaborare l’ambiente che ci circonda”, scrive Preston dando voce al pensiero riparazionista. Il mondo può essere salvato soltanto trasformandolo in un immenso giardino da curare, l’intera natura gestita razionalmente come fosse la fattoria dell’umanità. Con l’ausilio delle “scienze sintetiche” – nanotecnologie, fabbricazione molecolare, editing genetico, biologia sintetica, intelligenza artificiale e robotica, geoingegneria e ingegneria climatica, cyborg studies… – i riparazionisti sono certi di poter riprogettare le funzioni terrestri pregiudicate. Reingegnerizzando i processi planetari la Terra non sarà più la stessa, diventerà a tutti gli effetti un pianeta post-naturale, ma gli ecomodernisti invitano a non spaventarsi. Come riporta Preston, per evitare il collasso “non abbiamo scelta se non rendere la Terra un artefatto ben riprogettato”.
Umani come compost
I riparazionisti sono generalmente insensibili alla preoccupazione per cui l’applicazione dell’ingegneria climatica, anziché sventare la catastrofe ambientale, potrebbe accelerarne l’accadimento. Mettere troppo a fondo le mani nei regimi naturali rimane pur sempre un azzardo, un’ecological roulette dagli esiti mai compiutamente anticipabili. L’ambientalismo interventista degli ecomodernisti rimane così viziato da una fede cieca nelle potenzialità risolutorie ed emancipatorie della tecnologia, sempre suscettibile di un pieno controllo umano e di un miglioramento indefinito. Nel pericolo di un disastro ambientale incombente, il “catastrofismo illuminato” del pensiero riparazionista finisce per non rilevare alcun problema di ordine etico-politico, ma esclusivamente tecnico. E qualsiasi problema tecnico può essere risolto con un sovrappiù di innovazione tecnologica, quell’esplosione di capacità e conoscenze che alla fine salverà la razza.
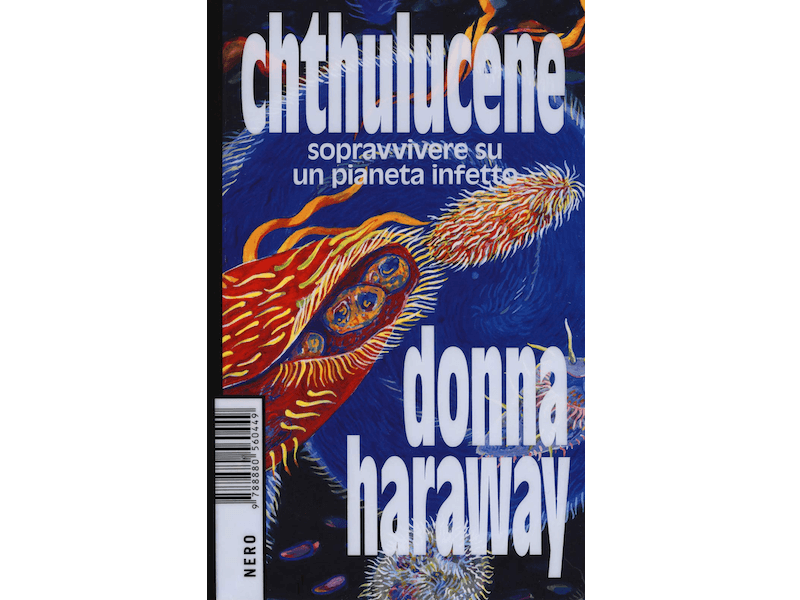
C’è del pensiero magico di fondo in questo modo di accostarsi al collasso ambientale armati soltanto di una “fede comica nella tecnologia riparatrice”, come giudica Donna Haraway in Chthulucene. Haraway rifugge il tecno-trionfalismo dei collassonauti riparazionisti prediligendo la via del “compostismo”, uno dei tanti neologismi da lei coniati con cui si indica l’approccio biofilo e transpecista che colloca gli umani alla stregua degli altri esseri viventi, tutti ugualmente indirizzati a diventare compost nel perenne ciclo della materia organica. L’umanità descritta da Haraway non ambisce a elevarsi al di sopra della natura intervenendo sulle sue leggi, piuttosto accetta di decomporsi sommessamente al suo interno come ogni altra forma di vita. Per marcare lo stacco dagli ecomodernisti, la filosofa ecofemminista scolpisce frasi come questa: “siamo compost, non postumani: abitiamo l’humusità, non l’umanità. Filosoficamente e materialmente, io sono una compostista, non una postumanista”. Più di recente un altro teorico compostista, Bruno Latour, ha scritto che per salvarci dal collasso ambientale dovremmo tutti “atterrare”, nel senso letterale di “toccare terra”, tornare all’humus che è ogni umano.
Haraway chiude il suo saggio con un esercizio di fabula speculativa in cui immagina delle comunità di collassonauti compostisti abitare nei secoli venturi un pianeta “infetto” e flagellato dagli sconvolgimenti climatici. Le comunità del compost si ritroveranno a vivere nel disordine ecologico lasciato dalla modernità capitalistica e, al pari delle altre tribù del collasso, intendono rimanere a contatto col problema di vivere in un pianeta danneggiato, ma in maniera diversa. Prendono le distanze dai doomer, che danno il mondo per spacciato predicando la dottrina del “è troppo tardi, non ha alcun senso cercare di migliorare le cose adesso”. Ma si allontanano anche dal migliorismo miope degli ecomodernisti, sostituendo alla tracotanza dei technological fixes l’umile ambizione di “una guarigione parziale, una riabilitazione modesta, […] una rinascita ancora possibile pur in tempi difficili”. Più che riparazione, qui è in gioco il “rimedio ecologico” per il ripristino dei refugia, luoghi in cui la vita possa essere sostenuta con alti livelli di biodiversità.
I compostisti immaginati da Haraway genereranno meno prole per non sovraccaricare demograficamente la Terra, la natalità diventerà un fatto collettivo e non solo familiare.
Contro l’escapismo solipsistico e il mito dell’autoprotezione radicale dei survivalisti, i compostisti immaginano invece quella che Haraway chiama “simpoiesi”, il “con-divenire” di umani e “specie compagne” per “un recupero parziale che ci permetta di andare avanti insieme”. Per sopravvivere al collasso climatico e viverne al di là, gli umani dovranno sentirsi “responso-abili” nei confronti dei non-umani, sciogliere i vincoli di genealogia, consanguineità ed eredità di parentela instaurando rapporti di cura nei confronti di tutto ciò che vive. Haraway parla al riguardo di “parentinnovazione” e oddkin: legami non riproduttivi, imprevisti e simbiotici di cooperazione con esseri al di fuori della razza umana, alleanze non-familistiche e non-speciste, assemblaggi naturalculturali che permettano a tutti i “terreni” (Latour) di convivere anche nelle circostanze più aspre del disordine ambientale. I compostisti immaginati da Haraway genereranno meno prole per non sovraccaricare demograficamente la Terra, la natalità diventerà per loro un fatto collettivo e non più (solo) familiare, tratteranno ogni vivente con lo stesso impegno emotivo oggi riservato ai rapporti di parentela. La sacralità della vita sarà estesa dall’umano all’oltre-che-umano, si piangeranno le morti degli altri esseri viventi e si avvertirà “dolore ecologico” per tutte le estinzioni irreversibili, comprese quelle dei ghiacciai.
L’ecologia politica immaginata da Haraway, né desolante né consolatoria, è molto lontana da un certo ambientalismo retorico e nostalgico che vede nella natura una condizione di purezza primordiale da preservare. Le comunità del compost non credono nelle utopie, non fanno tabula rasa della storia per ricostruire il mondo daccapo. Praticano l’arte di vivere in un pianeta danneggiato, rigenerano la vita a partire dalle rovine del capitalismo, s’insediano nei luoghi perturbati dalle attività umane per guarirli senza l’illusione di poterli riparare. Abitano mondi indeterminati e precari, al tempo stesso dentro e fuori il sistema capitalistico, o meglio ai suoi confini. Ne sono esempio i raccoglitori di funghi matsutake descritti da un’altra illustre compostista, Anna Tsing, che nel suo Il fungo alla fine del mondo (del 2015, in uscita in Italia per Keller ad aprile) parla di una “terza natura”, né incontaminata né sfigurata irreparabilmente, ma che nonostante le devastazioni antropogeniche riesce ancora a rendere possibile la vita.
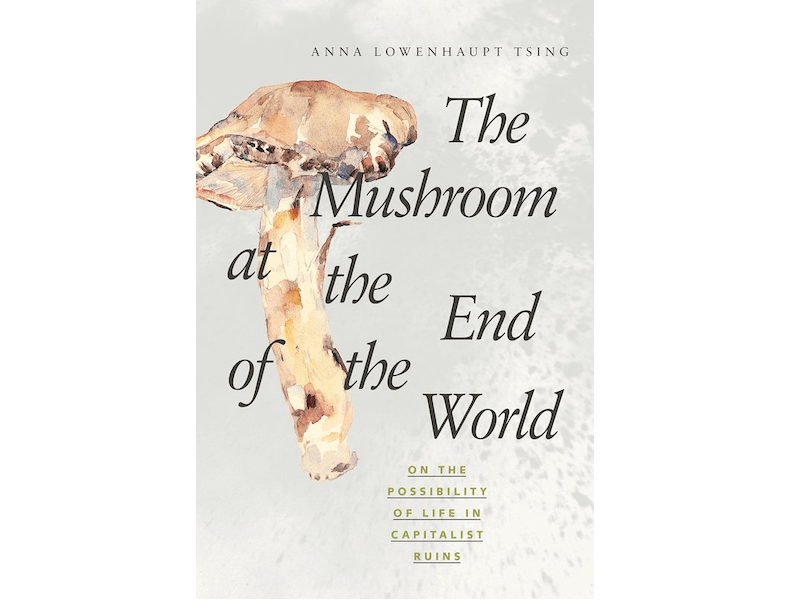
Spiega Tsing che i funghi matsutake non possono essere coltivati, la loro produzione non è pianificabile né scalabile in un regime di libero mercato, sono il common good per antonomasia. Proliferano spontaneamente nelle foreste di abeti rossi, che a loro volta attecchiscono in territori estremi, influenzati dalla presenza umana, deforestati o danneggiati dagli incendi, diffondendosi proprio grazie alle sostanze nutritive liberate dalle micorrize. Come e più degli altri funghi, i mastutake digeriscono le rocce, decompongono la materia organica e arricchiscono i suoli per poi vivere in simbiosi con le foreste di abeti che vi allignano. Nelle parole di Tsing, “sono il simbolo di associazioni opportunistiche, mutualismi, ibridazioni, incroci, legami di aiuto reciproco tra esseri viventi e tra specie, ma soprattutto di un funzionamento orizzontale e decentrato”. Contro la logica della piantagione – verticale, standardizzata, coloniale, coercitiva, alienante… – rappresentano la ragione del bosco, della vita che riprende a espandersi dopo il collasso, quando cessa lo sfruttamento e il consumo dei territori si arresta.
L’imprevedibilità dei raccolti, l’arbitrarietà nell’attribuzione di un valore a una merce che non può essere prodotta in serie, la libertà indomabile e irregolare del lavoro di ricerca dei funghi fanno dei raccoglitori di mastutake una comunità di collassonauti compostisti che esplora gli spazi liminali e periferici del capitalismo. Per Tsing e Haraway, ma l’opinione sarebbe condivisa anche da Danowski e Viveiros de Castro, la loro strategia di sopravvivenza non è affatto primitiva, ma piuttosto anti o post-capitalistica, oltre che post-catastrofica. Lo stile di vita dei raccoglitori di matsutake, per quanto precario e non esportabile a modello di società, mostra semplicemente la possibilità di una sopravvivenza collaborativa e multispecie pur nella perturbazione ambientale e nelle ecologie deteriorate di un pianeta in disfacimento.
I compostisti cercano la possibilità di una sopravvivenza collaborativa e multispecie nelle ecologie deteriorate di un pianeta in disfacimento.
A giudizio di Tsing, le due scienze che hanno dominato la modernità – la genetica delle popolazioni e l’economia neoclassica – hanno confuso la sopravvivenza di specie e individui con la promozione degli interessi individuali. “Al centro di entrambe c’è l’attore individuale autonomo, volto a massimizzare gli interessi personali, sia per la riproduzione che per il benessere materiale”: il gene egoista e l’homo oeconomicus, due abbagli che ci hanno condotti fuori strada, sulla via del collasso. Al contrario, “i funghi ci ricordano la nostra dipendenza da processi oltre-che-umani: da soli non possiamo riparare nulla, nemmeno ciò che abbiamo guastato”. Qui, a essere sepolti, sono i fantasmi di Smith, Malthus e degli altri teorici del progresso che hanno anteposto il principio di competizione a quello di cooperazione per lo sviluppo naturalculturale. Per i compostisti è urgente mettere le diverse forme di conoscenza – scientifica, tradizionale, indigena, artistica… – non più al servizio della produttività capitalistica, ma della collaborazione per la convivenza multispecie in un mondo impoverito. In questa versione eco-critica del collasso, per sopravvivere alla fine non basteranno né un bunker ben attrezzato né un clima ingegnerizzato. Quel che serve è, anzitutto, una nuova umanità.