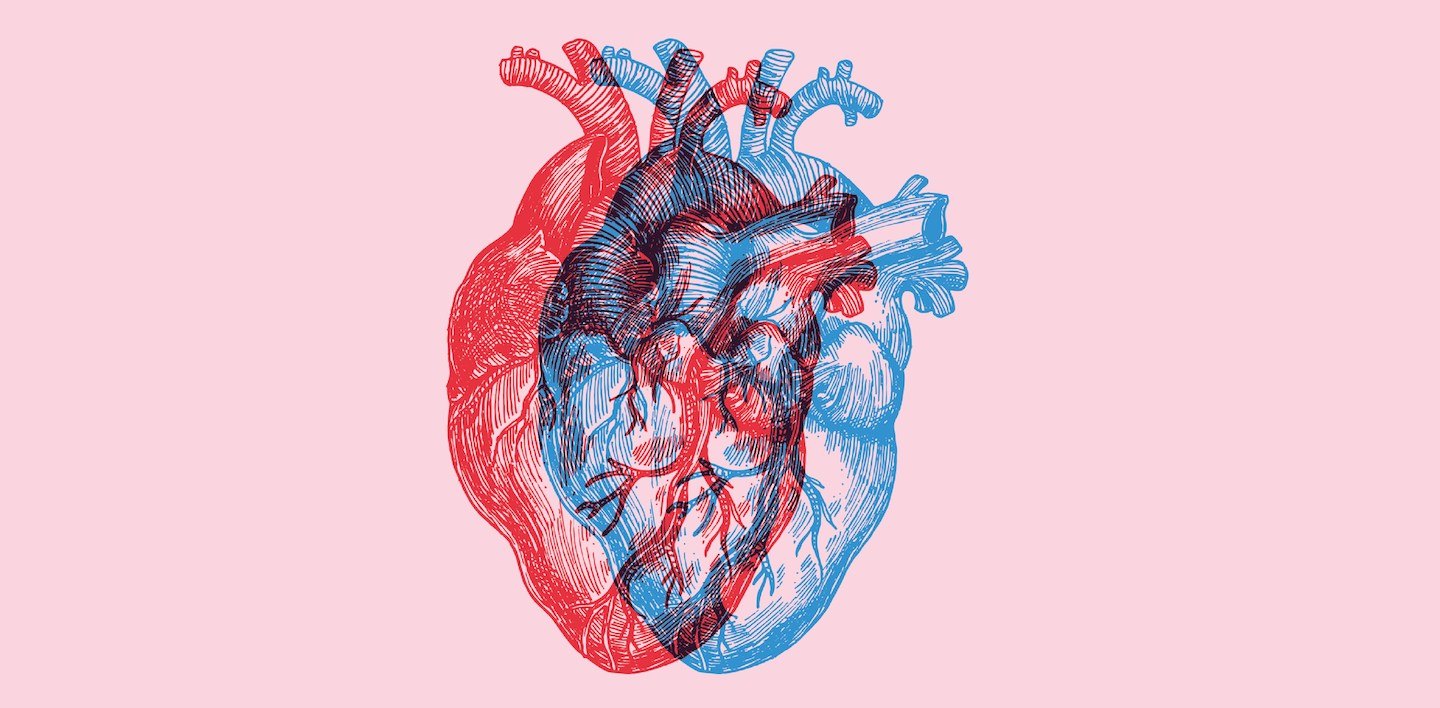
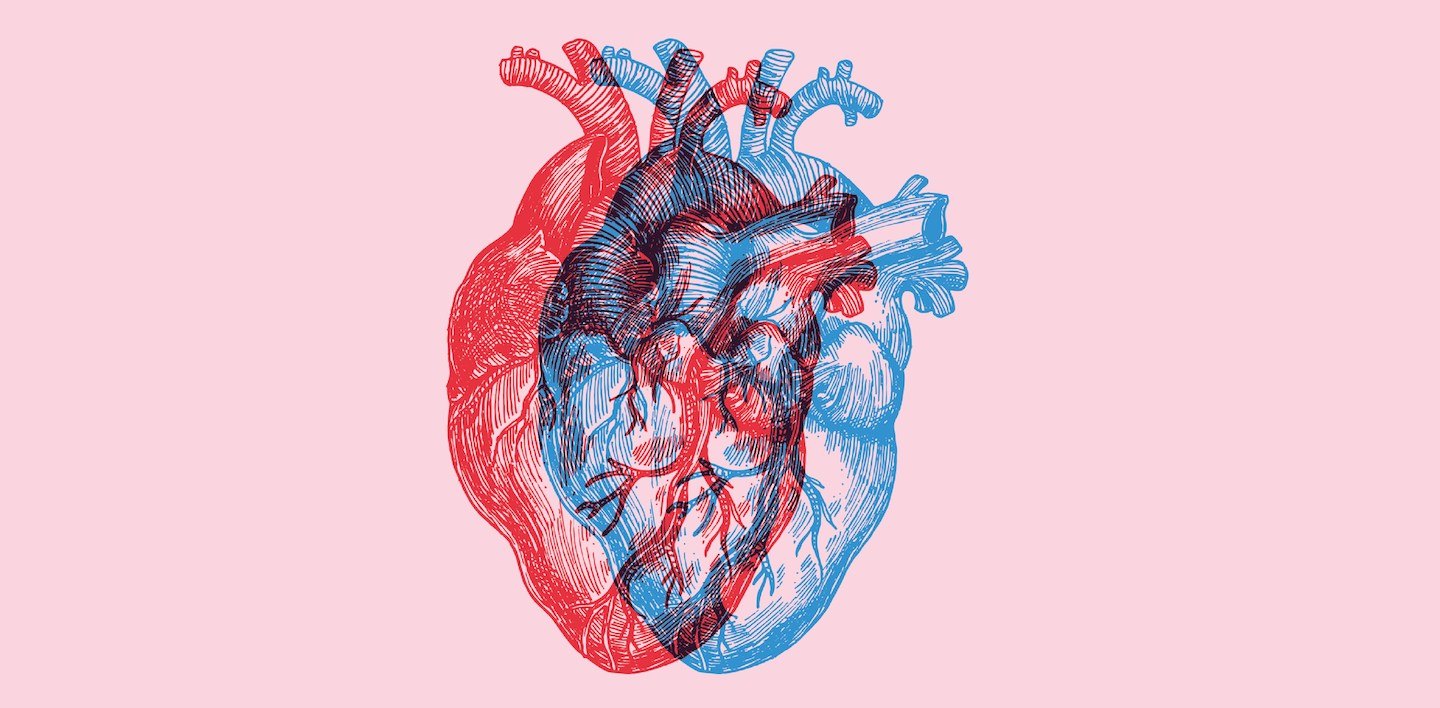
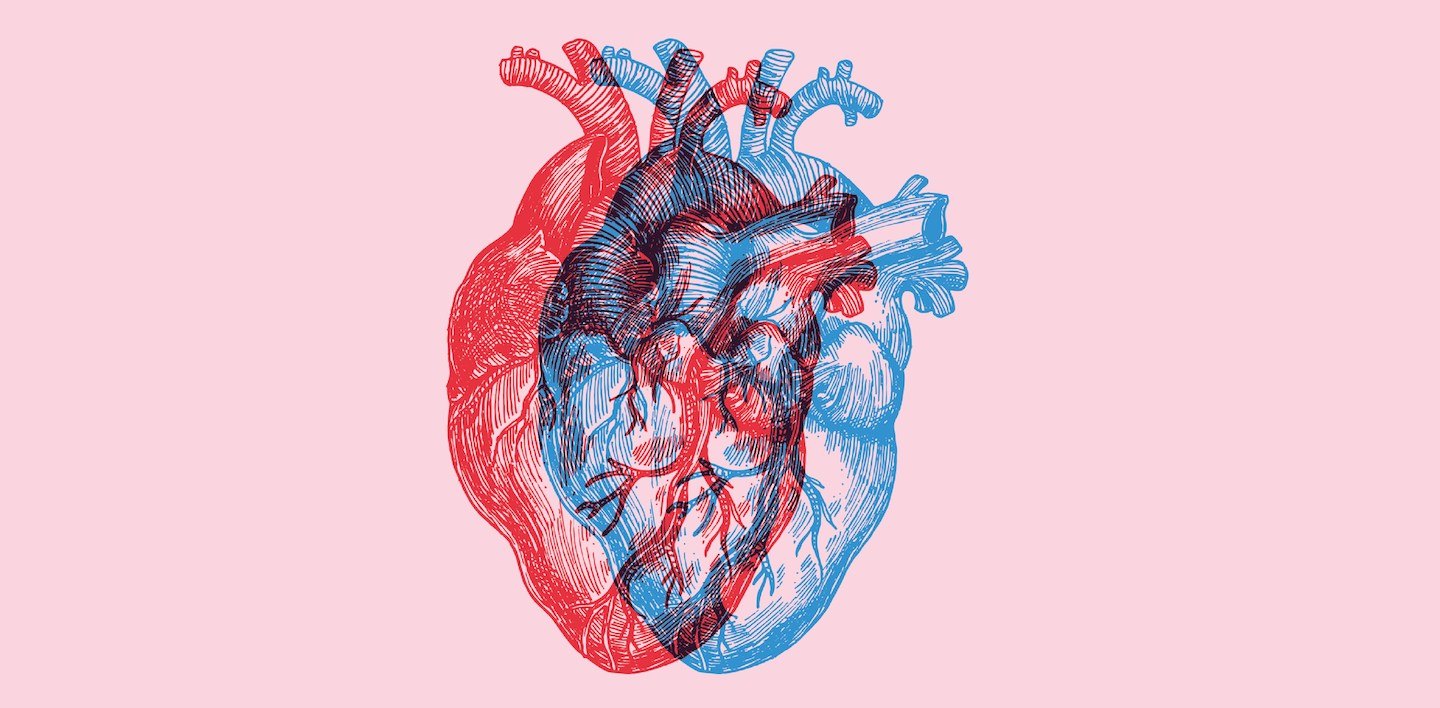
I l cuore è il principio della vita e il sole del microcosmo” scriveva nel 1628 William Harvey, lo scopritore della circolazione sanguigna che attese ben 13 anni prima di pubblicare i suoi risultati, perché temeva di essere deriso, messo al bando o peggio, in qualità di eretico: le credenze dell’epoca assegnavano al fegato il ruolo di fabbrica del sangue e al cuore quello di forno che, bruciando il sangue, forniva nutrimento al corpo. Non è un caso che questa frase apra Il cuore. Una storia di Sandeep Jauhar, appena portato in Italia da Bollati Boringhieri, con la traduzione di Benedetta Antonielli d’Oulx. Jauhar – direttore dell’Heart Failure Program del Long Island Jewish Medical Center ed editorialista del New York Times – ha una sua idea del cuore, un’idea che va ben al di là di quella prettamente medico-scientifica e, soprattutto, che oltrepassa le barriere anatomiche e fisiologiche, raccontando un intreccio inestricabile: non è possibile isolare il cuore, pur straordinario muscolo dal quale dipende la vita, dal resto del corpo e, soprattutto, dal cervello e dalla mente, come appunto un sole in un suo microcosmo.
Segnato durante l’infanzia in India dalla morte improvvisa dell’amatissimo nonno, all’epoca poco più che cinquantenne, Jauhar confessa – nelle prime pagine di quello che è al tempo stesso un memoir molto intimo, una storia della cardiologia e una riflessione sul futuro della disciplina – di essere stato sempre affascinato da questo organo, e di aver deciso con estrema naturalezza di studiarlo e curarlo.
Si è trovato così a rileggere la storia di chi, prima di lui, nei secoli, aveva osato profanare quella visione astratta che era cresciuta attorno al cuore, una congerie di teorie balzane, sedimentate nei secoli, contaminate da credenze religioso-filosofiche, prive di riscontri sperimentali, che a lungo non hanno permesso di curarlo, fino a quando non sono state smantellate pezzo dopo pezzo e sostituite da ciò che si vedeva davvero, e si iniziava a capire. Solo allora – e si parla di uno o due secoli fa – si sono iniziati a fare quei progressi che hanno poi consentito di inventare dispositivi impensabili anche solo fino a qualche anno prima quali i cateteri, la circolazione extracorporea, i pacemaker, i bypass.
Teorie balzane, sedimentate nei secoli, contaminate da credenze religioso-filosofiche, prive di riscontri sperimentali, a lungo non hanno permesso di curare il cuore.
Come Harvey, la maggior parte di questi pionieri ha sperimentato – dapprima in segreto, spesso per anni, in casa propria, su loro stessi o su animali trovati di notte, per le strade o nelle campagne – soluzioni del tutto visionarie per la loro epoca, ma dedotte dalla natura idraulica, elettrica e muscolare del cuore, che via via andavano scoprendo. E hanno dovuto lottare non poco per convincere i colleghi della genialità delle proprie intuizioni, non di rado riconosciuta solo dopo la morte.
Ha lottato Werner Forssmann che, stanco della diffidenza dei colleghi, nel 1929 introdusse il primo catetere della storia direttamente nel suo cuore passando dal suo braccio sinistro, e inventando di fatto tutta la cardiologia interventistica.
E così ha fatto anche Clarence Lillehei, considerato da molti il più grande innovatore del Ventesimo secolo, con la circolazione incrociata, sperimentata negli anni cinquanta prima sugli animali e poi su una bambina affetta da una gravissima cardiopatia congenita. La sua circolazione esterna utilizzava un parente del malato come primo, rudimentale macchinario, e collegava i vasi dei due attraverso una pompa. Ma grazie a lui negli anni seguenti fu inventato uno degli strumenti che più ha inciso sul destino di milioni di cardiopatici: la macchina per la circolazione extracorporea (ECMO), che oggi consente di eseguire lunghi interventi un tempo inimmaginabili, grazie alla temporanea sospensione della funzionalità cardiaca.
E così ha lottato negli anni sessanta Wilson Greatbatch, ingegnere della Cornell University, che studiando le caratteristiche elettriche del cuore per regolarizzarne il funzionamento inventò il primo pacemaker. Ma ciò che accomuna questi grandi innovatori, oltre alla capacità di pensare in modo eterodosso, di sfidare l’establishment, è stato anche il desiderio di aiutare i propri pazienti, ai quali, fino a pochi anni fa, non si poteva offrire granché. Per questo Juhar li definisce umanisti, e afferma di essersi ispirato a molti di loro, fino a giungere a un pensiero più ampio di quello dominante sul funzionamento del cuore, e sull’essenza della cardiologia.
Juhar definisce “umanisti” i medici, i cardiologi, gli scienziati visionari che sono stati grandi innovatori in questo campo.
Una visione che il Tascabile ha voluto approfondire con lui, in un dialogo che è andato ben al di là dei pur importantissimi progressi di una delle principali discipline mediche. Il punto di partenza del libro è la sindrome di Takotsubo. “Si tratta di una patologia riconosciuta solo a cavallo del 2000”, mi spiega Juhar, “chiamata anche cardiomiopatia del cuore infranto, perché riscontrata in persone che hanno subito un trauma e che si ammalano e talvolta muoiono poco dopo: se non fosse una patologia a volte mortale, sarebbe assai evocativa e talvolta romantica. Ma per me è molto di più”. Il cuore, nella Takotsubo, diventa come il vaso per la pesca al polpo giapponese da cui prende il nome, “ovvero più tondeggiante, a causa della ridistribuzione dei recettori dell’adrenalina che, in condizioni di stress, viene secreta in quantità molto abbondanti, a volte per mesi o anni. Per questo è considerata l’archetipo dei disturbi neurocardiaci, le patologie scaturite da una motivazione psicologica che influisce direttamente sulla conformazione e sulla funzionalità del cuore”. E per questo ha voluto partire da qui, nel libro: “questa inestricabile commistione tra il nostro stato psicologico e le condizioni del nostro cuore a mio parere è la base dell’interpretazione più moderna e reale della cardiologia”.
Che sia così, continua Jauhar, è sempre più chiaro, anche se in realtà la scienza ufficiale fa fatica e reimpostare quella concezione meccanicistica e ipertecnologica che ormai permea tutta l’organizzazione dell’assistenza e della terapia. “La riprova è che le società scientifiche non riconoscono lo stress come fattore di rischio, nonostante tutti i cardiologi sappiano quanto può essere importante”. C’è una grande pigrizia, sottolinea, perché ammettere che il benessere del cuore dipenda molto più strettamente del previsto dalla qualità della vita significherebbe dover recepire questa visione in ogni passaggio. “E ci sono due tipi di ostacoli”, mi racconta. “Il primo, da un certo punto di vista positivo, è che ne sappiamo troppo poco. Non sappiamo che cosa succede a livello chimico tra cervello e cuore, in che modo un’emozione si possa trasformare in un trauma a un muscolo, se non a livello molto superficiale, e quindi non capiamo ancora come intervenire davvero. Ciò implica che, in futuro, potremo scoprire ancora tanto, e avere grandi sorprese”.
La commistione tra il nostro stato psicologico e le condizioni del nostro cuore è la base dell’interpretazione più moderna e reale della cardiologia.
Nel frattempo, però, sarebbe già molto utile (ed efficace) se la cardiologia si facesse carico anche di questi aspetti. Il che non significa soltanto ripetere il mantra di una medicina più umana, che trovi lo spazio e soprattutto il tempo per comprendere davvero l’universo racchiuso in ogni paziente. Significa andare molto oltre. Ancora Jauhar: “Non basta pensare ai disagi psicologici che tutti sperimentiamo: quelli sono fondamentali, ma non bastano a comprendere fino in fondo perché ci ammaliamo. Noi ci ammaliamo di cuore perché viviamo male, sempre compressi tra esigenze che restringono i nostri tempi, alimentano l’ansia e l’aggressività, ci impediscono di mangiare bene, di avere cura del nostro corpo, di stare all’aria aperta, e allo stesso modo abbiamo sempre meno tempo per gli affetti, per le relazioni sociali, per il tempo libero. Per questo penso che tutta la società dovrebbe farsi carico del nostro cuore e iniziare a ripensare se stessa, tenendo presente che le malattie cardiache restano la prima causa di morte e che quindi riconoscergli lo spazio che gli compete sarebbe positivo per tutti”.
In attesa che questo accada, la comunità medica dovrebbe comunque dare l’esempio: “È indispensabile formare i giovani medici e soprattutto organizzare un’assistenza più a largo raggio, nella quale trovino spazio anche gli aspetti non prettamente medici ma assistenziali ad ampio raggio”, anche perché – e qui il cardiologo newyorkese fa una dichiarazione che non proviene quasi mai dalle labbra di un medico — “dal punto di vista tecnologico e probabilmente anche farmacologico abbiamo raggiunto il massimo delle competenze, e possiamo solo continuare a ottimizzare i cateteri, i pacemaker e così via, e trovare farmaci leggermente migliorativi rispetto ai precedenti (non sempre, peraltro)”.
Ci ammaliamo di cuore perché viviamo male, compressi tra esigenze che restringono i nostri tempi, alimentano l’ansia e l’aggressività, ci impediscono di mangiare bene, di avere cura del nostro corpo, di stare all’aria aperta.
Jauhar sa che questo è un paradosso perché, per definizione, la ricerca non pensa mai di aver capito tutto, e perché lui stesso riconosce che, appunto, almeno per ciò che riguarda le connessioni tra stato psicofisico e cuore c’è ancora molto da fare. Ma la sua non è una provocazione affrettata né, tantomeno, superficiale. “Se vogliamo vedere significativi passi in avanti nelle condizioni di milioni di persone”, mi dice, “dobbiamo ripensare tutta l’assistenza a partire dalla rete sociale e familiare, e dalla cura di tutto ciò che permette all’uomo di vivere la sua vita in condizioni migliori, ben prima che intervenga la malattia”.
Questo approccio ha un importante pensiero alle spalle, di cui Jauhar parla nel libro, quello dell’allostasi: “Abbiamo capito che l’organismo insegue sempre l’omeostasi, cioè l’equilibrio delle sue condizioni interne. Per questo motivo cerca sempre di compensare, di riparare, di bilanciare. Ma accanto a questa idea c’è anche quella dell’allostasi: secondo l’allostasi il corpo è anche in relazione con quanto lo circonda, e cambia in funzione del mondo, modificando i suoi parametri interni di riferimento. Per fare un esempio: il nostro organismo cerca di tenere pressione del sangue entro i suoi valori ottimali. Ma questi non sono statici, fissi: cambiano a seconda di come interagiamo con ciò che ci circonda e con ciò che attraversiamo dal punto di vista emotivo e psicologico”.
Questa assoluta interdipendenza, che richiama quella di un microcosmo con una sua stella, spiega perché spesso non basti una terapia, per quanto efficace, e perché Jauhar ritenga che si possa fare ancora molto. A cominciare da se stessi. Lui racconta di aver saputo di essere a rischio per la presenza di placche aterosclerotiche in alcuni suoi vasi, e di aver intrapreso un percorso nel quale, oltre a una grande attenzione per l’alimentazione, si dà grande spazio alla meditazione e alla respirazione, viene incluso lo yoga e così via. “Il cardiologo di domani — ma anche di oggi – dovrebbe aiutare ognuno dei suoi pazienti a individuare il tipo di attività più congeniale e compatibile con la sua vita, e stimolarlo a provare, trasmettendo così il messaggio più importante: quello di non trascurare il proprio benessere. Ho visto su di me quanti benefici possono assicurare ogni giorno 15 minuti di respirazione profonda”.
“Per curare i nostri cuori”, conclude il cardiologo, da umanista, “dobbiamo riparare le nostre società, e le nostre menti”.