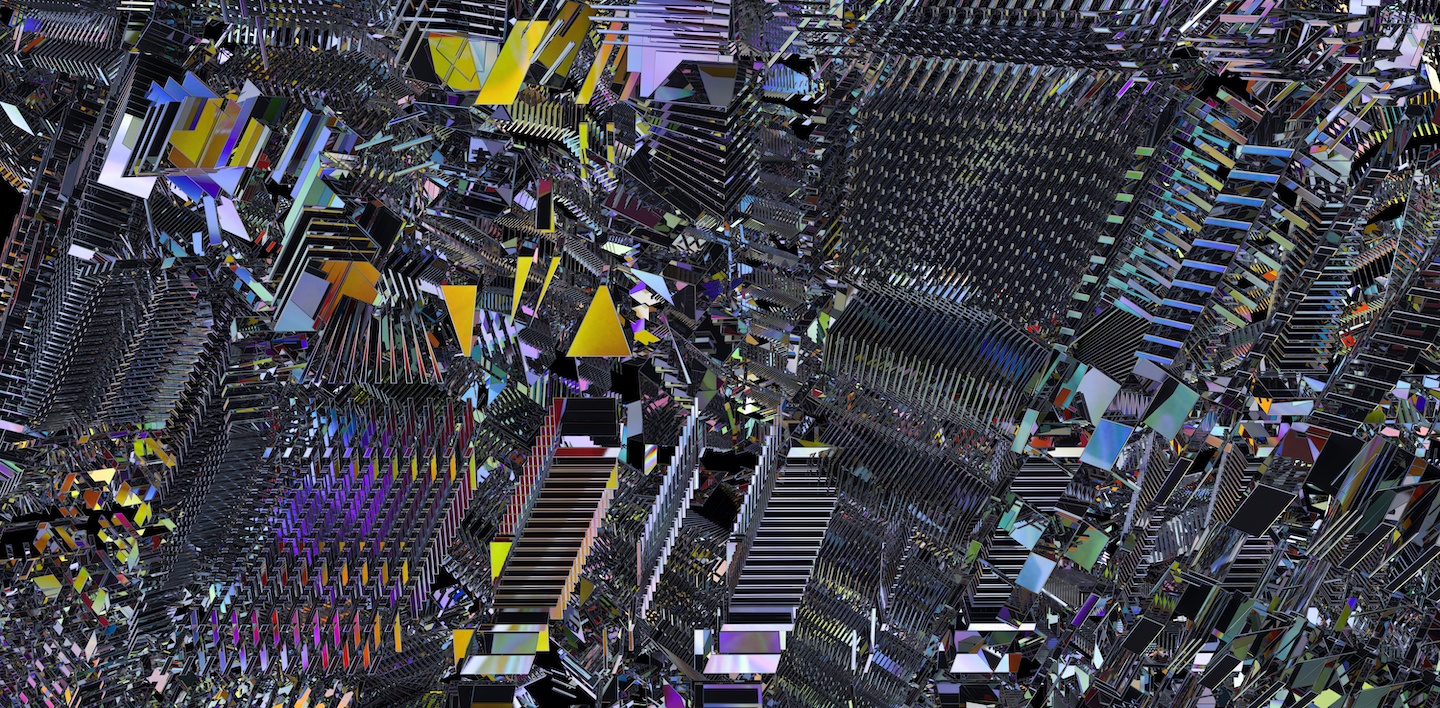
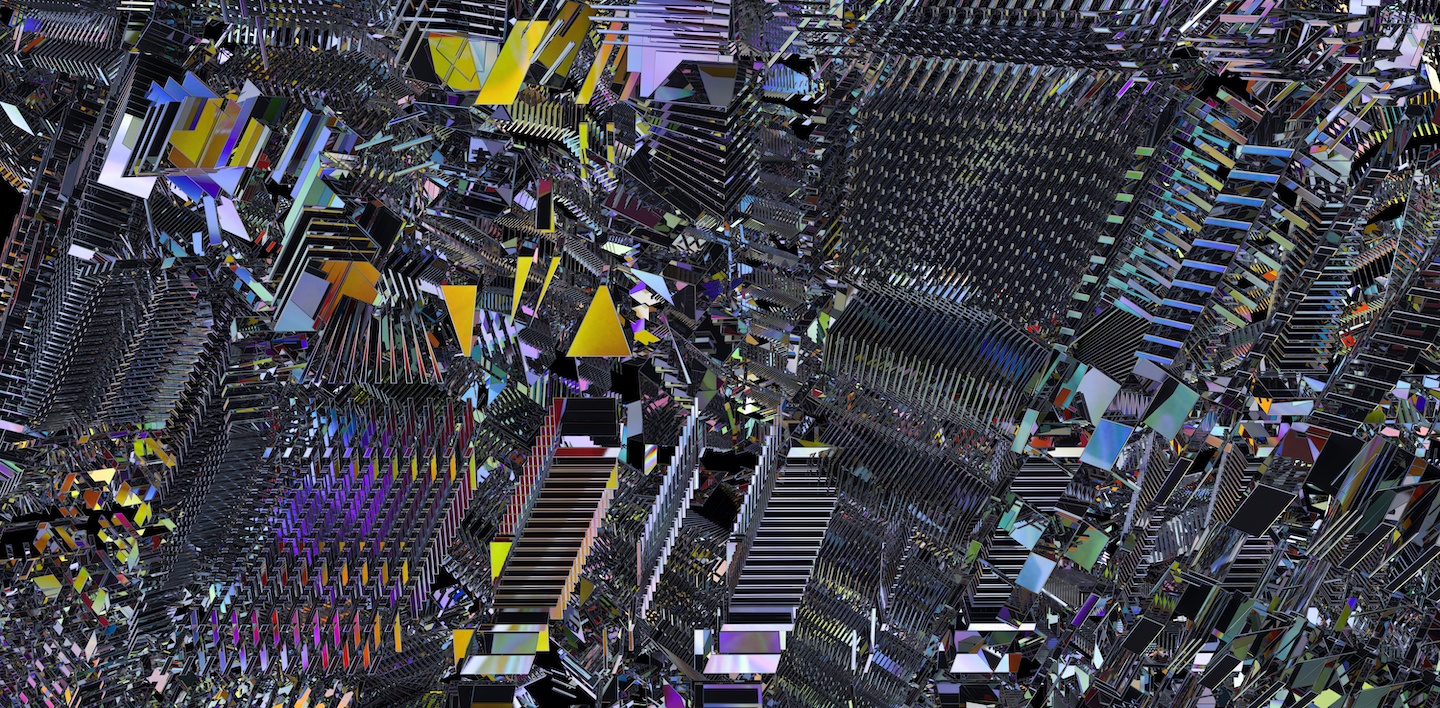
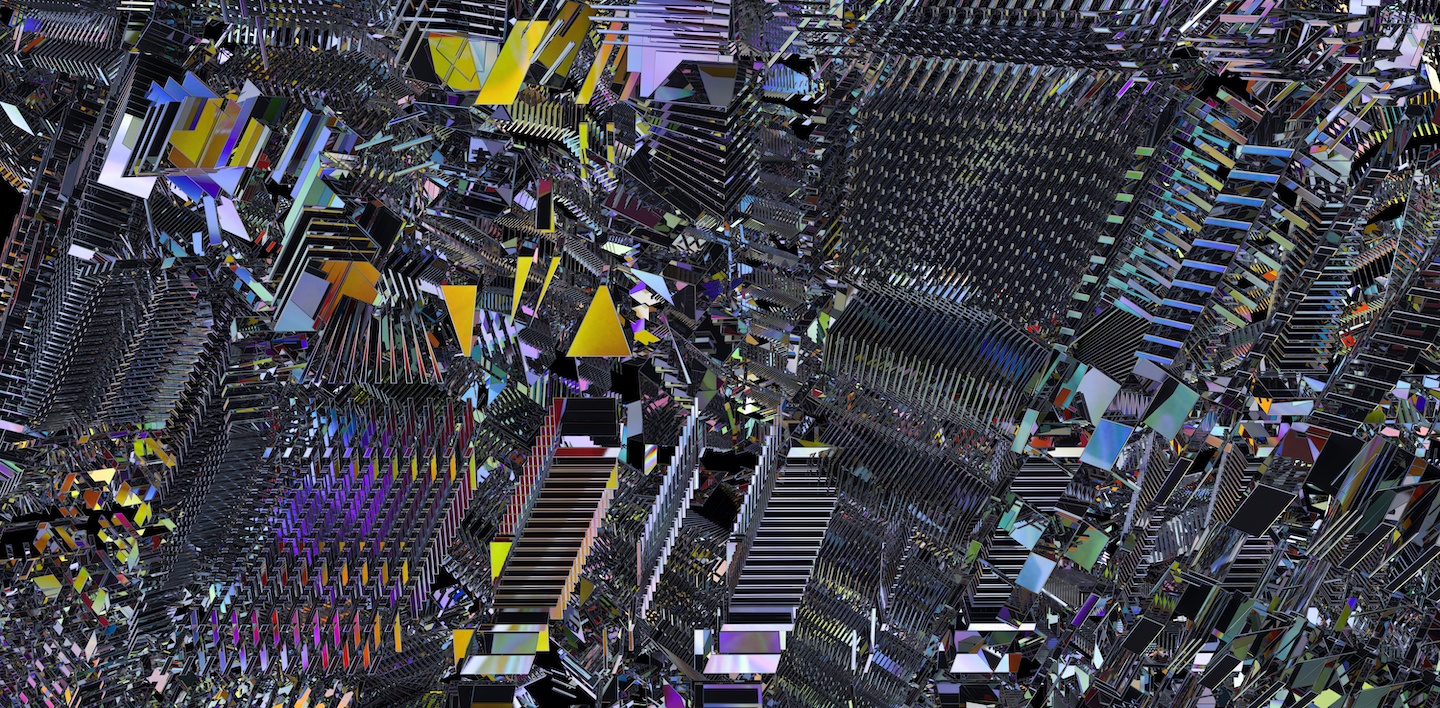
L a foto è del 1994: un giovane e intrepido Bill Gates si cala con fune e imbragatura in un bosco di abeti. Nella mano sinistra tiene bene in vista un iridescente CD-ROM, la destra è poggiata su una pila di fogli di carta che pareggia in altezza il fusto degli alberi. Il messaggio del ragazzo che vuole portare un calcolatore elettronico su ogni scrivania d’America e del mondo non chiede spiegazioni: guardate quanta informazione ci sta in un disco compatto di memoria, quanta carta ci farà risparmiare l’archiviazione digitale dei dati informatici. Basta già poca immaginazione per intravedere un futuro sfavillante in cui l’informazione, ormai quasi del tutto smaterializzata, viaggerà dal centro pulsante di un microchip fino allo schermo luminoso di un computer che potremo tenere in tasca. Alleggeriremo così la nostra impronta sull’ambiente, muoveremo i dati e non le cose, ci faremo efficienti e sostenibili. È la promessa spregiudicata di una rivoluzione digitale ed ecologica assieme.
A distanza di quasi trent’anni da quello scatto divenuto nel frattempo celebre, il savio e visionario Gates ama ancora farsi passare per guru della sostenibilità digitale, eppure la sua profezia pare essersi realizzata soltanto per metà. La rivoluzione digitale si è in effetti compiuta, almeno in larga parte, mentre la crisi climatica è sempre lì che incombe, anzi: sempre più. Ridimensionato l’ottimismo acritico della prima ondata per l’innovazione digitale – già messo in discussione, su basi economiche e politiche, da autori come Evgeny Morozov – le cosiddette ICT (information and communications technologies) hanno alla fine deluso le aspettative più rosee di riduzione dell’impatto ambientale.
La moneta digitale non è altro che l’energia impiegata per produrla, e più ne viene estratta più calcoli (ed energia) sono necessari per generarne di ulteriore.
Negli anni, le tecnologie informatiche e digitali sono diventate, anzi, per certi versi, parte del problema. Qualche dato: per fabbricare un computer si utilizzano 1,7 tonnellate di materiali, compresi 240 chili di combustibili fossili. Internet da sola succhia il 10% dell’elettricità mondiale e rispetto a dieci anni fa inquina sei volte di più, con un monte emissioni che eguaglia oggi quello dell’intero traffico aereo internazionale. Due ricerche su Google rilasciano anidride carbonica al pari di una teiera d’acqua portata a ebollizione, Netflix consuma da sé l’energia di 40mila abitazioni statunitensi. Mezz’ora di streaming emette quanto dieci chilometri percorsi in automobile (secondo altre fonti, non più di un chilometro e mezzo ), mentre un solo ciclo di training linguistico di un algoritmo arriva invece a inquinare come cinque automobili termiche lungo il loro intero ciclo di vita. Complessivamente, i consumi energetici dell’intelligenza artificiale raddoppiano ogni 3,4 mesi, e per risolvere in pochi secondi il cubo di Rubik a un algoritmo serve l’elettricità prodotta in un’ora da tre centrali nucleari.
Ci sono poi i videogiochi: complici la pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni, il 2020 è stato un anno da record per l’industria videoludica, che nei soli Stati Uniti assorbe il 2,4% dell’elettricità domestica, più di quanto facciano congelatori e lavatrici, generando tante emissioni quante quelle di 55 milioni di automobili a motore termico. Per ridurre consumi ed emissioni Sony e Microsoft hanno introdotto una modalità di utilizzo a risparmio energetico nella loro ultima generazione di console, rispettivamente, e tuttavia la sensazione è che l’intero settore stia rapidamente avanzando verso il più energivoro cloud gaming multipiattaforma.
C’è, infine e soprattutto, il problema della moneta digitale: allo stato attuale, l’impronta di carbonio di una singola transazione in Bitcoin equivale a quella di 680 operazioni Visa e di 51 ore di binge watching su YouTube. Paradossalmente, estrarre un dollaro di Bitcoin richiede quattro volte più energia che fabbricarne uno in rame e tre volte uno in oro, con proporzioni solo un po’ migliori per altre criptovalute come Ethereum, Litecoin e Monero. Al netto di definizioni troppo contorte e cervellotiche per i non addetti ai lavori, la moneta digitale non è altro che l’energia impiegata per produrla, e più ne viene estratta più calcoli (ed energia) sono necessari per generarne di ulteriore, motivo per cui i siti di produzione tendono a fare marginalità recuperando il gas di torcia dall’attività di fracking del petrolio, oppure localizzandosi lì dove l’elettricità viene ricavata dal carbone e perciò venduta a prezzi competitivi – come accade in Cina, dove le emissioni del settore superano ormai quelle di intere nazioni come Repubblica Ceca e Qatar. I computer usati nel mining della criptovaluta si surriscaldano così tanto che per raffreddarli si ricorre a sistemi di ventilazione simili a quelli impiegati negli allevamenti intensivi di polli in batteria.
Mining è una delle rare metafore del lessico digitale che rimandano esplicitamente all’industria estrattiva, un po’ come quando si dice che i dati sono il nuovo petrolio. La maggior parte delle analogie – software, cloud, smartphone, chip… – evoca un immaginario eufemistico di efficienza, leggerezza e intangibilità che contribuisce a oscurare l’impatto reale delle ICT. È stata soprattutto la miniaturizzazione dei processori a cambiare il modo in cui facciamo esperienza delle tecnologie digitali e della loro impronta ambientale. “Ingannati dalle dimensioni minuscole dei nostri apparecchi”, osserva Christina Gratorp in un articolo ripreso da Internazionale, “non ci fermiamo a riflettere sulla gigantesca industria che c’è dietro, sulle enormi quantità di risorse materiali che consumano quando li usiamo e sulle condizioni di lavoro di chi fornisce all’industria quelle risorse”.
Colossus ed Eniac, tra i primi calcolatori della storia, pesavano rispettivamente 5 e 27 tonnellate. Oggi una persona su cinque tiene in mano uno smartphone che per capacità di elaborazione supera il computer con cui la NASA è riuscita a mandare il primo essere umano sulla Luna. Si deve all’introduzione del silicio nei circuiti integrati lo sviluppo stupefacente dei microprocessori, cominciato nel 1971 con il lancio di Intel 4004. Da allora la potenza di calcolo è effettivamente raddoppiata ogni diciotto mesi mantenendo inalterate le dimensioni dei microchip, ma quello che la Legge di Moore non racconta è che la materialità delle tecnologie digitali non è affatto scomparsa: è stata soltanto rimossa da sotto i nostri occhi.
Tutt’altro che nell’etere: per fare acquisti online o muovere messaggi in chat serve carburante, e se le fonti rinnovabili sono insufficienti occorre ricavare l’elettricità da gas e carbone.
Tutt’altro che nell’etere, internet scorre come petrolio negli oleodotti attraverso 1,2 milioni di chilometri di cavi che si snodano sui fondali oceanici. Per fare acquisti online o muovere messaggi in chat serve carburante, e se le fonti rinnovabili sono insufficienti occorre ricavare l’elettricità da gas e carbone. Memorizzare dati informatici necessita di capienti archivi materiali: non esiste alcuna “nuvola”, il cloud è soltanto un imponente computer che lavora a tutto spiano in un torrido e congestionato data center. Così Gratorp: “per sua stessa natura il software consuma il mondo fisico, perché i bit non esistono senza gli atomi. Anche se imparassimo a codificare meglio, a fare test più rigorosi e a riciclare di più, sarebbe fisicamente impossibile non consumare materia ed energia”. Che doccia fredda: le tecnologie digitali sono essenziali per ridurre le emissioni e frenare il riscaldamento globale, ma quello della loro presunta immaterialità e sostenibilità è solamente un mito, tanto diffuso quanto fuorviante.
Nuvole che grondano petrolio
Misurare l’impronta ecologica dell’industria informatica e digitale è un’impresa laboriosa e scoraggiante: tolto il Cleaning Click Report di Greenpeace sono pochissimi altri i tentativi degni di nota, e tuttavia le Big Tech della Silicon Valley non mancano mai di dare sfoggio delle proprie ridotte emissioni. Di recente Google, Microsoft e Apple si sono promesse carbon neutral entro il 2030, Amazon entro il 2040. Qualche anno in più per installare pannelli fotovoltaici a sufficienza e le “sorelle” FAAMA (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet) assicurano di farsi carbon negative: produrranno più energia pulita di quella che consumano e riassorbiranno le proprie emissioni storiche con tecnologie di stoccaggio dell’anidride carbonica. In futuro mail e chat verranno alimentate interamente con energia solare, i cloud saranno ottimizzati e decarbonizzati, il green computing diventerà una consuetudine per una nuova generazione di programmatori. Le opache e discutibili compensazioni ambientali faranno il resto assieme ai massicci fondi di investimento per la sostenibilità, oggetto di una corsa filantrocapitalistica a chi elargisce la cifra più alta. Peccato che in gioco ci sia il solito, irrisolto problema di sempre, ossia quello degli “effetti rimbalzo”: la domanda di servizi cresce più rapidamente del risparmio di energia che si riesce a ottenere efficientando le tecnologie.
Per farsi un’idea di quanto emettano i data center nei quali vengono archiviati i dati informatici è stato introdotto anni fa un indicatore, il power-usage effectiveness (PUE), che tuttavia misura l’efficienza dei server, non la loro impronta di carbonio. Sono variabili ben distinte: per assurdo, il supercalcolatore più efficiente del pianeta potrebbe essere alimentato con elettricità ricavata interamente dalla combustione del carbone – la fonte energetica più inquinante – come di fatto avviene in molti data center. Ce ne sono circa otto milioni in giro per il mondo, quelli di scala industriale sono poche centinaia. Facebook detiene i propri server, Netflix si appoggia invece a quelli di Amazon che nel settore del cloud computing controlla la fetta di mercato più grossa assieme a Microsoft e Google. Dal 2010 la capacità di calcolo complessiva dei data center è cresciuta del 550% mentre i consumi di elettricità soltanto del 6%. L’impressione degli esperti è però che l’efficientamento dei server abbia ormai raggiunto il limite.
Per evitare la fusione dell’hardware surriscaldato dall’elaborazione dei dati si tenta oggi di incorporare nelle componenti elettroniche degli impianti miniaturizzati di raffreddamento a liquido. Altrove si sperimentano soluzioni ancor più avveniristiche, come quella di far funzionare i chip con fotoni al posto dei normali elettroni, oppure quella di immagazzinare i dati informatici nel DNA batterico. Facebook ha per ora risolto la faccenda del cooling delocalizzando parte delle proprie server farm nella gelida penisola scandinava, mentre Microsoft ha da poco ripescato gli 864 server del progetto sperimentale Natick, che punta a sfruttare le basse temperature degli abissi marini per raffreddare i processori. Se il calore prodotto dai calcolatori non viene smaltito in qualche modo c’è infatti il rischio che le “nuvole” di dati vadano in fiamme: vedere per credere il recente incendio ad uno dei data center di Strasburgo del colosso informatico OVHcloud.
Nei prossimi anni serviranno nuovi data center e tantissima energia per alimentare, archiviare e mantenere in vita i dati su cui si regge l’intera infrastruttura digitale. Da dove la prenderemo?
Il fatto è che prima di quanto immaginiamo prenderanno piede tecnologie come il 5G, il quantum computing, l’intelligenza artificiale, la blockchain, le criptovalute, le stampanti 3D, l’internet delle cose, le auto a guida autonoma… Serviranno nuovi data center e tanta, tantissima energia per alimentare tutto questo, archiviare e mantenere in vita i dati su cui si regge l’intera infrastruttura digitale. Da dove la prenderemo? I giganti dell’industria informatica sono già i principali client di elettricità al mondo, ma al momento non sembrano porsi seriamente il problema. Resta oltretutto aperta la questione dell’effettiva utilità dei dati memorizzati nei server – pare che solo il 6% sia veramente in uso – e dell’impiego ambiguo dei supercalcolatori, che troppo spesso vengono messi al servizio delle aziende petrolifere ed estrattive.
Uno di questi computer ad alte prestazioni si trova in Italia, nella campagna pavese, e più precisamente al Green Data Center di Eni: è in questo centro di elaborazione dei big data che a inizio 2020 è entrato in funzione HPC-5, ancora nella top ten dei supercomputer più potenti ed energeticamente efficienti del pianeta. I suoi 70 petaflop di potenza – una capacità di calcolo da 52 milioni di miliardi di operazioni al secondo – lavorano in parte in progetti di ricerca sulle fonti rinnovabili, e in parte nella rilevazione di nuovi giacimenti di gas e petrolio. Nel 2015 è stato proprio uno dei primi HPC del gruppo Eni a scovare il più grande giacimento di gas naturale del Mediterraneo, dimezzando così i tempi medi di localizzazione dei nuovi siti di estrazione. Anche Amazon, Google e Microsoft cedono i propri servizi di punta ai giganti dell’industria fossile, motivo per cui Greenpeace parla apertamente di partnership che devastano il pianeta, di cloud che grondano petrolio. Era forse questa la promessa di sostenibilità della rivoluzione informatica e digitale? Usiamo enormi quantità di energia per mettere in funzione i supercalcolatori, archiviare i dati e potenziare l’intelligenza artificiale, per poi mancare l’applicazione delle tecnologie digitali più sofisticate a questioni di pubblica utilità e urgenza come il riscaldamento globale.
Strozzati dai rifiuti elettronici
In aperta contraddizione con la percezione di sostenibilità e immaterialità delle tecnologie digitali si pone anche il tema dei rifiuti elettronici, derivanti soprattutto dalla dismissione di smartphone, computer, periferiche e altre consumer elettronics. Secondo il Global E-waste Monitor delle Nazioni Unite, nel 2019 sono stati prodotti 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, oltre 7 chili per ogni abitante del pianeta – una cifra che cresce a un ritmo tre volte superiore a quello della popolazione mondiale. Dove vanno a finire tanti apparecchi di scarto, di frequente gettati via ancora funzionanti e ben prima di aver concluso il ciclo di vita potenziale? Sempre nel 2019 solo il 17% dell’e-waste è entrato in circuiti legali di riciclo, del resto si è perso traccia in discariche abusive in Africa e nel Sud-est asiatico. Qui, per accelerare il recupero dei metalli rari, le componenti plastiche dei rifiuti elettronici sono solitamente bruciate in roghi altamente inquinanti che disperdono nell’ambiente sostanze nocive come diossine, piombo, mercurio, cadmio.
Oggi le tecnomasse tossiche e obsolete vengono esportate nel Sud del mondo perché il riciclo sarebbe un processo altrimenti complesso e oneroso.
Le tecnomasse tossiche e obsolete vengono esportate nel Sud del mondo perché il riciclo sarebbe un processo altrimenti complesso e oneroso. Un singolo smartphone contiene 40 diversi elementi metallici, alcuni dei quali pregiati e riutilizzabili come stagno, tungsteno, tantalio e oro, ma disassemblare i circuiti elettronici è un’operazione inefficiente se comparata all’estrazione deregolamentata delle materie prime “vergini”. Anche smaltire le batterie è difficile e inquinante, e ad oggi esistono soltanto due tecniche note: la pirometallurgia, che le fonde a temperature altissime, e l’idrometallurgia, che le discioglie in acidi iper-corrosivi. Proprio le batterie mostrano come sia tipico dell’industria digitale e informatica sviluppare tecnologie senza prestare alcuna attenzione al loro impatto ambientale, sacrificando la sostenibilità sull’altare della performance, dell’esperienza di consumo e della competitività sul mercato. La retorica dell’innovazione è tutta concentrata sulle prestazioni delle ICT, mai sulla loro capacità di essere riparate, riciclate, riutilizzate, rigenerate o – perché no – compostate.
All’obsolescenza tecnologica pianificata ci siamo ormai assuefatti, ne abbiamo tutti esperienza: i computer portatili che registrano la prima rottura fuori garanzia entro i primi tre o quattro anni di attività, la scocca di plastica degli ebook incollata in modo da rendere complicato aprirli e sostituirne la batteria, aziende che saldano le componenti interne dei propri device per avversarne la riparazione. Insomma, prodotti che si guastano secondo programma e che vengono deliberatamente progettati per non essere aggiustati, anche perché le case madri non forniscono in genere alcuna istruzione in merito e le comunità di riparatori indipendenti sono costrette ad organizzarsi dal basso, spesso e volentieri osteggiate dai marchi produttori. Il piccolo riparatore di smartphone Henrik Huesby, ad esempio, è stato citato a giudizio dalla Apple, una società da mille miliardi di dollari di capitalizzazione e 200 milioni di dispositivi venduti nel 2019, per aver riparato iPhone con schermi considerati contraffatti. Apple, dal canto suo, è stata multata per aver introdotto aggiornamenti che rallentavano il funzionamento dei vecchi modelli di iPhone, una pratica che gli analisti hanno ribattezzato throttling, “strozzamento”. È la nuova frontiera dell’obsolescenza indotta: non più un guasto precoce dei device a causa di difetti occulti, ma un sottile e pianificato disallineamento tra hardware e software che li rende di fatto inutilizzabili.
Mentre l’Unione Europea spinge per l’introduzione del diritto alla riparazione e per l’estensione della normativa sull’eco-design dagli elettrodomestici a smartphone, tablet e laptop, Apple ha dato negli ultimi anni un bel colpo di spugna alla propria immagine aziendale varando un vasto programma di iniziative “green”. Ha iniziato a riciclare (in parte) i dispositivi dismessi e per quelli di nuova fabbricazione utilizza (in parte) materiali di recupero. Ha installato pannelli solari nei propri centri e indirizzato i fornitori a ridurre le emissioni. I futuri modelli di iPhone saranno venduti senza adattatore per la ricarica e cuffie auricolari di modo da ridurre gli scarti elettronici – ma a quanto pare anche per abbattere il prezzo finale fatto lievitare dalle tecnologie di supporto al 5G.
All’obsolescenza tecnologica pianificata ci siamo ormai assuefatti: prodotti che si guastano secondo programma e che vengono deliberatamente progettati per non essere aggiustati.
Al tempo stesso, però, Apple resiste alle pressioni dell’Unione Europea per l’adozione del connettore USB-C come standard internazionale di ricarica e con la rimozione del jack audio ha inaugurato l’obsolescenza delle cuffie auricolari con cavo in favore del nuovo business dei sistemi wireless, ben più impattanti per via delle batterie incorporate. Parafrasando la nota burrasca di Schumpeter, si potrebbe parlare di innovazioni che fanno “creazione distruttrice”, col danno all’ambiente mascherato ad arte da beneficio. Tutto questo greenwashing di Apple e delle altre Big Tech ha l’effetto di sviare l’attenzione dal punto centrale della questione: perché l’industria elettronica e digitale non si è mai fatta carico dei rifiuti che produce e dei problemi ambientali che causano i suoi prodotti? In un’economia realmente sostenibile e circolare, ciò che inquina o non può essere riciclato, riparato e riutilizzato, dovrebbe essere riprogettato, altrimenti limitato nelle vendite e in ultima analisi bandito dal mercato.
Il mondo a portata di clic
Come ha scritto Samanth Subramanian in un articolo del Guardian (tradotto in Italia da Internazionale), anche il commercio digitale ha aggravato sensibilmente il nostro impatto sull’ambiente. Trasforma l’acquisto in un clic ed è come avere il mondo a domicilio, ti cambia radicalmente la percezione della realtà: “il grande inganno delle vendite al dettaglio online è stato spingerci a comprare sempre di più e a pensare sempre di meno, soprattutto a come arrivano gli acquisti a casa nostra”. Per resistere all’ultimo miglio critico, sballottati nei furgoni di consegna, i prodotti acquistati di comodo negli scaffali digitali richiedono un packaging decisamente più robusto: “aggiungere un millimetro di spessore al cartone per renderlo più resistente, se moltiplicato per centinaia di miliardi di scatole, può consumare un’intera foresta”. Spesso, scartando il pacco recapitato da Amazon, si ha l’amara sensazione di aver comprato più spazzatura che prodotto. Così, anziché smaterializzata, la forma merce esce dai mercati virtuali appesantita da un sovrappiù di esternalità ambientali sotto forma di imballaggio.
Pure la logistica del commercio elettronico si rivela estremamente inefficiente dal punto di vista ambientale. I centri di smistamento consumano molto suolo e spesso fanno land grabbing, i furgoni semivuoti dei corrieri ingorgano le strade e inquinano l’aria, i servizi digitali di vendita non sono altro che la variante esasperata e iper-consumistica del commercio analogico. Con internet possiamo consumare ad ogni ora del giorno e della notte, senza più nemmeno doverci alzare dalla sedia. “L’idea di un pacco che compare miracolosamente davanti alla porta di casa è molto affascinante”, commenta Subramanian. “Ci siamo abituati così in fretta ad accettarla da non capire veramente cosa comporta”. È indubbio che il commercio digitale ci regali un grande risparmio di tempo, ma come lo impieghiamo? Certo non impegnandoci a ridurre le nostre emissioni individuali, più probabilmente scrollando il feed di Facebook o le stories su Instagram. Internet ci libera il tempo, e poi ce lo sottrae.
Persino la logistica del commercio elettronico si sta rivelando estremamente inefficiente dal punto di vista ambientale.
Nel suo ultimo libro, I bisogni artificiali. Come uscire dal consumismo (ombre corte, 2021), il sociologo dell’ambiente Razmig Keucheyan fa notare che sì, “Amazon sarà anche un gigante del digitale, ma le merci che distribuisce sono proprio questo: delle merci, dotate di una materialità concreta”. A conti fatti la digitalizzazione degli scambi non ha affatto ridotto la circolazione degli oggetti materiali, anzi. Online si finisce per comprare più di quel che serve, si cede alla gratificazione immediata che azzera il tempo intercorso tra desiderio e acquisto, non si immagina minimamente quanta anidride carbonica possa accumulare la roba che mettiamo nel carrello virtuale. I prodotti acquistati con un clic nei mercati digitali viaggiano lungo le stesse rotte che le merci percorrono ormai da secoli, a bordo di navi portacontainer che solcano gli oceani bruciando oli combustibili pesanti. È servito che uno di questi cargo si mettesse di traverso nel canale di Suez per accorgersi dell’assoluta insostenibilità del traffico mercantile globalizzato, che le tecnologie digitali mica hanno diminuito, ma al contrario fomentato.
Contro l’alienazione generata dall’obsolescenza dei prodotti digitali e dal commercio compulsivo online Keucheyan propone di estendere l’anticapitalismo agli oggetti. “Il nostro problema oggi”, scrive, “è scongiurare la continua rivoluzione delle cose, interrompere la corsa precipitosa che sostituisce incessantemente l’ultimo gadget con uno nuovo, anch’esso subito colpito da obsolescenza e gettato come i suoi predecessori nei rifiuti della storia materiale”. Per rallentare l’oblio e l’incessante rinnovamento delle merci digitali serve emanciparle dalle esigenze capitalistiche dell’accumulazione, progettando beni che siano fin da principio più robusti, smontabili, modulari (ogni componente “deve essere utilizzabile e sostituibile separatamente”), interoperabili (“componenti e software devono essere tecnologicamente compatibili con quelli di altri marchi”) ed evolutivi (“incorporano nella loro progettazione le future evoluzioni tecnologiche”).
Emancipati sono quindi quei beni per i quali l’equilibrio di potere tra valore d’uso e valore di scambio torna a volgersi a favore del primo, come nel caso del Fairphone, lo smartphone pensato dagli sviluppatori con l’intento di minimizzarne l’impatto ambientale e massimizzarne il ciclo di vita. Per scardinare la dialettica tra il vecchio e il nuovo che fa da fondamento all’economia digitale servirebbe poi allungare la garanzia a copertura dei suoi prodotti, assecondando un desiderio di durabilità che è di per sé naturale nel consumatore medio. “La garanzia non sembra granché”, suggerisce Keuchayan, “ma è una potente leva per la trasformazione economica e, di conseguenza, politica”. E aggiunge: “il passaggio a dieci anni [di garanzia] ci porterebbe in un altro mondo, la forma merce ne verrebbe sconvolta”.
La via della sostenibilità, secondo Razmig Keucheyan, passa per la pianificazione degli sviluppi tecnologici, il ritorno al valore d’uso delle cose, e la gestione etica del fine vita degli oggetti.
L’efficientamento tecnologico delle ICT farà indubbiamente il suo corso, i device impiegheranno sempre meno energia per unità di calcolo e continueranno perciò a moltiplicarsi, ma in ogni caso la tecnica non basterà a fermare da sola se stessa. Per interrompere la crescita insostenibile delle tecnologie digitali c’è bisogno di misure politiche – come appunto l’estensione della garanzia legale – ambiziose e niente affatto scontate, eppure tutt’altro che implausibili. Il 60% delle banche nazionali, ad esempio, sta prendendo in considerazione l’ingresso nel mercato delle criptovalute e il 14% sta già facendo dei test per riportare questa diramazione della tecnofinanza sotto il controllo dello stato: cosa che, al netto dei rischi di un’eccessiva centralizzazione, avrebbe almeno l’effetto di arginare la proliferazione speculativa dei miners privati e offrirebbe maggiori garanzie sul taglio obbligato delle emissioni per l’intero settore.
Simile negli intenti all’ipotesi di nazionalizzare la moneta digitale era la provocazione, lanciata qualche anno da Morozov, di “socializzare” i data center. Server, supercalcolatori e big data sono infatti strumenti troppo potenti e importanti per rimanere in mano agli oligopoli digitali e servire al saggio di profitto del capitalismo data-centrico. Occorrerebbe trovare il coraggio politico di democratizzarli, metterli al servizio di una pianificazione economica e tecnologica internazionale che tenga finalmente conto della necessità di preservare quanto più possibile materia ed energia. Pianificazione degli sviluppi tecnologici, ritorno al valore d’uso delle cose, socializzazione dei mezzi di produzione digitali e gestione etica del fine vita degli oggetti. Secondo Keucheyan è questo quello che serve per far sì che alla rivoluzione digitale segua davvero anche quella ambientale. Un passaggio che nel mondo dell’industria informatica e dell’economia digitale in cerca di una difficile sostenibilità appare, a molti, ormai inevitabile.