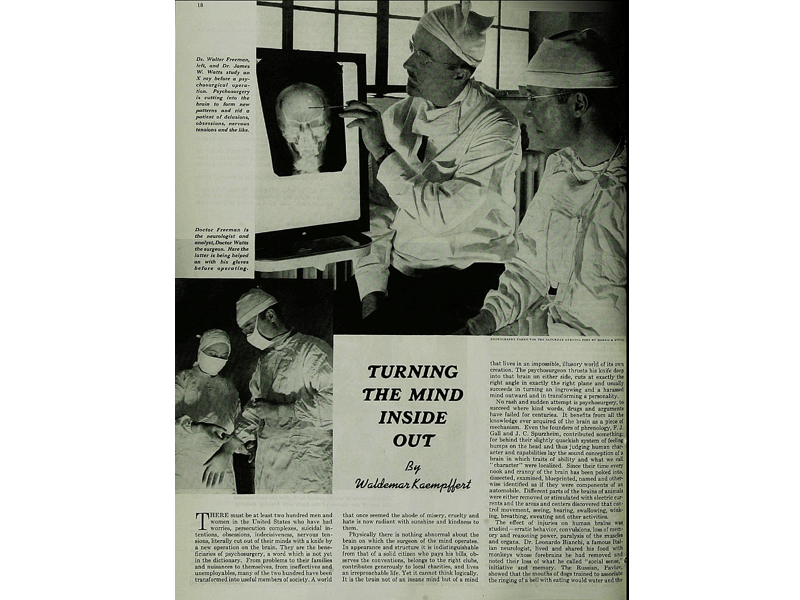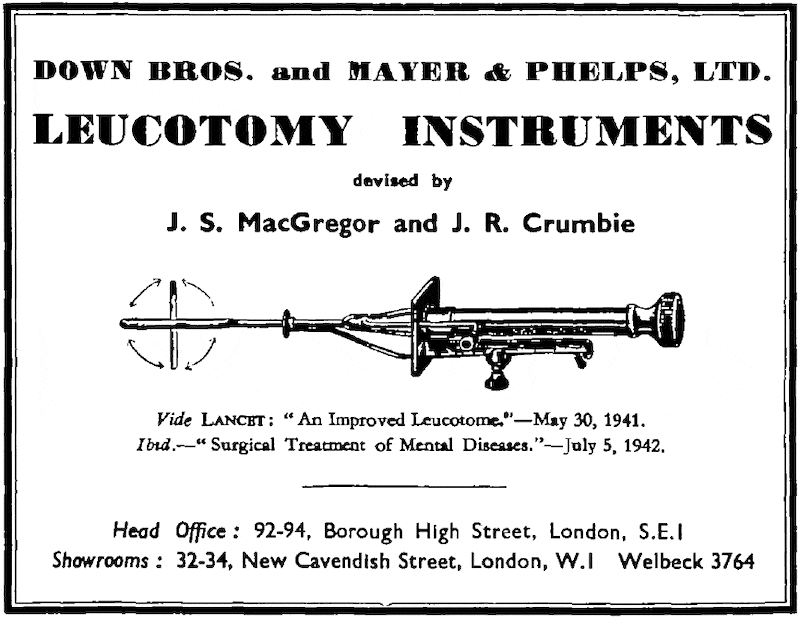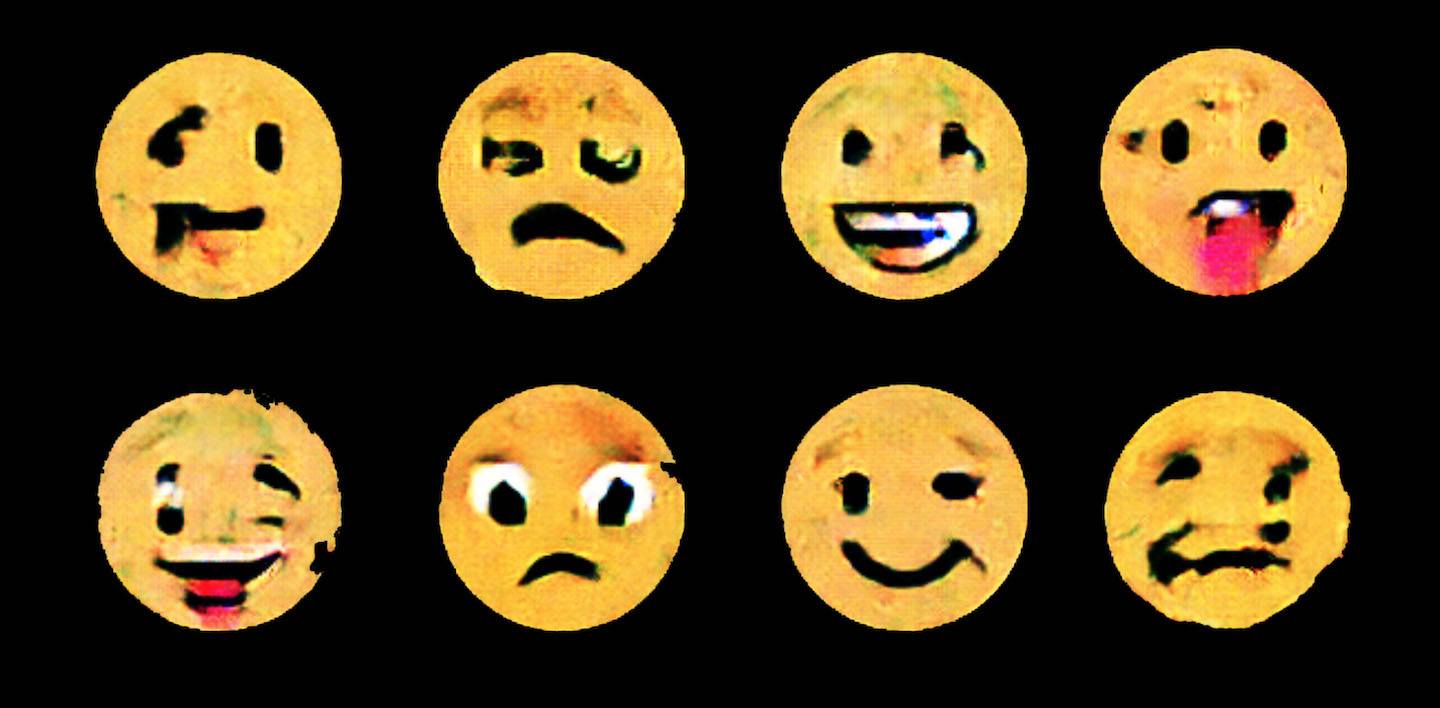
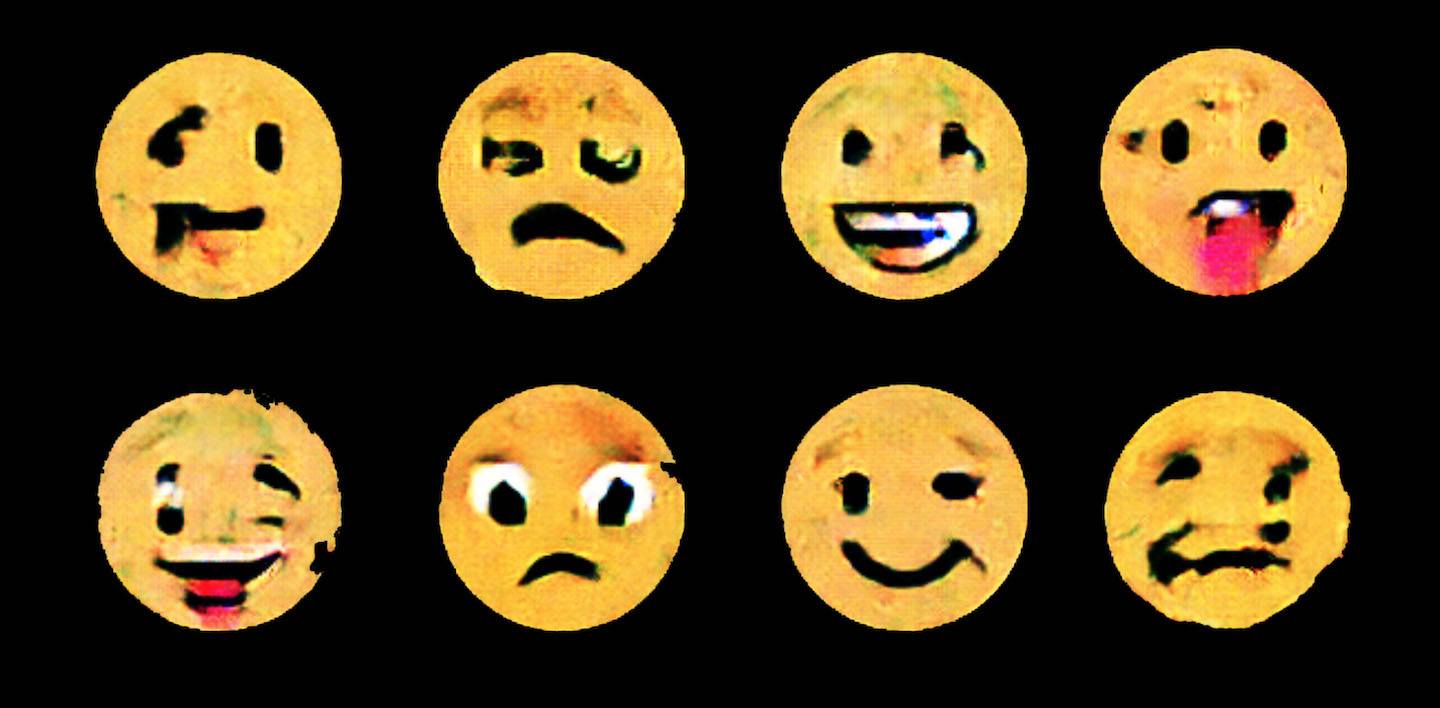
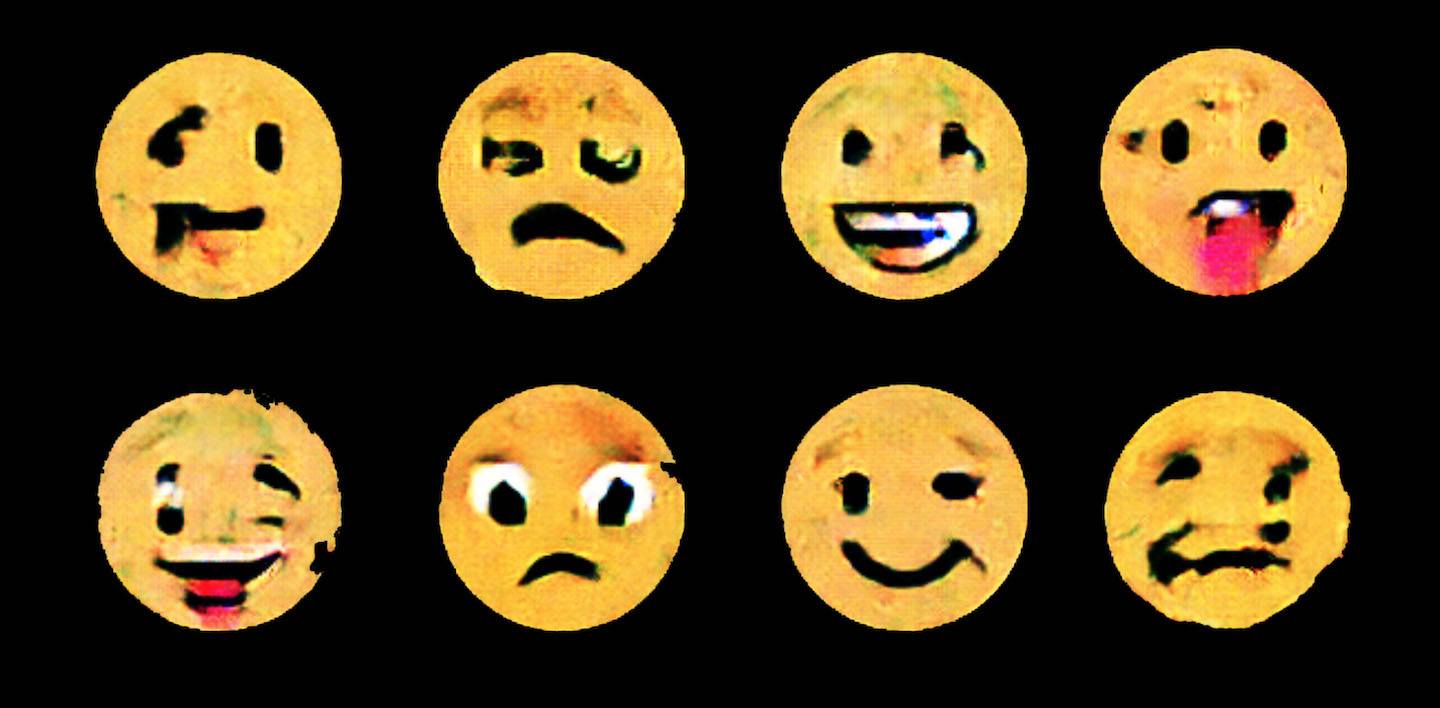
B isogna ammettere che l’idea era seducente: per ricondurre le persone con gravi malattie psichiatriche a un comportamento socialmente accettabile si pensava fosse sufficiente recidere o inabilitare parti del tessuto dei lobi frontali del cervello. L’idea trovava il suo fondamento in una storia medica ben precisa: la convinzione che comportamenti ossessivi, intrattabilità o allucinazioni fossero provocati da un eccesso di impulsi emotivi che raggiungevano i lobi frontali dal talamo. Sugli animali l’asportazione dei lobi frontali aveva funzionato, rendendoli subito più mansueti. Nel 1888 lo psichiatra svizzero Johann Gottlieb Burckhardt pensò di estendere la pratica a sei pazienti internati nella sua struttura: uno morì, tre migliorarono, due non mostrarono cambiamenti. I risultati, come illustrano Luigi Garlaschelli e Alessandra Carrer in Scienziati Pazzi (Carocci, 2017) non potevano certo considerarsi entusiasmanti, eppure l’idea che la soluzione a problemi complessi si trovasse nella sistemazione “meccanica” di una parte del nostro cervello non venne del tutto abbandonata.
Si continuò a investigare su quella che veniva definita leucotomia, o lobotomia, fino a che il medico portoghese Antonio Egas Moniz, durante un convegno nel 1935, ne rimase così affascinato da decidere che un esperimento di laboratorio fosse pronto a diventare pratica medica. Moniz era convinto che, nelle persone affette da schizofrenia, disturbo bipolare, ansia e depressione, le idee morbose dominassero l’attività psichica saldando delle connessioni stabili a livello neurale. Per guarirle sarebbe bastato allora rompere queste connessioni e “costringere il pensiero in circuiti nuovi”. Quindici anni dopo, settanta anni fa, l’intuizione gli valse il Nobel per la medicina.
Riduzionismo e danni collaterali
L’idea non affascinò solo Egas Moniz ma anche una parte più o meno nutrita della comunità medico scientifica mondiale. Tra i più entusiasti sostenitori della lobotomia figura il neurologo statunitense Walter Freeman che in circa trent’anni lobotomizzò più di 2.400 pazienti: donne, uomini, reduci, bambini. Alcuni dei suoi pazienti erano anche molto celebri, come Rosemary Kennedy, una delle sorelle del presidente. Venne lobotomizzata nel 1941 all’età di 23 anni e riprese ad articolare qualche parola solo 28 anni dopo. All’epoca Freeman non operava più. Gli venne revocato il permesso di farlo alla fine degli anni sessanta.
Nella sua biografia più completa, scritta dal giornalista scientifico Jack El-Hai nel 2007, Freeman appare come un medico talmente affascinato dalla sua soluzione da restare fino all’ultimo suo strenuo difensore. Anche quando, negli anni Cinquanta, vennero introdotti farmaci psicoattivi che ne segnarono il lento ed inesorabile declino. “La lobotomia non curava nessuna malattia, ma in alcuni casi mascherava i sintomi”, spiega El-Hai, “all’epoca esistevano pochi trattamenti efficaci per le persone che soffrivano di gravi malattie psichiatriche”. E infatti Freeman difese e affinò le tecniche di Moniz fino a trasformare un intervento chirurgico in una semplice operazione che si praticava introducendo un punteruolo simile a un rompighiaccio attraverso le orbite.
La leucotomia frontale era dunque una sorta di palliativo con molti rischi. Nel libro di El-Hai vengono citati molti casi in cui i pazienti soffrivano di gravi danni collaterali: qualcuno restava in stato vegetativo, qualcuno moriva, altri perdevano cognizione del linguaggio o di sé stessi. A questi però si affiancano anche casi che Freeman considerava riusciti. Ellen Ionesco, lobotomizzata nel 1949 per i suoi comportamenti ossessivi e per aver manifestato istinti suicidi, dopo l’operazione veniva ricordata così dalla figlia: “dopo la convalescenza tornò a casa, si occupò di me, diventò un’infermiera […] diventò una persona produttiva, guadagnava il suo salario. Faceva parte della chiesa ed era una gran cuoca”. Anni dopo l’operazione, Freeman visitò di nuovo Ionesco e considerò che in effetti si trovava in buona salute.
Ancora prima, Harry A. Dannecker si era fatto testimone ancora più deciso dei benefici della lobotomia firmando un articolo dal titolo La psicochirurgia mi ha curato, uscito su Coronet nel 1942. Vero è che all’epoca c’era anche chi manifestava critiche sempre più accese alla foga con cui Freeman si era messo in testa di liberare il mondo dalla malattia mentale. E c’era anche chi cercava di cavalcare l’onda in senso opposto. A questo proposito El-Hai cita nel suo libro l’esistenza di una pubblicità che recitava: “I dottori dicono che si possono tagliare via le preoccupazioni dal cervello con un coltello. C’è un modo migliore: andate in chiesa”. Nonostante le critiche, gli evidenti abusi (come sottoporre a lobotomia bambini e ragazzi) e i risultati mediocri, la lobotomia per molti anni non perse il suo fascino. Tanto che l’esercito americano decise di applicarla come trattamento comune per i reduci già dal 1949.
Spiega Maria Grazia Giannichedda, presidente della Fondazione Franca e Franco Basaglia, che la seduzione della semplicità di una soluzione meramente chirurgica o farmacologica a problemi complessi non è solo cosa d’allora. “Bisogna ricordare” dice, “che la medicina occidentale moderna, e questo è un punto più complesso, e forse più grave del granchio preso dall’accademia svedese, si è costituita sui corpi morti: sui cadaveri. Non sulle persone”. E aggiunge che la tensione “riduzionista” ovvero la tendenza a ridurre le persone a una mera manifestazione di impulsi fisiologici, biologici, meccanici (verrebbe quasi da dire) è sempre presente. Perché a ben vedere infatti, la vera domanda a cui cercavano di rispondere Freeman, Moniz, Buckhart e chi è venuto prima di loro (e forse anche chi è venuto dopo), risiede nell’individuazione dell’origine della malattia e nella definizione della normalità. Secondo Gianichedda la prima non può che avere un’origine complessa, mentre la seconda non ha che una definizione impossibile.
“L’esistenza di una mono-causalità in senso positivistico del comportamento umano è stata ormai abbandonata. Rappresenta poi una visione dell’umano scientificamente infondata e umanamente patetica”. Questo non significa che la malattia mentale non esista, ma che “è determinata da una serie di concause”.
Mente e cervello
Howard Dully, paziente lobotomizzato da Freeman a 12 anni, una quindicina di anni fa raccontava così alla NPR la sua reazione all’operazione: “A vedermi non diresti mai che sono stato sottoposto a una lobotomia […] ma mi sono sempre sentito diverso – come se alla mia anima mancasse qualcosa – non ho memoria dell’operazione e non ho mai avuto il coraggio per chiederlo alla mia famiglia”. Affermazioni che restituiscono la complessa relazione che esiste tra la personalità, il comportamento, le condizioni ambientali e sociali in cui viviamo e il funzionamento del nostro cervello: “Che cosa è la mente e che cos’è il cervello è una bella domanda”, dice Gabriele Miceli, ordinario di Neurologia del CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente/Cervello) dell’Università di Trento. “Diciamo che si può affermare che i processi mentali sono il risultato del funzionamento dei meccanismi neurali che hanno sede nel cervello”.
Miceli spiega inoltre che l’evoluzione tecnologico-medica ci ha permesso nel tempo di mappare l’attività neuronale con un grado di complessità impensabile solo qualche decennio fa. “Oggigiorno possiamo registrare i fenomeni nel momento stesso in cui si verificano e a partire da queste osservazioni inferire i meccanismi neurali sottostanti”, aggiunge ricordando come in tempi recenti lo studio della malattia mentale si sia sviluppato attraverso l’influenza di scuole di pensiero diverse: ora più orientate alle emanazioni della psicoterapia, ora più orientate alla cura farmacologica. “Gli psicofarmaci hanno assunto progressivamente una maggiore precisione e le terapie hanno ridotto i loro effetti collaterali”. Tuttavia la cura non può prescindere da un approccio multidisciplinare in un delicato equilibrio tra il raggiungimento del benessere e l’invasività delle terapie che necessariamente alterano i funzionamenti neurologici.
Secondo Garlaschelli la lobotomia “oltre che a essere orripilante”, si è “rivelata essere praticamente inutile”. Secondo El-Hai, un’eredità che ci ha lasciato è quantomeno “l’intuizione che molte malattie psichiatriche abbiano cause organiche radicate nei meccanismi fisici e chimici del cervello”. Tra i casi che avevano preceduto il Nobel a Moniz, ce n’era stato anche uno emblematico, e molto studiato, che in qualche modo testimoniava la complessità della ricerca sul rapporto tra fisiologia, neurologia e comportamento: a metà del Diciannovesimo secolo, l’operaio statunitense Phineas Gage venne trafitto da un’asta che gli trapassò il lobo frontale sinistro mentre lavorava alla costruzione di una ferrovia. Gage sopravvisse miracolosamente all’incidente, ma con il tempo sviluppò una personalità talmente aggressiva e volubile da renderlo quasi irriconoscibile a familiari, amici e colleghi.
Negli Stati Uniti sono state lobotomizzate circa 50.000 persone, secondo la NPR. In Inghilterra i lobotomizzati furono 17.000, in Svezia più di 9.000, secondo quanto si legge in Scienziati pazzi. L’Italia vanta il primato di aver sperimentato ancora prima di Freeman la tecnica del punteruolo grazie ad Amarro Fiamberti, direttore di un manicomio di Varese. Oggi l’unica forma di lobotomia non vietata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è una pratica mirata e selettiva: la leucotomia temporale anteriore in casi di epilessia, in pazienti che non rispondono ai farmaci.