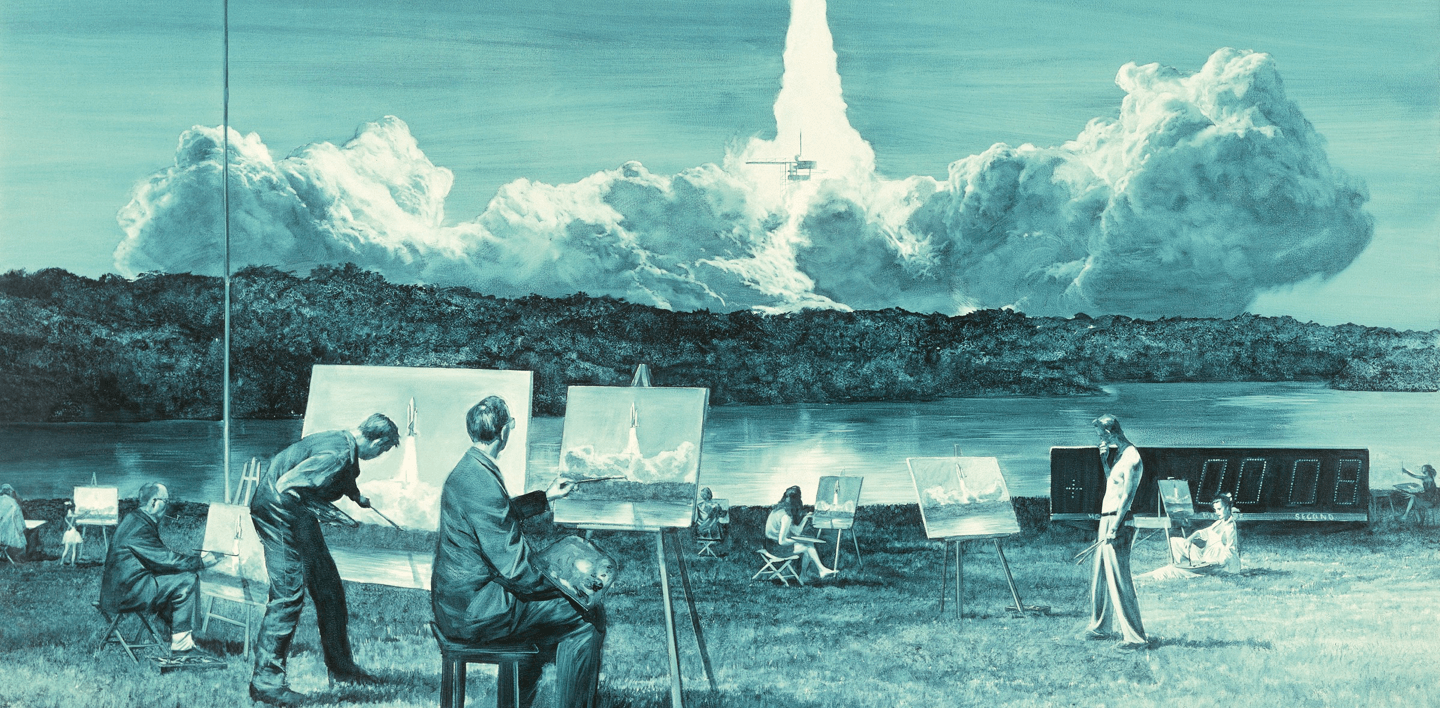
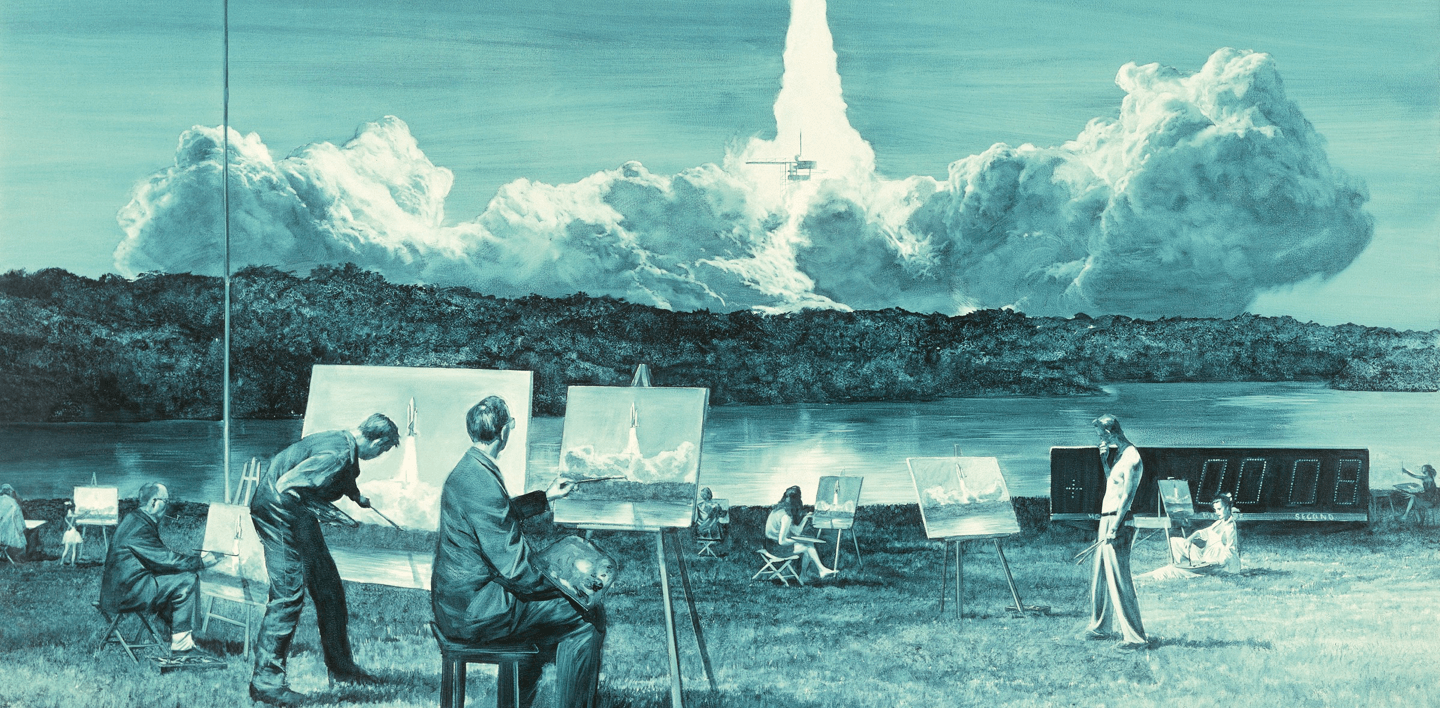
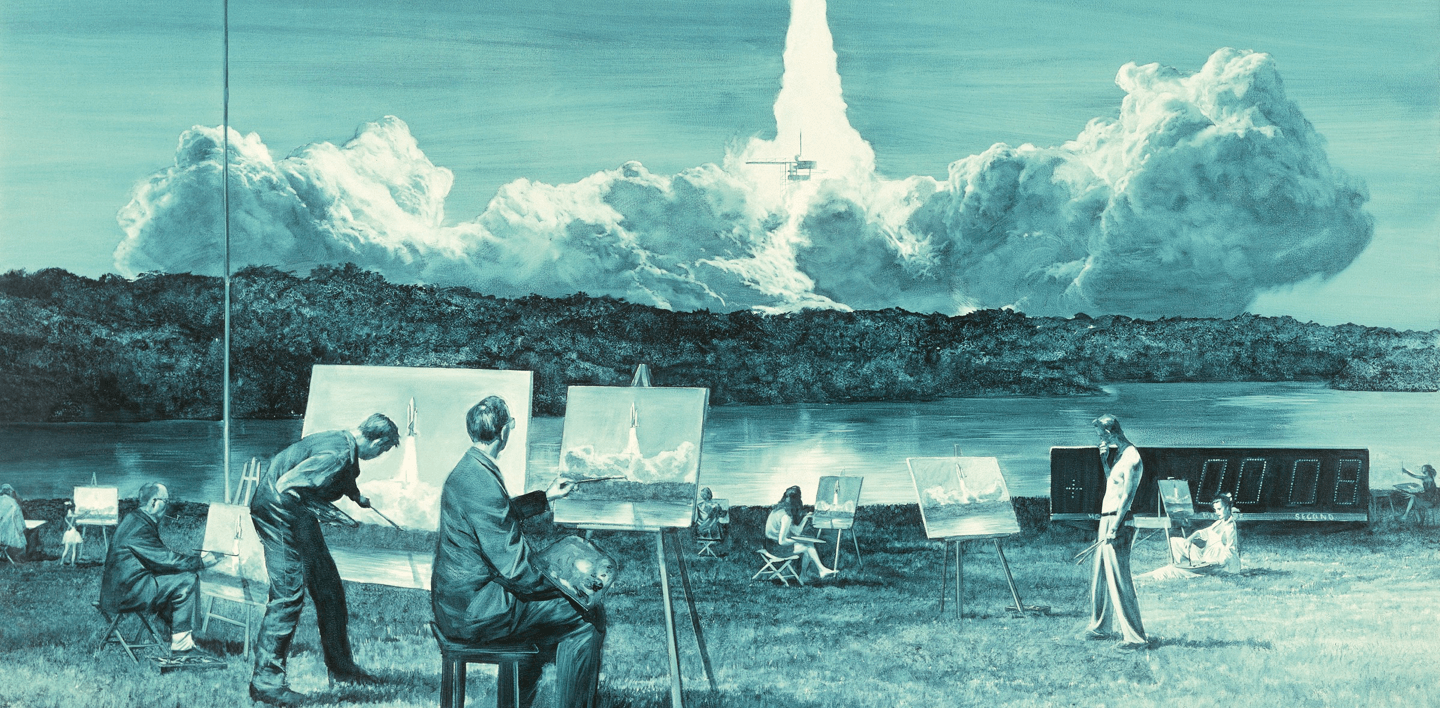
I mmaginate di essere ospiti a casa di qualcuno per un tè. Passato un po’ di tempo chiedete dov’è il bagno e il padrone di casa vi dice “dopo il corridoio gira a sud, poi la seconda porta a ovest”. Con tutta probabilità siete in casa di una persona che parla una lingua diversa dalla vostra, una delle molte di lingue che si basano su un sistema di coordinate spaziali geografiche, “assolute” invece che “egocentriche” come quelle a cui siamo abituati (per cui il bagno è “dopo il corridoio a destra, poi la seconda porta a destra”). Secondo l’antropologo Stephen Levinson, che ha studiato le conseguenze cognitive della descrizione spaziale nella lingua guugu yimithirr, popolazione aborigena australiana, chi parla questo genere di lingue è costretto a costruirsi una sorta di “bussola mentale” per soddisfare la richiesta di essere costantemente a conoscenza della direzione cardinale in cui si è orientati – e finisce per ricordarla anche a distanza di anni, quando racconta qualche evento che ha vissuto.
La struttura di una lingua richiede di rispettare determinate regole per poter essere parlata in maniera coerente e comprensibile. Ciò che tutti noi facciamo imparandone una qualsiasi è abituarci lentamente ma inesorabilmente a fare nostre queste “richieste” e ciò, verosimilmente, lascia un segno permanente nei meccanismi della nostra mente. Possiamo dire che le lingue impongono ai propri parlanti un’immagine della realtà che è diversa da lingua a lingua? Che una lingua può cambiare la comprensione dei concetti più basilari di chi la parla, come lo scorrere del tempo, la posizione degli oggetti, la dinamica degli avvenimenti?
L’affascinante e controversa idea che ciascuna lingua contribuisca a costruire la realtà oggettiva dei propri parlanti è stata chiamata nei primi decenni del Novecento “relatività linguistica”, in un audace tentativo di analogia con la relatività in fisica, che in quegli anni aveva dato grande popolarità ad Albert Einstein. Senza scendere nei dettagli della sua genesi, possiamo dire che quest’idea viene etichettata ancora oggi come “ipotesi Sapir-Whorf”, dal nome del linguista Edward Sapir e del suo allievo Benjamin Lee Whorf, a dispetto del fatto che né i due formularono una singola proposta nettamente identificabile come tale, né tantomeno lo fecero congiuntamente. Di solito, ad essere riconosciuto come padre del “principio di relatività linguistica” è infatti il solo Whorf, noto per la sua eclettica vita intellettuale. Studiò ingegneria chimica all’MIT senza brillare e per mantenersi, in seguito, lavorò come perito chimico per una società di assicurazioni. Infine si iscrisse a Yale seguendo le lezioni di linguistica di Sapir, di cui finì addirittura per rilevare la cattedra a ridosso della morte, prima che lo stesso Whorf morisse prematuramente di cancro. Whorf si avvicinò allo studio del linguaggio tramite la lettura di testi settecenteschi d’ispirazione cabalistica che ravvisavano un rapporto speciale tra lingua e misticismo, e per quanto negli anni di Yale fosse rientrato, per così dire, nei binari della linguistica scientifica del tempo (tanto che svolse approfondite ricerche sul campo studiando lingue di comunità native meso e nordamericane), l’interesse per il mistico non lo abbandonò mai: il suo ultimo saggio, Language, Mind, and Reality, pubblicato postumo, apparve su una rivista indiana di teosofia.
Le lingue impongono ai propri parlanti un’immagine della realtà che è diversa da lingua a lingua? Una lingua può cambiare la comprensione dei concetti più basilari di chi la parla, come lo scorrere del tempo, la posizione degli oggetti, la dinamica degli avvenimenti?
Nello specifico, Whorf studiò la lingua di una comunità di nativi americani dell’Arizona, gli hopi, e arrivò a sostenere che, mancando di marcatori verbali (così come di sostantivi) per quelli che nelle lingue europee chiamiamo tempi “futuro”, “presente” e “passato”, i parlanti hopi finissero per avere una concezione non-lineare del tempo, sorprendentemente vicina a quella proposta da Einstein con la teoria della relatività. Da qui, l’espressione “relatività linguistica”. (Questa intuizione sulle differenti concezioni temporali è stata recuperata nel film di Denis Villeneuve Arrival, basato sul racconto di Ted Chiang Story of your life, in cui a vivere il tempo circolarmente non sono dei nativi americani ma degli alieni a forma di seppia gigante).
Più in generale, tuttavia, l’idea whorfiana di fondo è che alla diversità linguistica possa corrispondere una diversità cognitiva. Se le lingue sono evidentemente diverse in molti dei loro aspetti formali e se la cognizione umana è legata a doppio filo con lo sviluppo linguistico, allora è assai probabile che chi cresce parlando una determinata lingua ne sia influenzato a livello dei vari processi di pensiero.
Se quest’influenza sia costante, aggirabile, o misurabile sono tutte questioni che, soprattutto a partire dagli anni Novanta, sono state indagate empiricamente in psicolinguistica, prendendo in esame lingue da tutto il mondo, incluse anche quelle parlate in piccole comunità non-occidentali. Un bilancio provvisorio e lapidario di quello che in accademia è stato chiamato “rinascimento whorfiano” (o neowhorfismo) indicherebbe che, sì, perlomeno in determinati e specifici domini e processi cognitivi (come la memoria, l’orientamento spaziale, il ragionamento, e così via), i parlanti si comportano, e quindi pensano, in maniera diversa in funzione delle differenze strutturali tra le rispettive lingue.
Azzardando un bilancio, la scienza attuale pare dirci che è vero che la lingua influenza il modo in cui concepiamo la realtà. Fino a che punto, è meno chiaro.
Lingua e genere
Le categorie espresse dalle strutture linguistiche sono davvero numerose. Oltre ai già citati spazio e tempo, si sono studiati molto i termini per i colori (per esempio, in giapponese c’è una sola parola per indicare ciò che in italiano sono “verde” e “blu”: questo influenza le operazioni cognitive legate ai colori?), ma anche categorie meno intuitive come i termini di forma contro quelli di sostanza (il maya yucateco concettualizza gli oggetti per il materiale di cui sono fatti, più che per la forma geometrica che hanno, per cui un cilindro di vetro è “un vetro” più che “un cilindro”). Tra queste rientra anche il genere grammaticale. In alcune lingue, compreso l’italiano, anche gli oggetti inanimati hanno un genere e questo, secondo la psicologa Lera Boroditsky, influenza l’immaginario che ne abbiamo. In tedesco, “chiave” (Schlüssel) è maschile, mentre in spagnolo (llave) è femminile e i parlanti intervistati da Boroditsky hanno liberamente associato aggettivi “più mascolini” in tedesco (la chiave era pesante, dentellata, dura) e “più femminili” in spagnolo (elegante, carina, delicata).
Al di là di come si vogliano interpretare questi risultati (l’associazione di quegli aggettivi al “mascolino” e al “femminile” è a dir poco stereotipata), quando pensiamo ai termini che si riferiscono a persone, il dibattito si accende. Non a caso, recentemente si è molto discusso di linguaggio inclusivo, ovvero di come le lingue, tramite le strutture linguistiche obbligatorie che i parlanti sono tenuti a rispettare, finiscano per “escludere” alcune categorie di persone dal riferimento.
Recentemente si è molto discusso di linguaggio inclusivo, ovvero di come le lingue, tramite le strutture linguistiche obbligatorie che i parlanti sono tenuti a rispettare, finiscano per “escludere” alcune categorie di persone dal riferimento.
Certo, sarebbe irragionevole pensare che Massimo D’Azeglio, nel sentenziare che “fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, volesse scientemente escludere tutte le donne. Così come quando al supermercato si invitano “i gentili clienti” a recarsi alla cassa è spontaneo anche per chi non si riconosce nel genere maschile sentirsi chiamata in causa. Ma non rivendicare una volontaria discriminazione nell’utilizzo di “direttore” al posto di “direttrice” e ricordare che la sovraestensione del maschile è una convenzione secolare è sufficiente? Negli ultimi anni un numero crescente di persone – a partire proprio da quelle che restano sistematicamente escluse – ha proposto diverse soluzioni per modificare (o integrare) alcune lingue in modo da includere determinate categorie (sebbene ci sia anche chi, pur riconoscendo l’importanza di queste istanze emancipatorie, pare avere molte difficoltà nell’accettare gli specifici correttivi proposti, come l’asterisco o lo schwa come desinenze). Alla base di tutti questi discorsi c’è un’idea potente che motiva la volontà di diffondere il più possibile le forme inclusive, qualsiasi esse siano: che la comprensione della realtà sia in qualche modo influenzata dal linguaggio. L’abbiamo visto prima: è del tutto verosimile che se una lingua che marca il genere grammaticale lo fa in maniera binaria tra femminile e maschile, i parlanti siano portati, da un lato, a pensare che non esista nulla al di fuori di questo binarismo e, di conseguenza, che tutto debba ricadere in uno di questi due generi grammaticali.
Potrebbe sorprendere, quindi, che in un articolo apparso su L’Indiscreto e firmato dal filosofo e blogger Erik Boni la relatività linguistica sia stata presa invece come argomento contrario a qualsiasi misura di modifica di una lingua pensata con il fine di modificare la percezione della realtà di chi la parla. Boni, soppesando ambizioni e mancanze delle proposte di linguaggio inclusivo italiano, finisce col bocciarlo, e tra le varie ragioni cita proprio l’implausibilità della “tesi di Sapir-Whorf” che renderebbe quindi inefficaci le misure che su di essa pretendono di fondarsi. E la colpa della tesi, secondo l’autore, sarebbe proprio quella di “sopravvalutare il potere del linguaggio” e i suoi effetti sulla realtà extralinguistica.
La critica di Boni è prima di tutto filosofica: la relatività linguistica intesa come premessa a qualsiasi genere di “programmazione” linguistica è in fondo illusoria, scrive, perché nella pratica dialogica dei parlanti le parole non sono “armi” dal potere magnetico e inappellabile che si scontrano fra loro. Vige piuttosto il principio di carità interpretativa che spinge i parlanti a cercare di capirsi reciprocamente: una parola attrae sì l’attenzione, ma è anche sempre interpretabile. In questo caso, secondo Boni, a chi usasse un maschile sovraesteso basterebbe chiedere “veramente intendi, ipso facto, escludere il genere femminile?” a cui, idealmente, basterebbe rispondere qualcosa come “niente affatto, si tratta di una convenzione linguistica”. (Bisogna a questo punto registrare il fatto che alcune università italiane hanno cominciato ad apparire delle note esattamente di questo tenore in calce a documenti ufficiali di segreteria, a mo’ di disclaimer rispetto all’utilizzo generalizzato del maschile quando si parla di candidati, ricercatori, e così via).
Boni, in sostanza, critica una visione determinista e assolutista di come il linguaggio sia legato al nostro rapporto con la realtà extralinguistica. Non a caso, nel rifiutare questa visione, cita 1984 di Orwell, nella cui distopia gioca un ruolo fondamentale la famigerata Neolingua, ovvero un progetto radicale di riforma linguistica “dall’alto” che ha l’obiettivo di eliminare o risemantizzare determinati lessemi al fine di cancellare nella massa dei parlanti i concetti (mentali) associati ad essi. Rozzamente, l’idea è che se cancelliamo dal vocabolario tutte le parole che derivano da “compassione”, alla lunga nessuno sarà più in grado di essere compassionevole, o di riconoscere e capire la compassione.
È del tutto verosimile che se una lingua che marca il genere grammaticale lo fa in maniera binaria tra femminile e maschile, i parlanti siano portati a pensare che non esista nulla al di fuori di questo binarismo.
È da considerarsi senz’altro voluta l’esagerazione per cui Orwell finisce nello stesso calderone insieme a Whorf, gli spin doctor politici e i pubblicitari, ma, nondimeno, si commette così un’ingiustizia nei confronti della relatività linguistica, esagerandone le pretese. Se infatti si fa dire ai relativisti del linguaggio, così come agli epigoni contemporanei, che chi parla lingue diverse vive in bolle fondamentalmente incomunicabili, semplicemente si sbaglia. Questa mossa è tuttavia frequente nelle critiche alle idee di Sapir e Whorf, anche in contesti accademici e del tutto slegati dai temi sociali. Ma ciò accade anche perché si confonde spesso la più accettabile relatività con lo spaventoso relativismo.
Lo spaventoso relativismo
La relatività, come concetto, non nasce né con Whorf né con Einstein: in fisica se ne parla sin da Galilei per quanto riguarda il moto inerziale. Con una sintesi brutale, si può dire che quelli della relatività sono princìpi che ricalibrano le pretese di poter parlare di certi fenomeni naturali in termini puramente assoluti, cioè slegati da qualsiasi altro parametro legato al contesto. Il relativismo, invece, è una tesi filosofica dalla storia ancora più antica e dalle molteplici declinazioni a seconda di quale ambito lo si applichi – la verità, la conoscenza, la morale, le culture, ecc. In ciascuna di queste incarnazioni parlare di relativismo ha un senso diverso. Ad esempio, il relativismo culturale viene di solito connotato positivamente: si tratta di quella presa di consapevolezza riguardo alla pluralità di modi di vivere umani che ci serve per non cadere nell’assolutismo xenofobico: come faceva notare Wittgenstein commentando l’etnografia del Ramo d’oro di Frazer, è scorretto giudicare errori le credenze magiche e religiose di una certa comunità. Allo stesso modo, Montaigne dissentiva sui criteri con cui i missionari bollavano come “barbarie” gli usi dei nativi dell’Amazzonia nel Cinquecento. Il relativismo etico, invece, potrebbe essere descritto come una problematizzazione di quello culturale: che conseguenze pratiche è giusto trarre dalla diversità dei valori e dei costumi? Esiste un obbligo morale di “correggere gli errori” o impedire la “barbarie”?
Ma il relativismo per eccellenza è probabilmente quello aletico (cioè sulla verità), che – in estrema sintesi – ammette che qualcosa possa essere contemporaneamente vero per qualcuno e falso per qualcun altro, sfidando il principio di non contraddizione. Come può essere lo stesso fiato di vento freddo per qualcuno e caldo per un altro? E così via. In questo senso, il relativismo, in maniera simile allo scetticismo, è valso nella storia della filosofia come uno spettro da cui ogni epoca di pensatori ha sentito l’obbligo di difendersi. In tempi recenti, la condanna del relativismo di Papa Ratzinger ha riaperto ancora una volta la riflessione pubblica in merito.
I relativisti del linguaggio non dicono però che chi parla lingue diverse vive in bolle fondamentalmente incomunicabili.
In tutto ciò, nei repertori di quelle che la filosofa Maria Baghramian chiama “le molte facce del relativismo”, la relatività linguistica spesso è del tutto assente o citata frettolosamente: la scelta di trascurarla deriva dal fatto che è fondamentalmente errato considerarla una tesi altrettanto estrema rispetto a forme radicali di relativismo aletico. Le implicazioni problematiche di quest’ultimo sono di amplissima portata – da cui lo spavento filosofico che il relativismo incute da sempre. La possibilità di affermare una (la) verità delle nostre credenze o di formulare asserzioni sul mondo esterno è una faccenda di importanza capitale, ma difficilmente la relatività linguistica investe campi simili.
Questa erronea equiparazione non è rara anche all’interno dell’accademia: per molti decenni, dopo la morte di Whorf e in contemporanea all’ascesa del paradigma universalista chomskiano in linguistica che paragonava la facoltà di linguaggio a un organo biologico (e quindi condiviso dall’intera specie umana), la relatività linguistica non ha affatto goduto di buona fama. Le motivazioni erano diverse. Naturalmente, la vicenda intellettuale nient’affatto ortodossa di Whorf non ha aiutato la causa: difficile inserire nel programma della nascente scienza cognitiva un dilettante dalle tendenze misticheggianti. Così come è stato (e tuttora è) facile fraintendere i suoi scritti, soprattutto quelli in cui espone il principio di relatività linguistica facendola scivolare in una interpretazione deterministica, per cui i parlanti non avrebbero scampo dalle strutture di pensiero trasmesse dalla proprio lingua. Ma si tratta, appunto, di un abbaglio.
In difesa della relatività
Da un lato è facile arrivare a chiedersi: se è vero che la lingua mi influenza inconsciamente nella mia concezione pratica e quotidiana della realtà, come mai potrò riuscire a sfuggirvi? Anche se non si è sempre impegnati a parlare, leggere o scrivere, è pur vero che pensiamo “nella” lingua che parliamo. La profondità del nostro essere immersi nelle lingue è tale che persino i sogni sono colorati dagli idiomi che conosciamo. Così, se il linguaggio è pervasivo della nostra vita cognitiva, affettiva e fisica, allora non stupisce che sembri una sorta di gabbia dalla quale è impossibile uscire.
A dire il vero, per chiarire la questione basterebbe leggere quella lettera di Whorf in cui scrive una volta per tutte che il linguaggio è soltanto uno dei fattori che contribuiscono a guidare il comportamento di un individuo e, da ultimo, a formare la sua “visione del mondo”. Ma, volendo affrontare il problema in termini generali, ci torna utile proprio la distinzione tra relativismo e relatività. Come ricorda Penny Lee, studiosa e biografa di Whorf, la sua relatività, così come quella di chi la studia oggi, non faceva assolutamente appello a una incommensurabilità tra visioni del mondo diverse. La ragione è semplice: deve pur esserci qualcosa di comune tra i parlanti perché possa darsi una qualunque sorta di disaccordo. E qui il terreno comune non è altro che la comprensione non-linguistica, e anche prelinguistica, del mondo, che chiaramente esiste, tanto per dirne una, negli animali non umani.
A ben vedere, è proprio l’analogia con la fisica che suggerisce che ciò che il relativista del linguaggio vuole capire è quale sia il ruolo delle risorse linguistiche nella mediazione – nelle parole di Lee – tra “le invarianti del mondo circostante nel quale gli esseri umani trascorrono la propria esistenza” e “le invarianti della lavorazione cognitiva dei dati percettivi”. Sembra perciò che la relatività linguistica non si preoccupi tanto dell’idea di mondi reciprocamente e totalmente incomunicabili (cioè di relativismo), quanto piuttosto delle impressioni diverse che otteniamo a causa della lingua, a partire da uno stato di cose che è il medesimo per tutti.
La relatività linguistica non si preoccupa tanto dell’idea di mondi reciprocamente e totalmente incomunicabili, quanto piuttosto delle impressioni diverse che otteniamo a causa della linga, a partire da uno stato di cose che è il medesimo per tutti.
In altre parole, se parlo inglese sono portato a vedere un cilindro (che, secondariamente, è di vetro), se invece parlo maya yucateco, a vedere del vetro (che, secondariamente, ha forma cilindrica). Ma in entrambi i casi possiamo serenamente dire che la realtà (termine eminentemente whorfiano) con cui abbiamo a che fare è la medesima. Discorso simile per le forme meno spaventose di relativismo, come quello dei giudizi di gusto: se un tale dice che il Lambrusco è buono mentre un altro lo nega, si parla di disaccordo senza errore; le due “verità” non sono in contrasto con l’idea di un’unica realtà uguale per tutti perché i giudizi sottintendono la personale prospettiva del singolo parlante. In un caso come questo ci sono molteplici sguardi sulla stessa porzione di mondo che non sono affatto incompatibili tra loro e di certo non mettono in discussione le fondamenta del nostro conoscere. Altrettanto vale se una lingua spinge due persone a considerare saliente due aspetti fisici diversi di un medesimo oggetto.
Eppure, anche libri di successo di stampo divulgativo, come quello del neuroscienziato canadese Steven Pinker, L’istinto del linguaggio, o quello del linguista israeliano Guy Deutscher La lingua colora il mondo, finiscono con l’esagerare iperbolicamente gli scopi della relatività, trasformandola in determinismo e associandola, di nuovo, a una temibile forma di relativismo. E così facendo, creano una testa di turco che pare doveroso abbattere. In questo senso, è piuttosto celebre il caso di Pinker che, con scarsa carità interpretativa, bollò le idee whorfiane come “wrong, all wrong”.
Al di là di queste esagerazioni, bisogna ammettere che dalle ricerche di psicolinguistica attuali a programmi più ambiziosi di amplissima portata come quelli del linguaggio inclusivo molto ci passa, ed è legittimo discuterne. Se quanto evidenziato finora mira a difendere la legittimità della relatività linguistica come posizione filosofica e scientifica, proprio a partire da questa riaffermazione è – però – tutt’altro che scontato che essa, da sola, sia sufficiente a corroborare le operazioni di inclusione linguistica. Meno in dubbio è che, come ha scritto la sociolinguista Vera Gheno in un recente post, “tra realtà e lingua c’è una relazione bidirezionale: la realtà influisce sulla lingua, ma anche la lingua influisce sulla realtà. Nel momento in cui nominiamo con precisione qualcosa o qualcuno, possiamo parlarne, di conseguenza quel qualcosa o qualcuno assume più concretezza”.
Così vera da essere irrilevante?
Oggi, la ricerca sulla relatività linguistica ispirata da Whorf utilizza per la maggior parte gli strumenti della psicologia cognitiva, conducendo esperimenti in laboratorio o, comunque, in situazioni il più possibile controllate. Si chiede ai soggetti testati di svolgere semplici compiti e si interpretano le strategie di risoluzione in modo da poter inferire conclusioni sull’influenza del linguaggio (e cioè delle specifiche lingue) a partire da certi pattern comportamentali.
Tuttavia, questo genere di approccio di per sé offre risultati che si presentano sotto forma di scarti di millesimi di secondo tra i partecipanti. Per esempio, si è visto che in una lingua, come l’inglese, che marca obbligatoriamente il genere dei pronomi di terza persona riferiti a esseri umani (she/he) la performance nel rispondere a domande di comprensione di un certo testo è leggermente più veloce rispetto a quella di chi parla lingue con pronomi privi di genere come cinese mandarino o caritiana, parlato da poche centinaia di persone in Amazzonia. Insomma, un risultato interessante, ma la cui portata sembra ridotta: quanto inciderà mai questa infinitesima differenza nella vita di tutti giorni? Gli esempi di esperimenti simili sono tanti, ma l’obiezione rimane valida: sono sufficienti queste piccole prove a sostenere che dai millisecondi si possano trarre conclusioni – o fondate suggestioni – di più ampia portata? Una lingua può influenzare un’intera società, piccola o grande che sia? D’altronde, si potrebbe facilmente dire il mandarino, che usa un pronome gender-ambiguous per la terza persona, non ha certo fatto in modo che, per dirne una, i ruoli maschile e femminile nella società cinese fossero interpretati come paritari.
E quindi, è sensato il progetto di risvegliare l’attenzione verso l’inclusione sociale modificando alcune forme grammaticali pervasive nella lingua? La risposta non può essere netta in nessuna delle due direzioni, per varie ragioni. Per prima cosa, la ricerca empirica è in un certo senso ancora agli inizi. Se è legittimo dire che cent’anni fa non si poteva praticamente disporre di alcuna prova sperimentale dell’influenza differenziata delle lingue sulla cognizione, trent’anni scarsi di rinascimento whorfiano sono ancora pochi per trarre conclusioni granitiche su domande così ampie sul ruolo del lingua nella cognizione, intrecciata com’è con la socialità e la cultura – probabilmente troppo ampie per non essere parcellizzate in tante, piccole domande di ipotesi di ricerca empirica, tutte da testare.
È sensato il progetto di risvegliare l’attenzione verso l’inclusione sociale modificando alcune forme grammaticali pervasive nella lingua? Non sembra esserci una risposta netta.
Allo stesso tempo, studiosi come lo psicologo cognitivo Daniel Casasanto hanno voluto difendere l’importanza della relatività linguistica empiricamente valutata, mostrando che, al giorno d’oggi, di risposte convincenti non siamo del tutto sforniti. Un caso molto evidente è quello della cosiddetta cognizione numerica, ovvero di come facciamo a sapere che cinque mattoni sono proprio cinque, e non tre o sette. Intuitivamente, il linguaggio gioca un chiaro ruolo di facilitatore nel riuscire a indirizzare la nostra cognizione non linguistica sull’indicazione delle quantità esatte. Come al solito, tuttavia, non è assolutamente scontato che tutte le lingue del mondo abbiano questo genere di parole per riferirsi a “quarantaquattro” o anche soltanto a “tre”. Nel dibattito odierno si ritiene che gli esseri umani sfruttino tre “sistemi” cognitivi per discriminare le quantità: i primi due sono fondamentalmente innati, ne sono dotati anche i bambini di pochi mesi e certi animali non umani (come i leoni), e consentono di discriminare con esattezza tra uno, due e tre (ma non tra tre e quattro), e poi di discriminare tra quantità anche numerose ma purché il rapporto differenziale sia consistente: sanno cioè indicare che un mucchietto di 49 caramelle è maggiore di uno di 17 caramelle; ma non che lo sia di uno di 41 caramelle. Ma per essere più precisi di così, deve necessariamente subentrare il linguaggio, ovvero il terzo sistema. Varia esperienza sul campo ha suggerito che in assenza di una lingua che preveda parole per numeri molto grandi (come un’altra celebre lingua amazzonica, il pirahã) si faccia molta fatica a compiere con esattezza azioni che si fondino sulla capacità di maneggiarli (diversa, ovviamente, da quella di immaginarli: il chiliagono è inimmaginabile, ma non per questo inutilizzabile). E chiedetevi, conclude Casasanto, se mai avremmo potuto raggiungere un livello di sviluppo tecnologico tale senza poter dire (e dunque pensare) pigreco o tre milioni settecentoottantasette.
Il legame tra lingua e cultura sembra essere, in definitiva, strettissimo, reciproco, e difficilmente solubile da una sola ipotesi. Whorf, dal canto suo, in uno dei suoi passaggi più infusi dell’umanitarismo che animava la sua impresa intellettuale, sosteneva che i linguisti erano probabilmente nella miglior posizione per avvicinarsi a “descrivere la natura con assoluta imparzialità”: conoscere a fondo “molti sistemi linguistici significativamente diversi tra loro” (inclusi quelli delle lingue native, delle piccole comunità) ha l’importante effetto di rendere possibile una maniera diversa di conoscere il mondo. Un commendevole principio insieme di tolleranza e di scienza riassunto poeticamente dal linguista Nicholas Evans: “studiamo altre lingue perché non possiamo vivere abbastanza vite”. E di lingue, là fuori, se ne contano diverse migliaia.