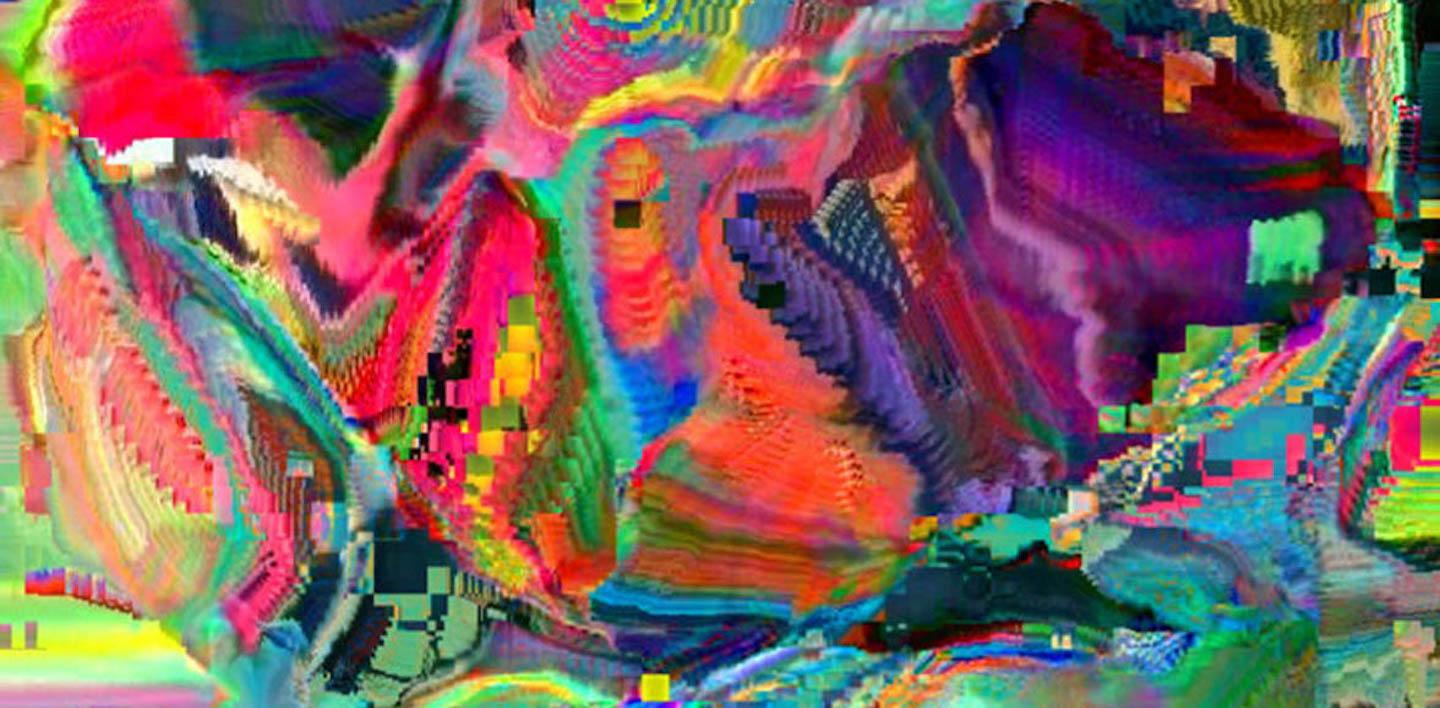
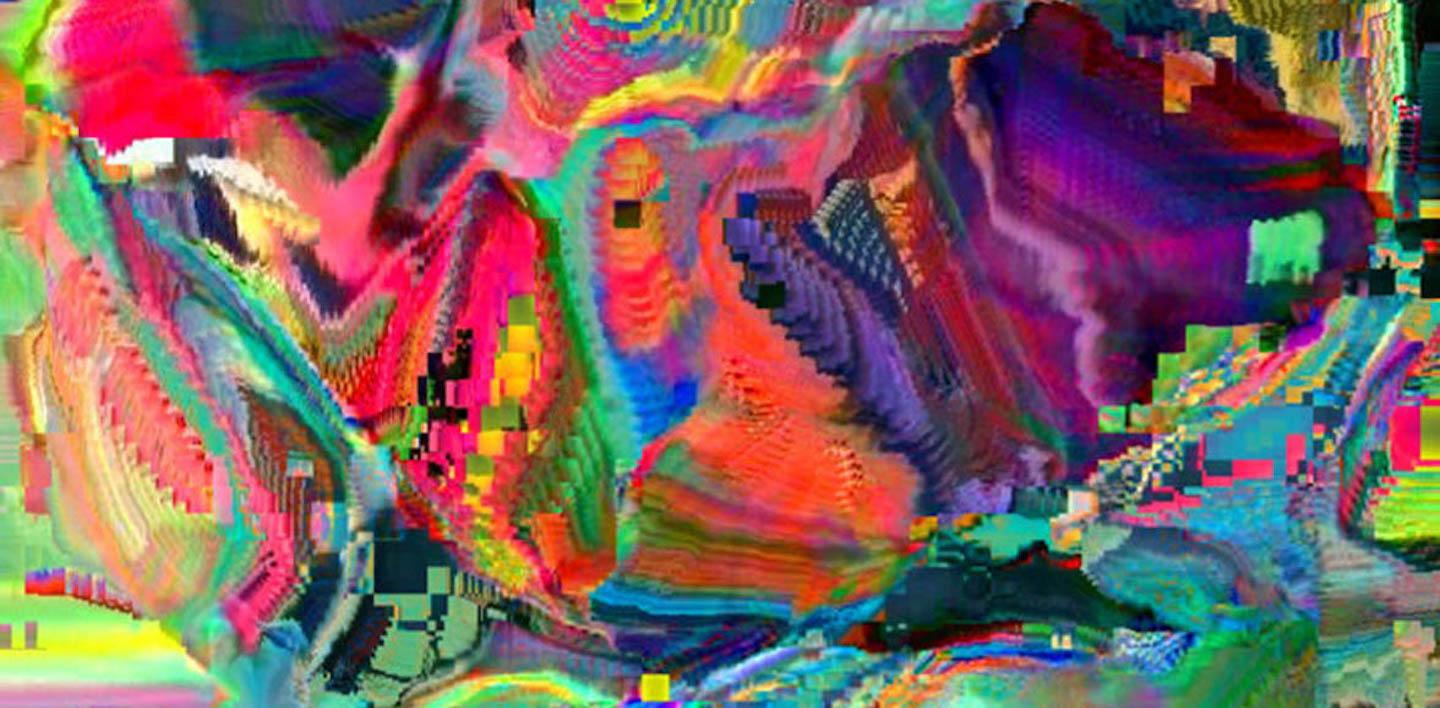
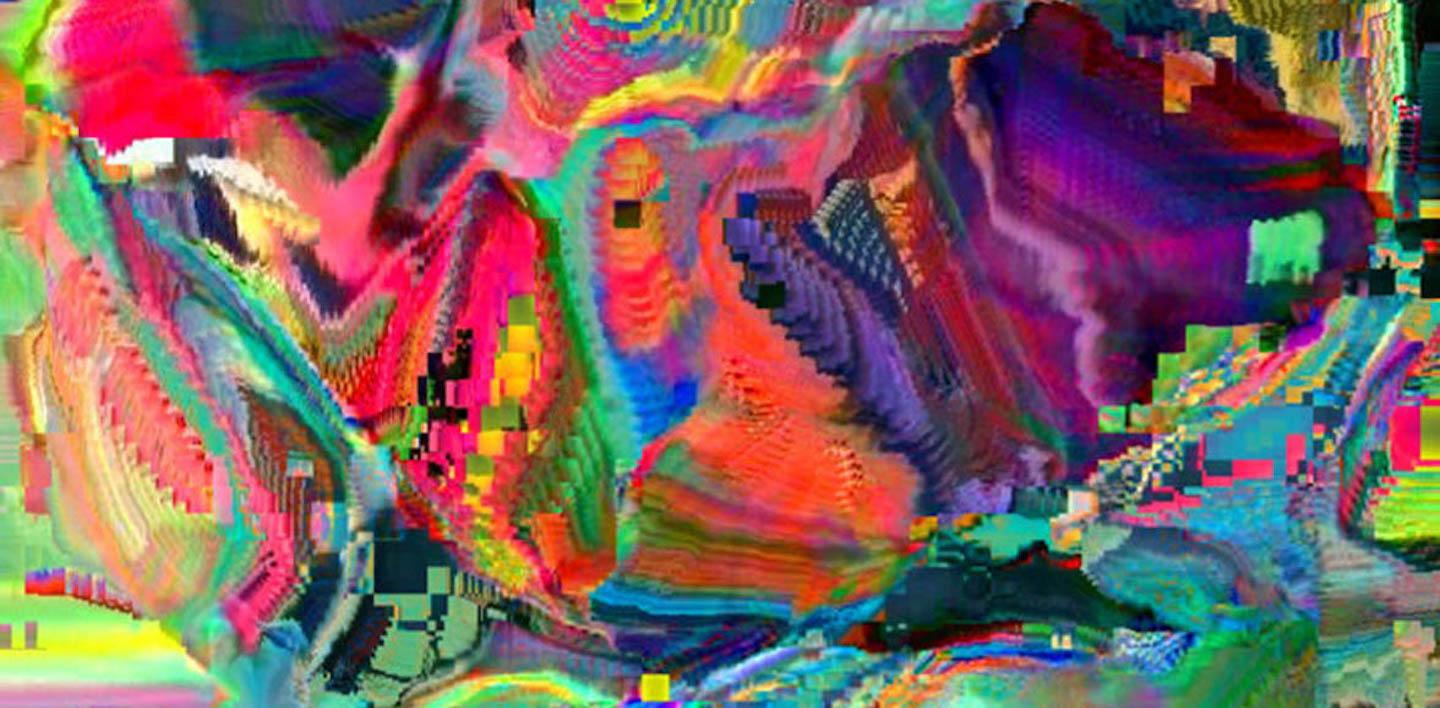
L’ anno è il 2029. Internet non è più la rete globale a cui eravamo abituati, è stata divisa in una serie di intranet locali accessibili solo all’interno delle singole nazioni. Gli unici collegamenti internazionali sono tra i paesi che hanno siglato accordi specifici: dalla Russia, però, non si può raggiungere un sito europeo, dal Giappone non si può arrivare a un sito cinese, dall’Iran non si può navigare su un sito turco.
Lo stesso avviene con i messaggi su WhatsApp e WeChat, che non raggiungono il destinatario a meno che non si trovi nel paese giusto. Larga parte dei paper accademici non è più consultabile, ed è diventato impossibile anche giocare in modalità multiplayer con persone che si trovano al di là delle svariate cortine di ferro digitali che sono state erette. Il presidente degli Stati Uniti, intanto, in un discorso pubblico ha minacciato di escludere l’Europa dalla intranet americana se non verranno risolte le disparità nella bilancia commerciale digitale tra USA e Unione Europea.
Torniamo alla realtà. Mancano ancora dieci anni al 2029, ma il processo che potrebbe condurre allo scenario sopra descritto – una visione del futuro immaginata da Michael Grothaus su FastCompany – è già iniziato. E la colpa, in un certo senso, è anche dell’Europa. Nel maggio 2018, l’Unione Europea ha infatti approvato la norma del GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati che ha l’obiettivo, meritorio, di difendere la privacy degli utenti dagli abusi dei colossi digitali. In seguito al varo del GDPR, parecchi siti statunitensi (tra cui Los Angeles Times e il Chicago Tribune), piattaforme come Instapaper e istituzioni come la Association for National Advertisers hanno bloccato l’accesso a tutti i visitatori provenienti dall’Europa. Adempiere alle norme previste dal GDPR, per loro, era meno conveniente che tagliare fuori qualche centinaio di milioni di utenti.
È stato solo una misura temporanea: a quasi un anno di distanza, la maggior parte dei siti sopracitati sono tornati raggiungibili. Ci sono delle eccezioni, però. Se provate ad accedere al sito del Chicago Tribune troverete ancora un messaggio che vi blocca dalla navigazione: ”Unfortunately, our website is currently unavailable in most European countries”. Di fatto, l’Europa è stata tagliata fuori da una parte dell’informazione online. Un segnale inquietante per il futuro della rete.
E la situazione non è destinata a migliorare.
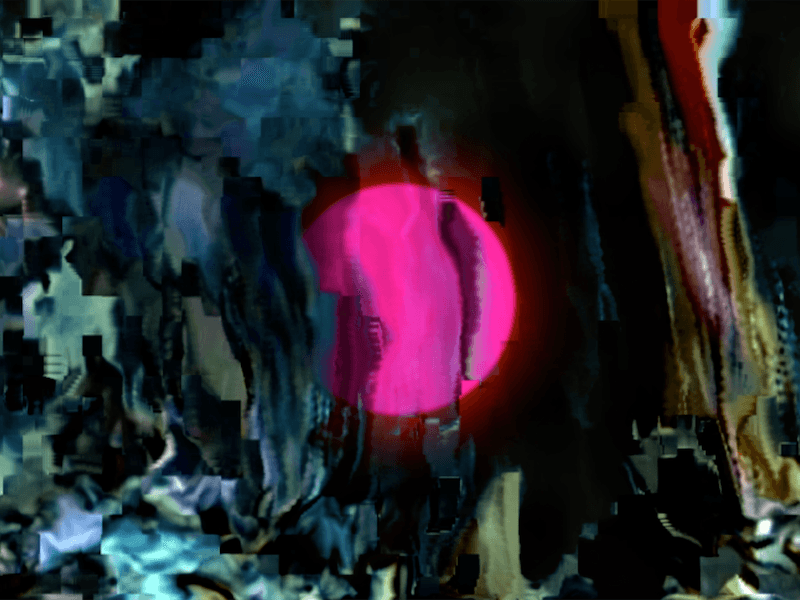
Lo scorso 26 marzo è stata infatti approvata la contestatissima direttiva UE sul copyright. Gli articoli più controversi sono due. Il primo è l’articolo 13, che impone a tutti i siti e le applicazioni commerciali sulle quali può essere caricato anche materiale protetto da diritto d’autore di essere responsabili per questi contenuti, e quindi punibili in caso di violazioni. L’articolo 11 (nella versione definitiva articolo 15) prevede invece che gli editori possano imporre alle piattaforme degli accordi commerciali se queste vogliono pubblicare gli estratti degli articoli; quelli che vediamo ogni volta che cerchiamo qualcosa su Google o compare un’anteprima su Facebook. Niente accordi, niente anteprima.
La versione europea del world wide web potrebbe diventare così sempre più diversa dalla rete globale. “Google potrebbe decidere di chiudere Google News in Europa (l’ha già ritirato in Spagna nel 2014, dopo che la nazione aveva implementato una simile legge sulla visualizzazione di frammenti di testo)”, scrive per esempio The Verge. “L’azienda di Mountain View ha fatto sapere che potrebbe seguire questo esempio in tutta Europa e che altre società potrebbe seguirla. Se Google deve pagare per citare in maniera efficace degli articoli, quali altri siti web potrebbe fronteggiare simili restrizioni? È facile immaginare un effetto a catena su tutta internet”.
Non sono solo le piattaforme di ricerca a fronteggiare questo problema. Per quanto nell’articolo 13 della direttiva sul copyright non si parli esplicitamente della creazione di filtri preventivi (che dovrebbero impedire che sulle piattaforme di streaming e non solo vengano caricati contenuti che violano il diritto d’autore), molti esperti ritengono questa soluzione inevitabile; l’unico modo per provare ad adempiere alla direttiva europea. Il fatto che il presidente francese Macron abbia già iniziato a richiedere l’implementazione di filtri automatici sembra dare loro ragione.
YouTube ha i mezzi per sviluppare un sistema di questo tipo (per quanto ci siano molti dubbi sulla sua efficacia), ma come si comporteranno le altre piattaforme che non hanno a disposizione le sue risorse? Nonostante la direttiva abbia accolto qualche modifica – che salvaguarda la circolazione di meme e di GIF ed esenta dal rispetto delle norme le aziende più piccole –, le conseguenze sul lungo termine sono ancora da valutare. Potrebbe tutto risolversi in una bolla di sapone (se non altro per la vaghezza delle norme e la difficoltà della loro applicazione), oppure potrebbe essere il primo passo verso la biforcazione della internet europea da quella globale.
La grande (cyber)muraglia cinese
Non sarebbe il primo caso. Da tempo, la rete cinese si sta separando dal resto di internet; filtrando i contenuti accessibili dagli utenti attraverso l’ormai celebre Grande Firewall. Le ragioni sono molto diverse da quelle europee e riguardano ovviamente la censura di contenuti sgraditi al regime della Repubblica Popolare. Il risultato, però, è che la rete globale che avrebbe dovuto garantire la libera circolazione dell’informazione e dei beni digitali si sta diversificando sempre di più, in risposta a quelle logiche politiche ed economiche che, nelle utopie anni Novanta, proprio internet avrebbe dovuto travolgere.
Gli stessi colossi digitali che, grazie alla rete globale, hanno potuto conquistare immensi profitti stanno rapidamente cercando di adattarsi a questa nuova situazione dopo essersi vanamente ribellati. Per anni Google ha cercato di entrare nel mercato cinese. La coesistenza con il governo autoritario di Pechino si è fatta però sempre più difficile. Così, nel marzo 2010, Google ha deciso di ritirarsi. Secondo una ricostruzione generalmente accettata, le dimissioni di Eric Schmidt da CEO di Google, avvenute nel 2011, furono causate da divergenze con i due fondatori, Larry Page e Sergey Brin, al centro delle quali c’era proprio la Cina. Page e Brin non volevano che Google si piegasse alle pretese del governo cinese, mentre Schmidt concentrava l’attenzione sulle potenzialità economiche di quel mercato. Schmidt, come detto, perse la sua battaglia e pochi mesi dopo rassegnò le dimissioni (rivestendo comunque, ancora a lungo, la carica più che altro onorifica di presidente di Alphabet).
La divisione di internet, gradualmente, si sta concretizzando, trasformando la rete globale in una realtà balcanizzata soprannominata Splinternet.
Da allora, sono passati otto anni. Oggi, Google produce un fatturato quattro volte superiore al 2011, ha un numero quattro volte superiore di dipendenti e, soprattutto, il suo modello di business (come quello di Facebook e tanti altri) lo costringe a cercare sempre nuovi mercati in cui espandersi. Se non bastasse, Page e Brin non sembrano più così interessati alle attività della loro creatura, che dal 2015 è guidata da Sundar Pichai; CEO che non sembra farsi gli stessi scrupoli morali dei suoi fondatori.
Lo dimostra il controverso progetto Dragonfly: un motore di ricerca a cui Google sta lavorando da tempo per adempiere alle richieste del governo cinese e riuscire finalmente a rientrare in un mercato da 800 milioni di utenti. Secondo un’inchiesta di The Intercept, Dragonfly, se e quando venisse implementato, censurerebbe alcune chiavi di ricerca specifiche (per esempio, “protesta studentesca” o “diritti civili”), impedirebbe l’accesso ad alcune testate e consentirebbe un’agevole sorveglianza di tutti gli utilizzatori. In seguito alle fortissime proteste e alle dimissioni di numerosi dipendenti di Google, Sundar Pichai ha promesso maggiore trasparenza e ha più volte fatto intendere che il progetto fosse stato bloccato; le ultime indiscrezioni, però, forniscono buone ragioni per credere che Dragonfly sia ancora vivo, e sempre più segreto.
La Cina, insomma, fa troppa gola per cedere a scrupoli morali. Lo ha dimostrato anche Facebook, che – secondo quanto riportato dal New York Times ormai più due anni fa – avrebbe progettato uno strumento in grado di censurare le notizie sgradite in determinate aree geografiche, con il preciso obiettivo di rendere il social network di nuovo attivo nella Repubblica Popolare, dove è stato bloccato nel 2009.
Il software non si limiterebbe a cancellare subito i post sgraditi, ma darebbe la possibilità a un ente terzo di emanazione governativa di sorvegliare in tempo reale le notizie più popolari e i post più condivisi, consentendogli di decidere in autonomia cosa possa o non possa apparire nel newsfeed degli utenti cinesi e controllare chi abbia pubblicato che cosa. Se questi due progetti andassero in porto, la Cina avrebbe delle versioni di Google e Facebook molto diverse dal resto del mondo, cucite su misura per soddisfare i voleri di Pechino: non si tratterebbe di una novità assoluta. Facebook ha già accettato le richieste di numerosi regimi autoritari: in Pakistan deve eliminare post e immagini che possono essere considerati blasfemi; in Turchia è responsabile della rimozione di contenuti diffamatori nei confronti di Ataturk (padre della nazione); in Vietnam non possono comparire contenuti contro il governo e lo stesso vale in Thailandia per il re e la famiglia reale.
Un sovranismo digitale
La divisione di internet, gradualmente, si sta concretizzando, trasformando la rete globale in una realtà balcanizzata soprannominata Splinternet. E con questo, tanti saluti anche alla “dichiarazione di indipendenza del cyberspazio” pubblicata nel 1996 dall’attivista (e autore dei testi dei Grateful Dead) John Perry Barlow: “Voi non siete i benvenuti tra noi. Non avete sovranità nel luogo in ci ritroviamo”, scriveva tra le altre cose Barlow, rivolgendosi ai governi di tutto il mondo.
Ventitre anni dopo, i governi hanno deciso di riprendere possesso di quella creatura eterea che per lungo tempo è sfuggita a ogni forma di controllo, dando vita a una creativa anarchia digitale. L’Unione Europea si è fatta sentire imponendo il rispetto del diritto d’autore in un mondo digitale che, anche attraverso la pirateria, ha dato un enorme impulso alla diffusione della cultura e alla nascita di forme innovative di scambio di contenuti (poi mutuate da realtà come Netflix e Spotify). La Cina si sta rapidamente separando dal resto di internet; dando sempre più forza, almeno nel mercato domestico, ai suoi colossi riuniti sotto la sigla BAT (Baidu, Alibaba, Tencent). Gli Stati Uniti, da parte loro, si sono fatti notare abolendo la Net Neutrality – il principio che garantisce a tutti gli attori di internet un accesso uguale alla banda della rete, siano essi un blog indipendente oppure Netflix – e favorendo così i colossi a scapito delle piccole realtà indipendenti.
Chiamatelo, se volete, “sovranismo di internet”: un fenomeno che spinge sempre più nazioni a creare delle vere e proprie intranet nazionali. Non è una metafora: se USA, Cina ed Europa si limitano a dotarsi di leggi diverse e a bloccare contenuti sgraditi tramite firewall, altre nazioni stanno fisicamente isolando la loro rete dal resto del mondo.
Mano a mano che internet diventa sempre più cruciale, essere parte di un’unica rete globale presenta rischi crescenti.
Dal 2012, l’Iran sta lavorando per costruire una sua intranet sovrana soprannominata “halal net”: tutti i cavi, i server e i data center sarebbero fisicamente scollegati dal resto della rete, dotando la repubblica islamica di un’infrastruttura sulla quale esercitare un ferreo controllo, senza possibilità di fuga attraverso proxy o VPN. In Corea del Nord, la intranet chiamata Kwangmyong è l’unica rete di computer a disposizione della gente comune (mentre l’accesso a internet è limitato a una strettissima cerchia di persone). Una cosa simile avviene a Cuba, dove a lungo l’intranet locale – censurata e sorvegliata – è stata l’unica forma di accesso su rete fissa per la maggior parte della popolazione, mentre la rete mobile, da poco liberalizzata ma con costi ancora elevati, permette l’accesso a internet globale con qualche censura.
La Russia, prevedibilmente, non vuole essere da meno e nel febbraio 2019 ha comunicato di voler sperimentare un black out di internet: una completa disconnessione che rappresenta una sorta di simulazione da attuare in caso scoppiasse una cyberguerra globale. Ma perché sta avvenendo tutto questo?
Sarebbe facile notare come tutti i paesi citati nei paragrafi precedenti abbiano poco a che fare con le democrazie liberali e siano quindi, semplicemente, alla ricerca di un modo per tenere sotto controllo l’informazione. Questa visione, però, rischia di essere fortemente limitata: “Nel 2014, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato i 28 membri dell’Unione Europea a creare una propria internet regionale (…) completamente separata dal world wide web”, si legge ancora su Fast Company. Una proposta che da allora sembra caduta nel vuoto – e che era politicamente motivata dalle recenti rivelazioni sul Datagate – ma che mostra come l’utilizzo di internet per lo spionaggio internazionale (e industriale) spinga quasi naturalmente gli stati sovrani a desiderare un maggiore isolamento.
Internet, in un certo senso, è vittima del suo successo. Agli albori della rete, nessuno poteva immaginare come la rete avrebbe cambiato il mondo; com’è noto, nel 2005 Paul Krugman, in seguito vincitore del premio Nobel per l’economia, scrisse che l’impatto economico di internet non sarebbe stato superiore a quello del fax. Le cose sono andate molto diversamente: ogni tipo di industria (finanziaria, energetica, sanitaria, tecnologica) ha spostato operazioni, informazioni e comunicazioni sulla rete. Un lavoro colossale condotto in nome dell’efficienza e della semplificazione, ma che ha aumentato a dismisura il rischio che dati sensibili o strategici vengano sottratti dagli hacker al soldo di stati rivali.

È attraverso internet che la Russia ha colpito la rete energetica ucraina, causando un blackout in ampie parti della nazione. È sempre attraverso internet che Mosca è riuscita a interferire nelle elezioni statunitensi del 2016. Ed è ancora attraverso internet che nell’estate 2017 è stato diffuso Triton, il malware che ha colpito i sistemi di sicurezza di un impianto petrolchimico in Arabia Saudita (mettendo a rischio anche l’incolumità dei dipendenti) e che continua ad aggirarsi nella rete.
Mano a mano che internet diventa sempre più cruciale, essere parte di un’unica rete globale presenta rischi crescenti. Uno scenario che agita i sonni degli esperti di sicurezza anche a causa delle costanti evoluzioni nei campi del deep learning e dei computer quantistici, che potrebbero fornire alle nazioni più avanzate armi digitali in grado di distruggere qualsiasi forma di cyberdifesa sia stata messa a protezione dei dati più sensibili. È a questo che faceva riferimento Vladimir Putin quando ha detto che “chi conquisterà il primato nel campo dell’intelligenza artificiale conquisterà il mondo” (e non a guerre combattuta con i robot, come si è spesso lasciato intendere).
L’11 settembre attraverso internet
Separare i cavi, abbandonare l’internet globale, isolarsi fisicamente costruendo intranet locali o regionali (condivise solo con i più fidati alleati): questo è l’unico modo per mettersi al riparo dai rischi connessi alla cyberwarfare ed evitare che la prima nazione che riuscirà a sviluppare sistemi di attacco basati sui computer quantistici possa invadere – senza incontrare resistenza – sistemi protetti da forme di crittografia che diventerebbero immediatamente obsolete. Questi timori si stanno facendo largo anche negli Stati Uniti. Il responsabile dell’intelligence nazionale Dan Coates ne ha parlato meno di un anno fa, sollevando il timore di un 11 settembre digitale:
Sono passati quasi due decenni [dagli attacchi alle Torri Gemelle] e voglio dirvi che le luci rosse di allarme stanno lampeggiando di nuovo. Oggi, le infrastrutture digitali che reggono le nazioni sono letteralmente sotto attacco.
E i rischi diventano sempre maggiori: le auto connesse alla rete possono essere manomesse da remoto, interferendo con gli assistenti di guida e provocando deliberatamente incidenti; i macchinari industriali possono essere sabotati; i sistemi finanziari possono andare in tilt; le banche possono essere attaccate. L’elenco potrebbe andare avanti senza fine. In ballo non c’è solo la manipolazione dell’opinione pubblica (nelle democrazie) o la libera circolazione dell’informazione (nei regimi), ma la protezione di infrastrutture strategiche in un mondo che sembra dirigersi verso una sorta di guerra fredda globale.
Come si può impedire che il sogno della rete globale si trasformi nel sovranismo di internet? Prima di tutto, vale la pena di sottolineare che questi scenari sono ancora lontani dall’essere realizzati. Se si esclude il grande firewall cinese e alcune realtà locali, il resto del mondo è sempre più connesso: in Africa, per fare solo un esempio, gli utenti connessi alla rete sono cresciuti del 10.000% nell’arco di vent’anni (contro l’89% del resto del mondo).
Detto questo, la minaccia è esistente e non va sottovalutata. “Nel 2016, le Nazioni Unite hanno dichiarato la ‘libertà online’ un diritto fondamentale dell’uomo”, scrive TechCrunch. “Anche se non è vincolante, la mozione è passata e di conseguenza all’ONU è stato fornito un limitato potere per difendere il sistema dell’open internet. Facendo pressioni su alcuni governi, le Nazioni Unite potrebbero far rispettare gli standard relativi ai diritti umani digitali”.
Probabilmente, questa è una visione fin troppo ingenua. Neanche i diritti umani basilari vengono rispettati in ampie parti del mondo; perché mai si dovrebbe riuscire – attraverso sanzioni o provvedimenti simili – a far rispettare i diritti digitali in un mondo in cui, già oggi, internet è sempre meno libero? Una soluzione più realistica potrebbe prendere in considerazione la creazione di una intranet accessibile solo a livello regionale o locale, in cui recintare tutti i dati e le infrastrutture sensibili, mantenendo allo stesso tempo in vita la rete globale, destinata all’informazione e all’e-commerce e aperta a chiunque voglia partecipare a questo continuo esperimento mondiale (e a beneficiare delle ricadute economiche, industriali e occupazionali).
Una soluzione di compromesso, la cui fattibilità è tutta da verificare e che segnerebbe comunque la fine dell’ecosistema digitale come l’abbiamo conosciuto fino a oggi. In un periodo storico in cui i governi hanno deciso di puntare lo sguardo su una realtà che per lungo tempo è sfuggita al loro controllo – e mentre i rischi in termini di cybersicurezza non fanno che aumentare – potrebbe non esserci alternativa. Come tutte le utopie, anche quella di internet era destinata, prima o poi, a fare i conti con la realpolitik.