


L e immagini dell’enorme seracco di ghiaccio che, nel pomeriggio di domenica 3 luglio, si stacca dal corpo della Marmolada travolgendo ogni cosa sul suo cammino resteranno con ogni probabilità nella nostra memoria collettiva. Parte della loro forza visiva si deve alla natura improvvisa e inaspettata del crollo, parte al fatto che il crollo sia avvenuto dopo un prolungato periodo di temperature molto al di sopra della media stagionale.
Un particolare, questo, che favorisce una lettura causa-effetto dell’evento: chi ha visto le immagini non ha potuto fare a meno di interpretarle, prima ancora di ricevere le conferme degli scienziati, come una manifestazione degli effetti dei cambiamenti attribuibili alla crisi climatica. Le reazioni pubblicate sui social nelle ore e nei giorni successivi sono lì a testimoniare questa presa di coscienza: l’epifania di una crisi che squarcia l’immaginario dell’alta montagna.
Un immaginario depositato nel profondo della nostra cultura almeno dalla metà del Settecento, quando le élite urbane, nel pieno della temperie illuminista e sulla scorta delle coeve esplorazioni scientifiche, scoprirono le Alpi. Fino a quel momento, la cultura europea le aveva pensate, descritte e rappresentate all’interno della dicotomia tra ager (la pianura ordinata e coltivata) e saltus (il territorio indistinto, caotico e selvaggio) che derivava loro dalla civilizzazione romana. Le Alpi cessarono così di essere una massa inerte e priva di identità per diventare oggetti di studio da parte del pensiero scientifico e di rappresentazione da parte dell’agire artistico che cercò parole e immagini per descriverne gli spazi.
Oggi la preservazione delle Alpi è messa a repentaglio dagli effetti più imprevedibili e distruttivi del riscaldamento globale.
E quello che era iniziato come un processo descrittivo diverrà ben presto un processo di terraformazione da cui, all’incrocio tra invenzione visiva e intervento sul territorio, emergerà l’immagine che siamo abituati a riconoscere come il “paesaggio alpino”. La tipologia architettonica dello chalet suisse, che con le sue falde sporgenti, le mensole ornamentali, le scalette e i loggiati si configura come una sineddoche della montagna. Le Alpi diventano così un artefatto.
Oggi la loro preservazione è messa a repentaglio dagli effetti più imprevedibili e distruttivi del riscaldamento globale. Neve e ghiacciai, che del paesaggio alpino sono componenti essenziali, sembrano destinati a scomparire. Negli ultimi 120 anni, scrivono gli esperti che hanno redatto l’edizione 2022 del rapporto State of Climate Services dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, la temperatura sulle Alpi è cresciuta a una media due volte più alta rispetto a quella del resto del mondo, aumentando già di ben 2 gradi centigradi. Una tendenza destinata a peggiorare se, come purtroppo appare sempre più evidente, non sarà possibile rispettare gli obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura a livello globale.
Tra il 2036 e il 2050, sottolinea uno dei casi studio contenuti nel report dell’organizzazione e dedicato alle conseguenze del riscaldamento globale nella provincia di Belluno, la probabilità di rischi climatici relativi a eventi di neve bagnata aumenterà del 6,2% per i rischi indiretti e del 10,2% per quelli diretti. Una combinazione le cui conseguenze interesseranno tanto le attività produttive quanto la distribuzione di energia elettrica, così come il turismo, sia estivo che invernale, in particolare la zona di Cortina.
Come nota Fabrizio Fasanella su Linkiesta, le reazioni di personalità, impiantisti e operatori turistici della zona, che sarà sede delle Olimpiadi Invernali del 2026, sono improntate a un senso di negazione e rifiuto che appare inspiegabile di fronte a quella che ha ormai la forza di un’evidenza.
Che la neve, in particolare sul versante a sud delle Alpi, sia ormai un evento sempre più raro lo dicono anche, tra gli altri, le previsioni realizzate da Michael Matiu, matematico del centro di ricerca Eurac di Bolzano, che ha analizzato i dati raccolti dalle 28 stazioni meteorologiche della provincia dal 1981 a oggi. Lo studio delle serie storiche mostra infatti come, nei mesi da dicembre a marzo, la neve sia diminuita in modo considerevole sotto i 1500 metri di quota, mentre a fine stagione il saldo risulti negativo in tutte le località del Sudtirolo. Una tendenza che si consolida a dispetto delle nevicate estreme registrate negli ultimi anni e che, dice ancora Matiu, sono anch’esse causate dal riscaldamento globale e destinate ad aumentare mano a mano che i suoi effetti si faranno più evidenti. La negazione espressa dagli operatori del turismo invernale di Cortina potrebbe apparire dunque come il primo stadio di un processo di elaborazione del lutto per quello che è un settore che sembra destinato a scomparire.
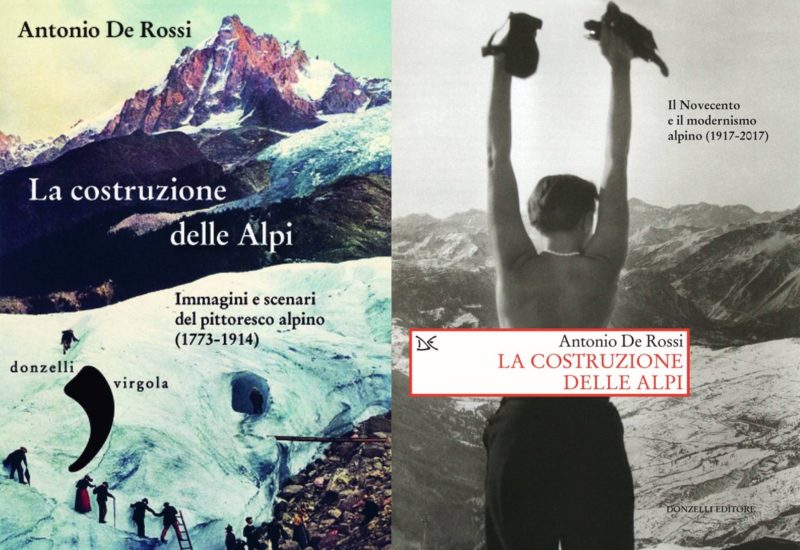
Una valutazione condivisa da Legambiente che, a marzo del 2021, intitolava Sci a rischio d’estinzione il comunicato stampa con cui presentava e riassumeva i dati contenuti del rapporto Nevediversa 2021. Qui veniva fatta notare la vertiginosa risalita della cosiddetta “Linea di Affidabilità della Neve” (LAN), cioè l’altitudine che garantisce spessore e durata sufficienti dell’innevamento stagionale, ovvero almeno 30 cm per un minimo di 100 giorni.
Condizioni sempre più rare, tanto è vero che, si legge ancora nel comunicato di Legambiente, analizzando “le prospettive climatiche degli impianti sciistici che fino ad oggi hanno ospitato una o più edizioni delle Olimpiadi invernali”, un gruppo di ricercatori ha stabilito che, “in uno scenario ottimistico soltanto 13 dei 21 impianti osservati sarebbero in grado di ripetere l’esperienza nel 2050, mentre gli altri 8 dovrebbero chiudere per mancanza di neve. Nell’ipotesi peggiore, gli impianti disponibili entro la metà del secolo si ridurrebbero a 10 per scendere a 8 nel 2080”.
Tuttavia, la gestione imprenditoriale e politica dei territori alpini sembra ancora ignorare il futuro che questi studi raccontano. L’industria dello sci e degli sport invernali sembra preoccuparsi della progressiva scomparsa della neve solo quando deve fare pressione sullo Stato per socializzare le sue perdite. Le Olimpiadi Invernali del 2026 si terranno a dispetto delle voci sempre più numerose che ne chiedono l’annullamento in nome dell’impatto e delle contraddizioni che un evento del genere rappresenta. In più, anche dopo un estate straordinariamente siccitosa, si stanno moltiplicando gli interventi legati al potenziamento delle infrastrutture sciistiche come, per esempio, il raddoppio degli impianti Klausberg in Valle Aurina, approvato dalla Giunta Provinciale di Bolzano che ha ignorato senza alcuna spiegazione le indicazioni dei tecnici sull’elevatissimo impatto ambientale del progetto.
Un atteggiamento spregiudicato, una indifferenza verso gli effetti della crisi climatica e ambientale sulla quale pesano diversi fattori. Primo fra tutti il valore del comparto, stimato in 400.000 posti di lavoro e un fatturato compreso tra 10 e 12 miliardi di euro a stagione. Secondo, la capacità di innevamento artificiale che, oggi, grazie all’innovazione tecnologica, ha permesso all’industria dello sci di liberarsi dalla necessità della neve naturale. I moderni cannoni per l’innevamento programmato possono operare infatti anche solo in presenza di aria fredda e secca e di sufficienti quantità d’acqua e di energia elettrica. Condizioni che contribuiscono ad aumentare l’impatto ambientale dello sci e degli sport invernali. Basti pensare – e i dati sono ripresi ancora dallo studio di Matiu – che “dal 2007 al 2016, i cannoni da neve in Alto Adige hanno consumato dai cinque ai dieci miliardi di litri d’acqua a stagione e, insieme agli impianti di risalita, dai 90 ai 170 milioni di kWh di elettricità, vale a dire il 6-12 per cento del consumo annuo di acqua potabile e il 2,9-5,4 per cento del consumo annuo di elettricità di tutta la provincia”.
Ma c’è forse un terzo e ultimo fattore che si può considerare, un fattore di carattere culturale, che affonda le sue radici nella storia dello sci alpino. Una disciplina che nasce intorno alla fine dell’Ottocento, ma vive i suoi maggiori fasti tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Novecento, facendosi interprete di una storia eroica che incarna alcuni dei tratti più caratteristici della modernità.
Come nota Antonio De Rossi nel primo volume di La costruzione delle Alpi (Donzelli, 2014), oltre al carattere cosmopolita con cui si oppone a quello nazionalista caratteristico dello sci nordico, lo sci alpino si definisce in opposizione all’alpinismo, configurando un diverso modo di percepire la montagna, che ne rovescia i valori. All’emozione della salita, lo sci alpino oppone l’ebbrezza della discesa e, viceversa, alla noia della discesa quella della (ri)salita. È con il suo avvento che i mountain user abbandonano le posture contemplative tipiche dell’alpinismo ottocentesco per scoprire un gesto sportivo inedito, in cui velocità e pulizia di esecuzione si sublimano in una dimensione puramente stilistica, i cui tratti ricordano da vicino alcune elaborazioni delle avanguardie artistiche.
La dimensione compiutamente moderna dell’industria sciistica continua a infestare il nostro presente impedendo di trovare modelli alternativi credibili e capaci di sopravvivere al suo collasso.
Nel giro di pochi anni, spinto dall’innovazione tecnologica, lo sci alpino muta i caratteri del turismo di montagna, esprimendosi in un concatenamento che lega insieme automobile, stazione sciistica, impianto di risalita e pista da sci. Un dispositivo che, nel suo funzionamento, richiama il sistema fordista di organizzazione del lavoro espresso nella fabbrica e ha nel modello urbanistico e architettonico della stazione sciistica – Sestriere e Cervinia in Italia, le stazioni del Plan Niege in Francia – la sua espressione che maggiormente incide e trasforma il paesaggio di montagna secondo i canoni della modernità.
Canoni che lo sci esprime dapprima coi tratti dell’ebbrezza e della velocità, poi con quelli dell’innovazione e dell’utopia tecnologiche, per assurgere infine, negli anni Sessanta, a quella dimensione di massa che tanto il consumo quanto lo spettacolo esortano a un dispendio improduttivo di risorse, dando vita a un intreccio inarrestabile tra distrazione e distruzione. Questa dimensione compiutamente moderna dell’industria sciistica continua a infestare il nostro presente impedendo di trovare modelli alternativi credibili e capaci di sopravvivere al suo collasso. Modelli che, da una parte, siano in grado di riconoscere e accettare la portata e le conseguenze che il riscaldamento globale avrà sui territori e alpini e, dall’altra parte, che siano in grado di offrire a chi abita gli spazi alpini opportunità di sviluppo prive degli spiccati caratteri estrattivi che continuano a prevalere anche oggi.
Ma né il paradigma di patrimonializzazione della montagna, emerso come reazione ai fallimenti della modernità, né il turismo d’élite, che alcuni operatori presentano come alternativa a quello di massa per mascherare le loro operazioni di gentrificazione dello spazio alpino, sembrano essere in grado di offrire risposte in tal senso, proponendo soluzioni concrete alle esigenze di chi abita un territorio tanto fragile quanto importante, dimostrando ancora una volta che, a dispetto di chi lo concepisce solo nel lessico soluzionista dell’innovazione tecnologica, quello contro il riscaldamento globale e i suoi effetti è anche uno sforzo di carattere culturale, volto a creare un pensiero in grado di accompagnare la nostra civiltà lungo uno dei processi più difficili e sfidanti per l’essere umano: quello di cambiare se stesso.