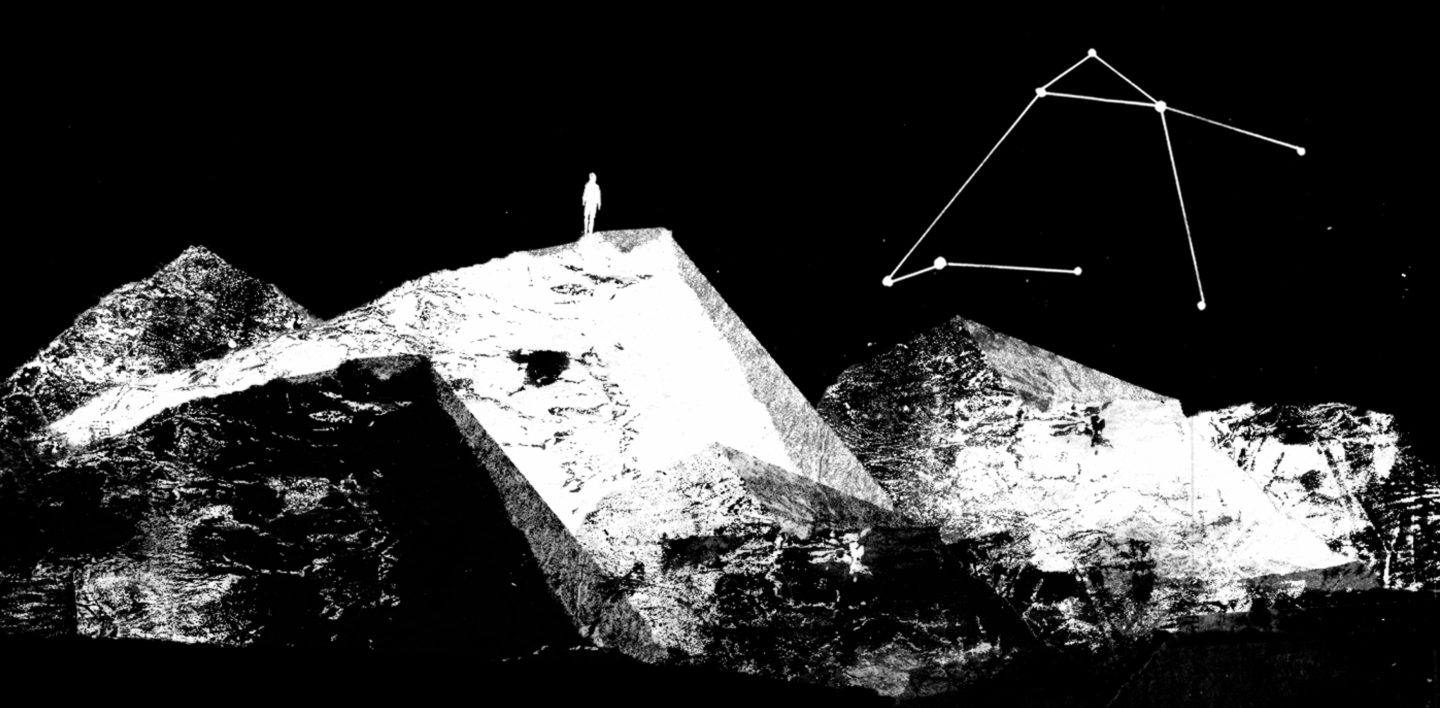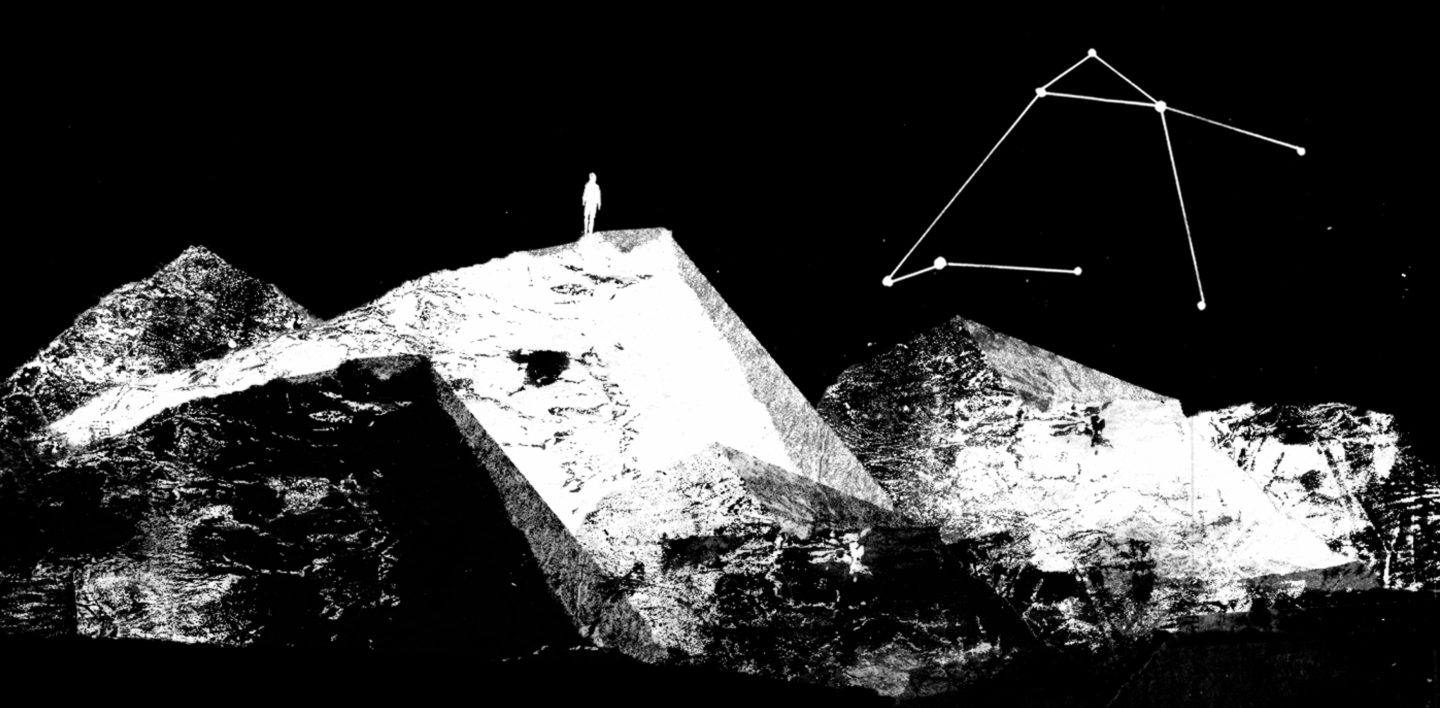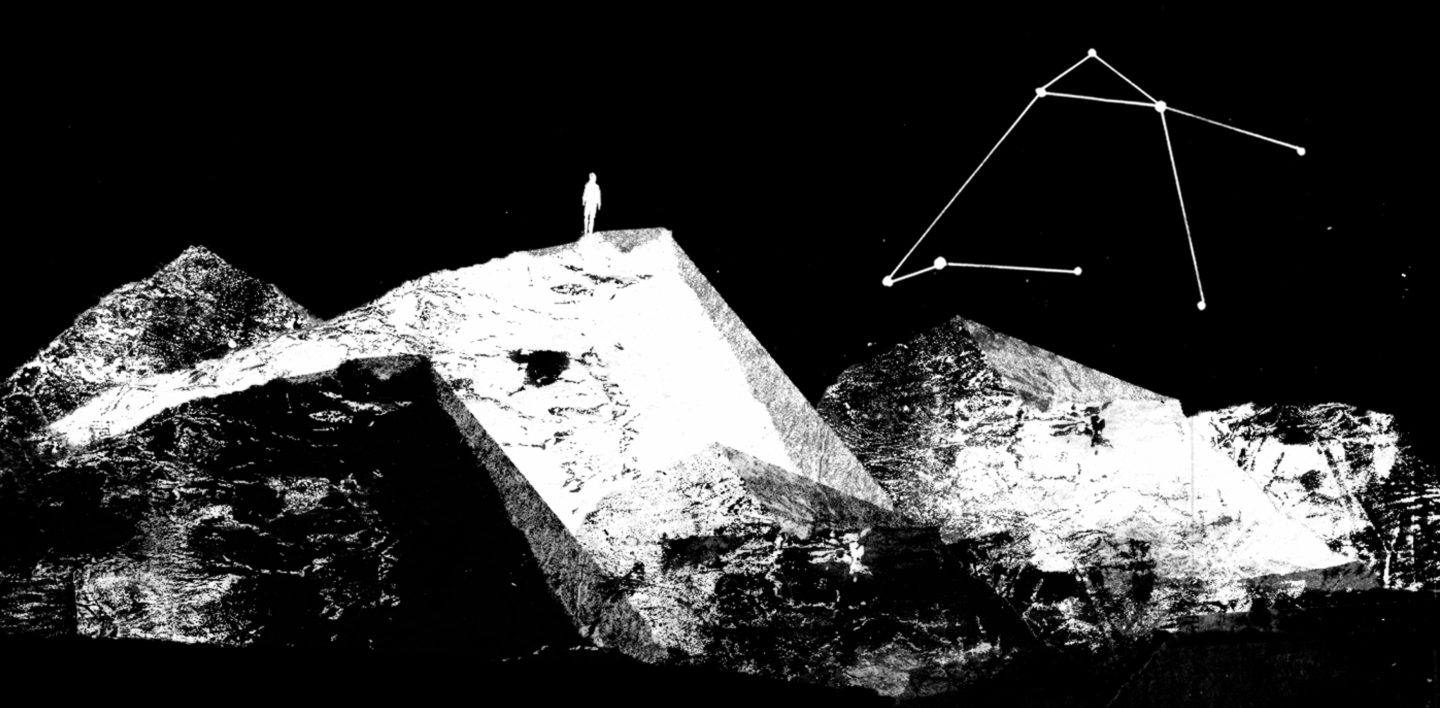P
enso ai lupi di Yellowstone più o meno tutti i giorni”, mi dice Carl Safina. “Sono ancora in contatto con le persone che li studiano, mi danno piccoli aggiornamenti. La primavera scorsa, per esempio, alcuni discendenti dei lupi di cui parlo nel mio libro hanno avuto dei cuccioli in una delle tane”. I lupi di Yellowstone, le orche del mare di Salish e gli elefanti del parco naturale di Samburu, in Kenya – le loro complesse strutture sociali, le loro abilità, i loro sentimenti – sono i protagonisti di Al di là delle parole, uscito in Italia a marzo di quest’anno, con la traduzione di Isabella C. Blum, primo volume della collana Animalia di Adelphi (il secondo è Altre menti, di Peter Godfrey-Smith).
Seicento pagine in cui, raccontando la vita di comunità di quegli animali, viene raccontata in realtà la storia di un esilio: quello dell’essere umano nei confronti della natura. Siamo diventati superbi, distanti, distratti e pericolosi, scrive Safina, che non nasconde il proprio fastidio nei confronti della modernità. Abbiamo perso l’antica capacità umana di riconoscere la presenza della mente degli altri animali. Eppure “cure parentali, soddisfazione, amicizia, compassione e lutto non apparvero così, all’improvviso, con l’emergere degli esseri umani moderni: erano già tutti affiorati in esseri pre-umani. L’origine del nostro cervello è inseparabile dall’origine di quello delle altre specie, nel gran calderone dei tempi evolutivi”.
A un certo punto del libro lei si chiede che cos’è che ci rende umani, cosa ci distingue dal mondo animale, e soprattutto perché siamo ossessionati da questa domanda. E la risposta che si dà è che quello che ci rende umani è proprio la nostra insicurezza davanti a queste domande.
Ci sono molte cose che ci rendono umani, ma credo sia più importante comprendere che ogni creatura ha qualcosa di unico, qualcosa che la rende speciale. Gli ecologi e i biologi conoscono le peculiarità di ogni specie. A volte sono caratteristiche fisiche, a volte è invece la loro personale nicchia ecologica, il ruolo che hanno all’interno del proprio ecosistema. Allo stesso modo ci sono cose che rendono umani gli umani, e tra queste c’è la nostra insicurezza. Il fatto che continuiamo a farci tutte queste domande, a chiederci cosa ci rende umani, cosa ci distingue dagli altri animali. Credo sia in parte dovuto alla nostra intelligenza e in parte ai limiti della nostra intelligenza: è la nostra inabilità a capire davvero chi siamo, e chi siamo in relazione agli altri animali, e quindi ad avere una prospettiva su questo. Detto ciò, delle tante caratteristiche umane che ci definiscono come specie, non credo che ce ne possa essere una che sia unicamente umana: non c’è davvero nulla di quello che noi abbiamo che non possa essere rintracciato, in dosi minori o in modalità differenti, in qualche altro animale. Siamo un “caso estremo di esseri animali”. Siamo la specie più creativa ma anche la più distruttiva, siamo la più compassionevole ma anche la più crudele, l’unica che conosce il disprezzo.
Due parole ricorrenti della sua riflessione su similitudini e differenze tra noi e gli altri animali sono empatia e compassione.
Sì, e c’è una differenza tra le due parole che mi piace sottolineare. L’empatia è la capacità di una mente di accordarsi all’umore di un compagno. Molti, moltissimi animali sono empatici. I pesci hanno empatia: quando uno di loro è spaventato dalla vista di un predatore, l’intero banco di pesci percepisce la sua paura e va nel panico, cambia direzione o schizza fuori dall’acqua. È la forma più antica di empatia, la paura contagiosa. Ma è anche la forma più semplice, l’abilità della mente di allinearsi a uno stato d’animo. Poi c’è un altro tipo più complesso di empatia, nel quale io sono distante dalla tua situazione e dal tuo umore ma li comprendo intellettualmente e anche se non provo nulla di quello che stai provando riesco a immedesimarmi nella tua situazione. È il caso delle condoglianze per un lutto. Questo tipo di partecipazione io la chiamo simpatia. Se questa abilità di percepire la situazione di un altro ci spinge ad agire in qualche modo, quell’azione è la compassione. Molti animali condividono l’empatia primordiale, la paura contagiosa o anche un contagioso senso di benessere: è una delle cose che ci unisce in maniera profonda, tutti. Pochi però sono capaci di simpatia e ancora meno hanno l’abilità e la motivazione di assistere e aiutare, mossi da compassione. Sono pochi animali sociali, la maggior parte dei quali mammiferi – e forse un paio di uccelli.
Spesso pensiamo alla compassione come a una caratteristica prettamente umana, ma poi fatichiamo a esercitarla sia nei confronti degli altri che nei confronti di molti animali.
È una di quelle cose in cui pensiamo di essere particolarmente bravi, una di quelle cose che pensiamo ci renda speciali in maniera evidente e grandiosa. Ma, come dicevo, siamo “animali estremi”, siamo i più compassionevoli e i più crudeli. Siamo capaci di grande compassione quando vogliamo, ma la riserviamo per lo più per le persone che conosciamo. Per le altre persone abbiamo poca compassione, a volte non abbiamo neanche empatia, altre volte vorremmo distruggere chi è diverso da noi. E gran parte delle persone ha davvero poca empatia per gli esseri non umani. Per questo non solo alleviamo gli animali ma li trattiamo in maniera crudele nei nostri allevamenti, perché non siamo interessati ai loro sentimenti. Molte persone si raccontano la storia che gli altri animali non possono provare nulla, ma ormai è chiaro, è provato, che possono sentirsi felici, tristi, che possono condurre una vita serena o una vita tormentata. È una cosa nota, ma facciamo ancora finta di non saperla.
Qual è la più grande responsabilità che abbiamo, allora, come esseri umani, nel mondo di oggi?
Penso che la responsabilità maggiore sia quella di vivere e lasciar vivere. E non sono io a dirlo, è una forma di saggezza antica, anche se non la mettiamo in pratica così bene. Cosa stiamo facendo al resto del mondo vivente? Se ci vogliamo credere proprietari della Terra dobbiamo anche diventarne responsabili, dobbiamo agire, “per delega”, per conto delle altre specie. Se le foreste, le praterie, gli oceani, i fiumi sono nostri, allora è nostra la responsabilità degli animali che vivono in quelle foreste, praterie, oceani e fiumi. E invece oggi ognuno di quegli habitat è alla sua estensione minore o nello stato più degradato della storia e della preistoria. Ed è a causa nostra. Distruggiamo gli habitat, li tagliamo, li riduciamo, li semplifichiamo sotto forma di allevamenti, li inquiniamo con pesticidi e fertilizzanti. E ogni altra popolazione animale, ogni specie nel mondo – con davvero poche eccezioni, forse piccioni e ratti – è al suo minimo. Gli esseri umani, in questo momento storico, non sono compatibili con la continuità della vita sulla Terra. Siamo la causa del degrado e della diminuzione di ogni habitat naturale e di ogni altra popolazione animale con molte poche eccezioni. Gli animali che alleviamo, di quelli ne abbiamo a milioni, ma li costringiamo a una vita penosa, e poi li uccidiamo. Guardando così le cose, mi sento di dire che quella che abbiamo in questo momento non è la migliore relazione possibile con il resto del mondo. Dobbiamo garantire la continuità del processo e del ciclo della vita. Nessuno di noi durerà in eterno, siamo qui solo per qualche anno. Ma la continuità della vita dovrebbe essere la nostra responsabilità più grande, dobbiamo garantire che ci sia spazio per le altre specie, che possano prosperare in popolazioni vitali.
E dovremo sacrificare qualcosa, del nostro modo di pensare, del nostro modo di vivere?
Be’, non penso assolutamente che sia un sacrificio vivere in un modo compatibile con la vita. Penso che sia un sacrificio vivere in un modo che distrugge la vita. Vivere in un modo che avvelena il mondo, che finisce per avvelenare anche i nostri stessi corpi, che crea tumori, malattie ai polmoni, malattie cardiache. Questi sono i sacrifici che stiamo già facendo. E cosa ne otteniamo, in cambio? Solo milioni e milioni di persone in più, pronte a vendere qualcosa a qualcun altro. C’è il doppio di esseri umani in vita rispetto a quando sono nato. Ma il mondo non mi sembra sia diventato un posto “doppiamente migliore”. È affollato il doppio, sotto molti punti di vista è diventato competitivo il doppio, e vediamo le conseguenze di questa competizione nella crisi delle democrazie, nell’ascesa di leader autoritari, – almeno una radice di tutto questo credo vada rintracciata proprio nella paura e nella competizione che viviamo a causa del sovraffolamento. Quindi, per me questi sono i grandi sacrifici, vivere in questo tipo di mondo è un sacrificio. Provare a immaginare di vivere con più leggerezza, invece, in un mondo in cui godere della bellezza del resto della vita del pianeta e cercare di non distruggerla o umiliarla: questo non mi sembra un sacrificio.
Scrivere libri è una forma di attivismo?
Scrivere è senza dubbio una forma di attivismo. Basta andare online e cercare quanti giornalisti vengono uccisi ogni anno. Il mio obiettivo è un altro però, il mio obiettivo è comunicare alle persone questa piccola fetta di universo che riesco a vedere. Conoscere cose nuove e avere compassione per le specie non umane del mondo. Cerco di aprire una finestra su questo tipo di panorama. E spero che possa servire a qualcosa, certo, a cambiare le cose. Almeno in questo senso sono un attivista anch’io.