


I l gasogeno. Autarchia. Veicoli FIAT costruiti razionalmente per energie termiche nazionali”. È il titolo di un pieghevole pubblicitario pubblicato dall’Ufficio stampa FIAT, a Torino, nel 1936. Un reperto di quegli anni che testimonia una storia di tecnologia e propaganda che oggi forse è poco ricordata ma che fu centrale nelle vicende del regime fascista. Riemerge tra i memorabilia delle librerie dell’usato; nella descrizione del pieghevole in vendita online a qualche centinaio di euro si legge: “A4 falde, cm 89 x 28,5, illustrato con una immagine al fronte di Porcheddu raffigurante lo stabilimento Fiat Lingotto posto tra due bande rosse e verdi contenenti le parole autarchia e gasogeno. Diffusa descrizione tecnica degli autobus a gasogeno Fiat 635 RGL e 635 RG con corredo di molte illustrazioni e disegni tecnici. Grafica modernista in chiave autarchica. Piccoli strappetti ai margini”.
Il gasogeno (o gassogeno) è un apparecchio che crea un gas a base di monossido di carbonio a partire dalla combustione di biomassa. Si brucia quindi della legna e si ottiene quello che è un gas “povero”, ma che può anche alimentare un motore a combustione interna, come quello di un’automobile o di una barca. Il fascismo vedeva nell’uso di impianti a gasogeno per automobili e automezzi italiani la soluzione ideale per rendere energeticamente indipendente un Paese povero di risorse fossili come l’Italia. Alla mancanza di petrolio si poteva sopperire con l’abbondanza di alberi e foreste: “Il sogno fascista era riuscire ad alimentare macchine a gasogeno con materiali di scarto della silvicoltura e dell’agricoltura”, si legge nella Natura del duce (Einaudi, 2022), recente saggio scritto dagli storici dell’ambiente Marco Armiero, Roberta Biasillo, Wilko Graf von Hardenberg.
Il gasogeno è un apparecchio che crea un gas a base di monossido di carbonio a partire dalla combustione di biomassa. Si brucia della legna e si ottiene quello che è un gas “povero”, ma che può anche alimentare un motore a combustione interna.
Il fascismo, spiegano gli autori, aveva un’anima ruralista, celebrava una cultura del bosco e delle campagne. Il fratello del duce Arnaldo Mussolini fu, non a caso, il primo presidente del Comitato nazionale forestale. Al tempo stesso, in quegli anni l’Italia si stava industrializzando, un’evoluzione essenziale anche dal punto di vista militare per il regime. Proprio il gasogeno, per il fascismo, assunse così il valore di una tecnologia simbolica, che permetteva una sintesi “alchemica” capace di tenere ruralismo e progresso in un circolo virtuoso, mettendo a profitto le “energie termiche nazionali” per far muovere i veicoli.
Questo strano dispositivo, che venne poi abbandonato per questioni tecniche e sistemiche, per problemi di sostenibilità, produzione, efficienza e sicurezza, non è stato però un’esclusiva del fascismo. Né, come vedremo, è stato completamente dimenticato.
La foresta nella macchina
Durante il ventennio, la propaganda fascista sul gasogeno venne perfettamente integrata in una precisa narrazione imposta dal regime. Nella Natura del duce gli autori ricostruiscono l’Italia fascista come un Paese in lotta contro la natura “selvaggia”, avara di combustibili fossili, e generosa di paludi malsane, ma anche di torrenti impetuosi e boschi. È una natura non da tutelare in quanto parte di relazioni socio-ecologiche, ma piuttosto da sottomettere e mettere a valore, da trasformare così in un’alleata. Questo è l’humus su cui nascono le bonifiche, i parchi nazionali, e le centrali idroelettriche. Tutti progetti che in realtà avevano un piede nell’era liberale, a cui il fascismo comodamente subentrò con la sua retorica potente, e che avrebbe poi incluso il miraggio dell’autarchia. Il discorso fascista parlava di una razza italiana passionale e ingegnosa, destinata a vivere in un paese rigenerato e fecondo, in ogni senso. Non c’era niente di più ingegnoso allora di un apparecchio che usava una materia prima ampiamente disponibile per sottrarsi al giogo dei Paesi stranieri ricchi di combustibili fossili. Scrivono gli autori del saggio:
Lo storico Leo Marx descriveva il progetto modernizzatore americano come il sogno di una macchina nel giardino, ovvero di una possibile convivenza tra ideale pastorale e progresso tecnologico. Nel caso del motore a gasogeno, piú che la macchina in giardino sembrerebbe che il fascismo proponesse il percorso inverso, ovvero la foresta nella macchina. Era la natura che doveva entrare – letteralmente e metaforicamente – dentro gli ingranaggi della modernità fascista.
Non tutti erano convinti delle meraviglie del motore a gasogeno. Come è possibile intestarsi la protezione dei boschi e, allo stesso tempo, promuovere una tecnologia avida di legna? La natura del duce ricostruisce il dibattito dell’epoca, diviso tra “disfattisti e fascisti”. Minuziosi calcoli di ingegneri, come quelli riportati nella voce “gasogeno” di Treccani del 1938, assicuravano che il gasogeno era, per così dire, “sostenibile”. Non serviva necessariamente legna pregiata per farlo funzionare, bastavano ramaglie e addirittura scarti dell’agricoltura, come le fascine di grano. Non è un caso che nel 1934, alla fiera dell’agricoltura, la Milizia forestale avesse allestito il “Parco del gas della foresta”: ci dice che il sostegno a questa impresa era condiviso proprio da quelli che si presentavano come numi tutelari dei boschi. Le cose non andarono però come previsto.
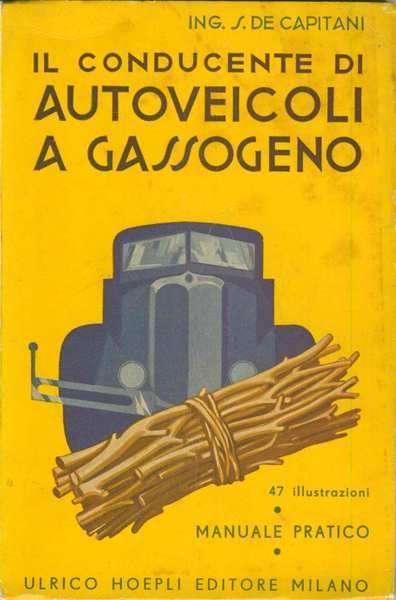
Dentro il generatore a gasogeno un combustibile solido (legna, carbone di legna…) brucia in maniera controllata, alimentato dall’aria esterna. Si sviluppa prima anidride carbonica, che ad alte temperature si combina col carbonio per dare il monossido di carbonio. Una volta raffreddato, questo gas, mischiato con l’aria, può alimentare un veicolo che sia stato appositamente adattato. Il veicolo adattato poteva anche mantenere l’alimentazione a benzina. E la tecnologia del gasogeno applicata ai veicoli, in sé, funzionava. Furono anche organizzate delle vere e proprie competizioni automobilistiche, per dimostrare nei fatti che l’auto a legna non era fantascienza.
Quello che non funzionò fu l’ingenua transizione energetica in salsa autarchica spinta dal regime. I progetti furono molti, al CNR per esempio si lavorò sia sul gasogeno sia su altri combustibili alternativi (l’alcol per esempio), con scarsi risultati pratici. Ed è vero, in Italia diversi veicoli furono convertiti a gasogeno, soprattutto nel trasporto pubblico (uscì un decreto apposito), ma come ha scritto lo storico Roberto Maiocchi:
Sul tema si assistette a un fiorire di studi e di pubblicazioni. Fu soprattutto nel settore del trasporto pubblico cittadino che il gassogeno trovò applicazione pratica. Il maggior ostacolo alla diffusione dell’autotrazione a gassogeno era rappresentato dalla difficoltà della raccolta del legname, dallo stoccaggio e dalla distribuzione del carbone di legna, molto più ingombrante e di più difficile trasporto della benzina o di altri combustibili liquidi.
Alla fine, l’Italia ridusse le importazioni di combustibili fossili, ma solo perché costretta e non perché il gasogeno si fosse dimostrato un’alternativa solida.
Il gasogeno nell’ Europa in guerra
Tra il 1938 e il 1939 la Milizia forestale impiantò 20.000 abeti sul Monte Giano, nel Reatino, in modo da formare la parola DUX. A partire dagli anni Novanta la scritta, “deteriorata” dal tempo e dalla natura (con la nascita di nuove piante) ha cominciato a essere salvaguardato, su impulso di amministrazioni di destra, per l’interesse “storico e culturale”. Come raccontano ancora gli autori del libro, nel 2017 venne bruciato da un incendio doloso:
L’inverno successivo circa mille abeti sono stati piantumati per nuovamente omaggiare il duce su iniziativa dell’associazione di estrema destra CasaPound. All’iniziativa presero parte circa duecento persone tra militanti del movimento politico, aderenti al suo gruppo di protezione civile – La Salamandra –, membri del suo braccio ecologista – l’associazione La Foresta che Avanza – e alcuni residenti.
È uno dei tanti luoghi dell’Italia del fascismo che oggi vengono apertamente celebrati. A un livello più immateriale, un po’ di commemorazione si può trovare anche nel caso del gasogeno: non è impossibile imbattersi in articoli su riviste nostalgiche che raccontano oggi il gasogeno come il pioniere fascista dell’“ibrido” o del “biocombustibile”, una verniciata di verde per nascondere il fallimento dell’autarchia celebrando la tecnica.
La tecnica, in effetti, non mancava. Il fascismo ha potuto contare sulla collaborazione di molti tra i migliori scienziati italiani. Nel marzo del 1935, pochi mesi prima dell’inizio dell’invasione in Etiopia, Mussolini scrisse al primo presidente del CNR Guglielmo Marconi per illustrargli le priorità della nazione, tra cui figurava proprio il gasogeno: nasceva ufficialmente l’autarchia. L’inventore del motore, che era un fascista della prima ora, rispose al duce che gli scienziati erano ovviamente già al lavoro sulle priorità elencate, ma lamentava in conclusione una scarsità strutturale di risorse per i ricercatori che non poteva essere ignorata. Il duce non scriverà altre lettere. Ancora Maiocchi riassume così:
Questa mobilizzazione dei tecnici e degli scienziati, più operativa che ideologica non fu e non avrebbe potuto essere sufficiente per dare qualsiasi plausibilità al progetto dell’autarchia. La scarsità di materie prime e di capacità produzione erano troppo grandi, troppo disastrose, per raggiungere gli scopi dell’autarchia, anche nella forma limitata e parziale che era stata abbozzata nei piani fascisti.
I problemi a cui lavoravano i ricercatori del duce però non erano unici: al gasogeno per autotrazione si interessavano molte altre nazioni. La produzione di gas combustibile da legna, infatti, risaliva a metà Ottocento. Le prime auto alimentate con questo gas arrivano nel 1905, fabbricate dalla ditta inglese Thorny-Croft. Ma non fanno molta strada. Fu l’ingegnere francese Georges Imbert, negli anni Venti, a far maturare la tecnologia e a renderla “pratica”.
Alcuni di questi Paesi, per esempio la Francia dopo la Prima guerra mondiale, erano anch’essi motivati da un’ideologia autarchica, almeno per quando riguardava i combustibili. Era il caso anche della Germania, che però a differenza dell’Italia non arrivò alla guerra completamente impreparata. Se l’Italia ebbe risultati molto limitati col gasogeno rispetto a quelli promessi dalla propaganda, non fu così per altre nazioni che, anche in previsione della guerra che stava arrivando, seppero sfruttare il gasogeno, nonostante i grandi svantaggi, nelle condizioni emergenziali imposte del conflitto. Una stima riportata dallo storico Finlandese Timo Myllyntaus parla di mezzo milione di autoveicoli in circolazione nel 1942 in Europa e in Unione sovietica, a cui l’Italia contribuisce con 9.000 veicoli.
In un recente studio lo storico della scienza Arne Kaijser, analizzando il caso della Svezia, ha definito l’introduzione del gasogeno “la più veloce transizione energetica che sia mai accaduta” nel Paese. Lo studioso parla di “transizione controvento” (head wind transition), perché nell’aprile del 1940, quando Hitler occupò Norvegia e Danimarca, le importazioni di petrolio in Svezia si azzerarono. Ma il Paese, che si era dichiarato neutrale, era preparato sia tecnologicamente che politicamente. Dall’inizio del secolo faceva ricerca sui carburanti alternativi, perché sapeva di non avere molti combustibili nazionali su cui contare, e aveva cominciato a pianificare un’infrastruttura che potesse sostenere l’approvvigionamento di combustibile per decine di migliaia di veicoli a gasogeno. Questo grazie a una collaborazione capillare tra governo, industria e cittadini, che ricevevano anche incentivi per l’installazione del gasogeno sulle auto private. Questo sforzo, che ad alcuni sembrava inutile in tempo di pace, si rivelò vincente con lo scoppio della guerra. I disagi non mancarono, in particolare avvelenamenti da monossido di carbonio e incendi, perché si trattava sempre di dispositivi molto meno pratici e sicuri e di un’auto a benzina. Ma alla fine del conflitto la Svezia contava ben 70.000 auto a gasogeno.
Il tramonto del gasogeno
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale le auto a gasogeno scomparvero rapidamente in tutta Europa. Non avevano più senso, ora che era possibile importare petrolio, e nessuno sentiva la mancanza di guidare un veicolo “a carbonella”, come dispregiativamente si diceva in Italia. Non fu, però, dimenticato. Nel 1973 ci fu il primo shock petrolifero, causato da un embargo dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio verso i Paesi che sostenevano Israele, che fece salire i prezzi del 300%. Tra le opzioni vagliate dalla Svezia per far fronte alle emergenze future a c’era anche quella di ricorrere al razionamento, e tornare in parte “alla carbonella”, sfruttando proprio il know how accumulato nella Seconda guerra mondiale. Venne però calcolato che era possibile convertire solo un milione di veicoli, insufficienti per i bisogni economici di quel periodo: la Svezia quindi si mise a fare ricerca anche sul metanolo, ma non arrivò mai ad attuare il suo piano di emergenza, nemmeno durante il secondo shock del 1979. L’uso del gasogeno, sia per autotrazione che per la produzione di elettricità, è stato poi considerato come un’opzione percorribile per i Paesi poveri, stando a un report del 1986 della FAO, ma gli esperimenti sono stati limitati.
Questo strano dispositivo, che venne poi abbandonato per questioni tecniche e sistemiche, per problemi di sostenibilità, produzione, efficienza e sicurezza, non è stato però un’esclusiva del fascismo; né è stato completamente dimenticato.
Eppure anche oggi il gasogeno sopravvive, in nicchie particolari. Per esempio quella dei survivalisti, che prevedono un collasso della civiltà: e ha perfettamente senso equipaggiarsi con un veicolo a legna, se si vuole vivere off the grid. Il gasogeno è rispuntato anche in Ucraina, stando a un video diffuso su Tiktok che sembra mostrare un gassificatore montato su una vecchia utilitaria. Più diffuso, ma sempre di nicchia, è invece il suo utilizzo per la produzione di calore ed elettricità.
L’autarchia energetica oggi?
In passato l’Italia (e altri) hanno tentato la strada dell’autarchia, anche energetica. Per questo hanno provato, sia a sfruttare ogni risorsa nazionale di idrocarburi, sia a espandere il territorio con la guerra coloniale, e infine con la ricerca hanno tentato nuove tecnologie (in epoca fascista diversi ricercatori si interessarono anche all’energia solare).
L’autarchia non è stata mai raggiunta e storicamente questa fase è stata descritta in termini di deriva “irrazionale” e “modernismo reazionario”, anche se alcune strategie “autarchiche” hanno dato un sollievo temporaneo in situazioni emergenziali, come è successo col gasogeno in Europa durante la guerra.
Oggi invece abbiamo da una parte il problema di decarbonizzare molto velocemente le fonti energetiche, e dall’altra una situazione geopolitica instabile foriera di shock energetici. Nessuno sente davvero la mancanza del gasogeno, ma molti in Europa stanno ora puntando sul riscaldamento a biomasse per far fronte all’inverno povero di gas. Peccato che i prezzi della legna da ardere ora siano già alle stelle, e che dieci anni di sussidi abbiano dimostrato che questa risorsa è solo ipoteticamente “ecosostenibile” senza alcun guadagno tangibile per gli obiettivi climatici o per la natura.

Nel frattempo, però, abbiamo sviluppato tecnologie ben più avanzate, alcune delle quali molto mature. Mi chiedo quindi se nel prossimo futuro abbia senso ambire all’autarchia energetica, cioè la completa autosufficienza a livello locale, ovviamente con fonti energetiche pulite. E lo domando a Luigi Moccia, ingegnere e primo ricercatore all’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni (ICAR CNR) dove si occupa di modelli di ottimizzazione per i trasporti.
“Rispetto all’autarchia ‘storica’, quella che velleitariamente si cercava nel ventennio, occorrono alcune premesse tecniche” mi spiega Moccia. Il gasogeno per auto-trazione è un metodo per trasformare la biomassa in energia meccanica, ma questa strada, conti alla mano, è del tutto inefficiente, anche con altre tecnologie (per esempio moderni biocarburanti). La produzione della materia prima dipende dalla fotosintesi, ma dal punto di vista strettamente energetico è un modo poco efficiente di sfruttare l’energia solare. Se la fotosintesi rende l’1% dell’energia assorbita, un pannello fotovoltaico arriva al 20%, e un motore elettrico è tre volte più efficiente di un motore a combustione interna. Le rinnovabili “battono” la biomassa persino sul terreno del semplice riscaldamento, se consideriamo le pompe di calore. “La produttività complessiva di un’area coltivata a fotovoltaico è 80 volte maggiore della stessa area dedicata alle biomasse”, riassume Moccia.
L’autarchia non è stata mai raggiunta e storicamente questa fase è stata descritta in termini di deriva “irrazionale” e “modernismo reazionario”.
Con questa efficienza il fotovoltaico, assieme all’eolico, hanno realmente le potenzialità per garantire l’indipendenza energetica di un paese come l’Italia, e con un consumo di suolo sostenibile. I dati indicano che le due fonti tendono a “compensarsi” tra di loro durante l’anno e anche durante la giornata, e si può quindi contare su una generazione combinata “molto meno variabile di quanto comunemente viene fatto intendere dai detrattori”.
Autarchia, però, è forse una parola un po’ estrema e fuori luogo nel contesto del prossimo futuro. Le principali fonti rinnovabili, il fotovoltaico e l’eolico, producono energia elettrica, che si sposta facilmente su grandi distanze ma è più difficile da stoccare. Inoltre, non sono programmabili. Quindi la generazione va bilanciata con tecnologie di accumulo, che possono essere di vario tipo e scala. A livello nazionale (o regionale) è teoricamente possibile essere totalmente “autarchici” con le rinnovabili, cioè provvedere localmente sia alla generazione che al bilanciamento, ma non è detto che sia la scelta migliore in assoluto. Uno studio del 2020 sul sistema europeo suggerisce che sia più conveniente, in termini di costo, cooperare e scambiarsi l’energia sul continente. Un’occhiata alla mappa della rete ENTSO-E (European association for the cooperation of transmission system operators for electricity) fa capire che esiste già un’infrastruttura avanzata, e in ampliamento, per gli scambi di energia elettrica tra regioni e paesi. Si potrebbe poi aggiungere che è bizzarro parlare di “autarchia” energetica quando mezzo mondo dipende dall’altro per i metalli necessari alla transizione, se non direttamente per la componentistica.
La storia non finisce qui. Ci sono settori “non facilmente elettrificabili, come il trasporto aereo, il trasporto marittimo di lunga distanza (le navi per le brevi e medie distanze andranno sulle batterie), e anche nel coprire quegli ultimi punti percentuali della domanda elettrica annua che non possono essere serviti per mancanza di sole/vento”. Ma nemmeno questo ci lega in perpetuo ai combustibili fossili. L’elettricità da fonti rinnovabili può essere accumulata chimicamente nell’idrogeno ottenuto dall’elettrolisi dell’acqua. È il cosiddetto idrogeno “verde”, per distinguerlo da quello generato a partire da fonti fossili.
Oggi che abbiamo sviluppato tecnologie ben più avanzate, alcune delle quali molto mature, è possibile invece ambire all’autarchia energetica, alla totale autosufficienza, con fonti energetiche pulite?
La molecola è importantissima per l’industria chimica o dell’acciaio, ma come vettore energetico, presa tal quale, è di uso difficile per il trasporto e lo stoccaggio. Avrebbe invece un utilizzo maggiore se trasformato in idrocarburi liquidi o gassosi, secondo il principio del power to X. Per esempio, l’idrogeno “verde” può essere convertito in metano (metanizzazione) e accumulato nei depositi geologici già esistenti. Per trasformare l’idrogeno però serve una fonte di carbonio, che ovviamente non può essere di tipo fossile.
Qui potrebbe esserci, mi spiega Moccia, un ritorno non tanto della “foresta nella macchina”, ma degli “scarti della foresta nella macchina”, cioè del riscatto dell’umile biomassa: “Il carbonio messo a disposizione dalle piante nel loro ciclo della CO2 può essere la fonte integrativa che permette al vettore idrogeno di servire per quegli usi non facilmente elettrificabili. Non sarebbe più l’inefficiente e velleitario utilizzo a grande scala della fotosintesi ma un suo utilizzo integrativo a tecnologie sulle quali avremmo dovuto da tempo investire di più”.