


Q uesta settimana ho vinto un sacco di premi. L’app che utilizzo per tenere allenata la memoria e ingannare i tempi morti mi ha fatto sapere che sono diventato maestro di secondo livello. Quella che uso per obbligarmi a fare un po’ di esercizio fisico a un certo punto ha trillato: avevo appena superato i mille minuti complessivi. Pocket, l’app con cui salvo gli articoli da leggere più tardi, mi ha fatto i complimenti perché nei giorni precedenti avevo letto più del solito. E poi sono riuscito in un’impresa straordinaria: ho ricevuto una medaglia di bronzo da una newsletter perché questo mese avevo aperto tre delle loro email quotidiane.
Salute, informazione, tempo libero: tutta la mia vita sta diventando un grande gioco, costantemente soggetta a premi e incentivi per spronarmi a fare ciò che si vuole che io faccia. Non è certo un caso isolato, non è nemmeno un caso strano: tutti siamo travolti dall’epidemia di una gamification (letteralmente, l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi in contesti esterni ai giochi) che diventa più pervasiva ogni giorno che passa. L’intento sarà anche apprezzabile – che male c’è a essere spronati a esercitarsi o a leggere?–, ma i lati negativi sono sempre più evidenti.
La frusta elettronica
Nei piani sotterranei del Disneyland Resort Hotel, in California, il lavoro svolto dagli addetti alla lavanderia viene misurato in tempo reale e mostrato su un display elettronico che monitora la produttività. Il nome di ogni dipendente è riportato sul tabellone digitale e assume un colore diverso a seconda della velocità a cui vengono lavati, asciugati e piegati accappatoi, asciugamani e lenzuola. Se si tiene il passo degli obiettivi fissati dai supervisori il proprio nome appare in verde, se si sta rallentando diventa giallo, se si è rimasti indietro diventa rosso.
A dare retta ai siti specializzati, tutto ciò ha l’obiettivo di rendere il lavoro più coinvolgente e divertente. I dipendenti della lavanderia del resort Disney la pensano probabilmente in modo diverso e hanno ribattezzato il tabellone digitale con un soprannome azzeccato: frusta elettronica. “Ti sprona mentalmente a continuare a lavorare, non ti lascia neanche spazio per respirare”, ha raccontato a Fast Company la sindacalista Beatriz Topete. “Anche se non vorresti prendere parte alla competizione, il tabellone è un incentivo impossibile da ignorare”. Stando alla sua testimonianza, quello che era un luogo di lavoro dove regnava la collaborazione si è trasformato in un’arena, in cui pur di non tralasciare i segnali che vengono del tabellone, non si va al bagno o si abbandonano al proprio destino i meno esperti. Una delle inevitabili conseguenze è stato l’aumento degli infortuni.
Tutti siamo travolti dall’epidemia di una gamification che diventa più pervasiva ogni giorno che passa, e i lati negativi sono sempre più evidenti.
Una cosa molto simile avviene nella catena di negozi Target, dove la velocità dei cassieri è monitorata e i dipendenti sono classificati in base ai punteggi ottenuti. Nelle gelaterie di Cold Stone Creamery, invece, i lavoratori vengono incentivati a usare – in orario non lavorativo – un’applicazione che insegna a fare palle di gelato delle giuste dimensioni, mostrando quanti soldi fanno perdere al negozio i gelatai troppo generosi.
Il caso più noto, però, è quello di Amazon. Un’inchiesta del Washington Post ha mostrato come in cinque magazzini (negli USA e Regno Unito) del colosso fondato da Jeff Bezos siano stati installati, in ogni postazione di lavoro, degli schermi che mostrano semplici giochi dai nomi accattivanti, come PicksInSpace o Mission Racer. La rapidità con cui gli addetti compiono il loro lavoro – spostare gli oggetti o mettere assieme gli ordini – si trasforma sullo schermo di Mission Racer nella velocità con cui le automobili assegnate a ciascun lavoratore gareggiano su un circuito virtuale. Come in ogni corsa che si rispetti, ci sono anche dei premi: i cosiddetti “swag bucks”, una moneta aziendale che può essere utilizzata solo per ottenere del merchandising Amazon, come t-shirt o borracce brandizzate.
Amazon sottolinea sempre come questa forma di gamification sia pensata – nonostante le ovvie pressioni psicologiche che spronano i lavoratori ad accettarla – per combattere la noia e motivare i lavoratori. Ma dietro questa facciata amichevole non è difficile vedere la realtà che nasconde: aumentare il più possibile la produttività dei lavoratori e spronarli a dare il massimo, trattando gli esseri umani come fossero dei robot oppure – come ha scritto Steven Conway, docente della Swinburne University of Technology – degli zombie: “meccanismi privati dei sensi e spronati ad andare avanti a ogni costo pur di conquistare la ricompensa”. Una ricompensa che può essere anche solo quella di mantenere il lavoro.

“Attraverso le tecnologie della gamification, le aziende come Amazon e Disney raggiungono un livello di controllo senza precedenti sui corpi dei loro dipendenti”, scrive Fast Company. Una forma di microgestione che si potrebbe definire taylorismo sotto steroidi e che – come sottolinea invece Jerry Z. Muller, autore di Contro i numeri (LUISS University press, 2019) – “premiando gli individui in base alle performance registrate riduce il senso di avere uno scopo comune basato sulla cooperazione e l’efficacia. Al contrario, questa forma di ricompensa promuove solo la competizione”.
A caccia di ricompense
Ma perché funziona? Perché, psicologicamente, la gamification riesce nel suo scopo di incentivare i lavoratori a dare il massimo, anche quelli che probabilmente si rendono conto di essere soggetti a una forma di sfruttamento? “Siamo incredibilmente reattivi a ogni tipo di segnale che ci indica che stiamo conquistando un obiettivo”, ha spiegato lo psicologo Colin DeYoung. “Gamificare i processi significa creare un’informazione che ti avvisa continuamente se stai andando nella giusta direzione. Ogni volta che controlli il punteggio e scopri che sei andato bene, ricevi una scossa di dopamina che ti spronerà a dare di più”.
La dopamina è il neurotrasmettitore alla base della motivazione: si pensa sia stato sviluppato dal cervello per spronarci alla caccia e facilitare così il sostentamento. Conquistare un obiettivo scatena il rilascio di dopamina, facendoci avvertire una breve sensazione di appagamento che rappresenta, dal punto di vista neurologico, la ricompensa per aver portato a termine il nostro compito. In epoca contemporanea, la dopamina, non più legata al sostentamento, è diventata la base della ludopatia (jackpot!), della dipendenza da smartphone (like!) e ovviamente anche del successo della gamification.
La gamification, in poche parole, può essere vista come un ennesimo strumento per hackerare la psicologia umana, sfruttando necessità ancestrali per eterodirigere i nostri comportamenti secondo i desideri di terzi. Vista così, la gamification solleva un grande problema etico. E non è neanche l’unico che andrebbe analizzato.
Hackerando la psicologia umana, la gamification riesce a incentivare i lavoratori a dare il massimo, anche quelli che probabilmente si rendono conto di essere soggetti a una forma di sfruttamento.
Secondo Tae Wan Kim, docente di Etica del business alla Carnegie Mellon University, i sistemi gamificati hanno infatti il potenziale di sovvertire il ragionamento etico. L’esempio portato da Kim è quello di un bambino che sta annegando: se lo salviamo perché motivati da compassione o buona volontà, siamo di fronte a un atto moralmente buono, ma se gamifichiamo la situazione – ho salvato il bambino per ottenere punti bonus – l’atto diventa eticamente privo di valore. Per quanto possa sembrare un esempio astratto e privo di conseguenze pratiche (l’importante è che il bambino venga salvato, si potrebbe ribattere), è un aspetto non ignorabile quando, per esempio, si porta la gamification all’interno di realtà – spesso istituzioni pubbliche – che dovrebbero avere a cuore il benessere della collettività. Se il numero di crimini gravi compiuti in un quartiere diventa l’unico punteggio in base alla quale viene deciso quali funzionari di polizia saranno promossi, il rischio è che alcuni di questi decidano di non registrare una certa percentuale di crimini o li classifichino forzatamente come crimini minori. Oppure che si concentrino a tal punto sul numero di casi da chiudere entro l’anno da concludere alcune indagini frettolosamente, con tutti i rischi che ciò comporta.
Nel caso dei medici valutati in base alla percentuale di operazioni di successo compiute rispetto al totale di quelle eseguite, il rischio è che rifiutino di occuparsi dei casi più gravi, mettendo a rischio il paziente. E i professori giudicati esclusivamente in base al rendimento della classe? Potrebbero alzare i voti in maniera arbitraria e quindi promuovere anche chi non lo merita. Le metriche si prestano a essere truccate molto più del semplice giudizio umano; e poiché siamo uomini e non robot, gli espedienti per volgere la dittatura della metrica a nostro favore sono sempre a portata di mano.
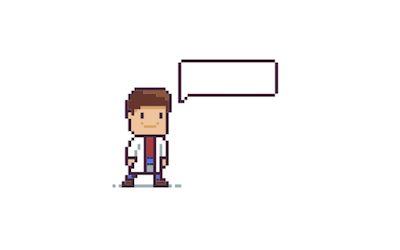
Più in generale, l’ossessione verso i punteggi (che sono alla base della gamification del lavoro) rischia di promuovere non solo una competizione esasperata tra colleghi, ma anche una visione esclusivamente di breve termine. “Le persone si concentrano su queste misure, spesso a costo di altri obiettivi ben più importanti, ma che non possono essere misurati”, scrive ancora Jerry Z. Muller. “Gli analisti che sono riusciti a individuare Bin Laden ci hanno lavorato per anni. Se fossero stati misurati in qualunque momento, il loro tasso di produttività sarebbe stato pari a zero. (…) Eppure, la possibilità di fare conquiste notevoli dipende proprio dalla capacità di assumersi rischi di questo tipo”. Come dire: più utilizziamo dei parametri rigidi per valutare il nostro lavoro, meno siamo disposti a correre rischi che potrebbero portare, in tempi lunghi, a risultati e obiettivi più ambiziosi.
Gamificare tutto
Riflettere sulle nostre azioni diventa ancora più importante quando si pensa alla gamification della guerra, sempre più spesso combattuta da remoto con droni guidati attraverso controller simili a quelli della Playstation. Una guerra-videogioco, che ha portato – come racconta un breve documentario del Guardian – l’esercito degli Stati Uniti e quello britannico ad assoldare direttamente dei gamer esperti. Il risultato è che ammazzare qualcuno diventa, come racconta un pilota di drone, “simile a schiacciare una formica e non pensarci più”.
La gamification, insomma, incentiva la competizione, crea distacco rispetto alle attività svolte e costringe a focalizzarsi sul breve termine. Da quest’ultimo punto di vista, si potrebbe anche parlare di gamification della politica, causata dai sondaggi che settimana dopo settimana mostrano gli indici di fiducia dei partiti e dei leader. Sondaggi che hanno trasformato la politica – come si legge nei manuali di marketing elettorale – in una corsa di cavalli tutta concentrata sulla politics a scapito della policy, sul ritorno immediato di consenso, sottoponendo i politici al giogo costante del gradimento e rendendo quasi impossibile attuare politiche di lungo termine.
Per quanto sia il lavoro ad aver subito la gamificazione più massiccia, evidente ed esplicita nei suoi veri scopi (spremere la massima produttività dai lavoratori), la verità è che ogni aspetto della società è stato o si sta – in misure diverse – gamificando. I social network hanno trasformato la nostra vita sociale in un contest di popolarità calcolabile al singolo like o follower; le app per la gestione della vita quotidiana – come LifeCycle – trasformano in un gioco la vita di tutti i giorni (“questa settimana hai visto i tuoi genitori il 15% in più della settimana scorsa, ottimo lavoro!”); le app per la salute pre-installate sugli smartphone ci spronano a camminare di più anche se avremmo voglia di fare altro (e quelle presenti su Apple Watch ci rimproverano se non teniamo il ritmo).
La gamification incentiva la competizione, crea distacco rispetto alle attività svolte e costringe a focalizzarsi sul breve termine
Tutto diventa soggetto a metriche, misurazioni, punteggi. Tutto ispirato ai videogame. Ma – come spiega bene il game designer Ian Bogost – “proprietà incidentali dei videogiochi come i punteggi e i livelli sono state confuse per elementi essenziali come l’interazione o la complessità comportamentale”. Un fraintendimento ignorato anche da chi ha progettato quella che oggi rappresenta l’esperimento definitivo della gamification: il social credit score cinese, un unico grande ranking sociale – ancora in corso di sperimentazione e per ora diviso in vari sistemi – che mira a dare punteggi in base a ogni aspetto della vita (ore di volontariato, dieta, attività fisica, puntualità nei pagamenti; ma anche multe, acquisti e persino frequentazioni) per premiare i cittadini modello – attraverso corsie preferenziali per i concorsi pubblici o facilità nell’ottenere finanziamenti – e penalizzare gli altri.
È l’ultimo livello: il “mostro finale” della gamification della vita e della società, che con i suoi tentacoli abbraccia tutto dispensando classifiche, premi e punizioni per ogni nostra singola attività; classificando l’umanità e dividendola algoritmicamente in buoni e cattivi. Le persone diventano così materiale da punteggi in stile TripAdvisor. Non dovrebbero esserci dubbi: questa non è una storia che può andare a finire bene, e non c’è bisogno di citare ancora qualche famoso episodio di Black Mirror.