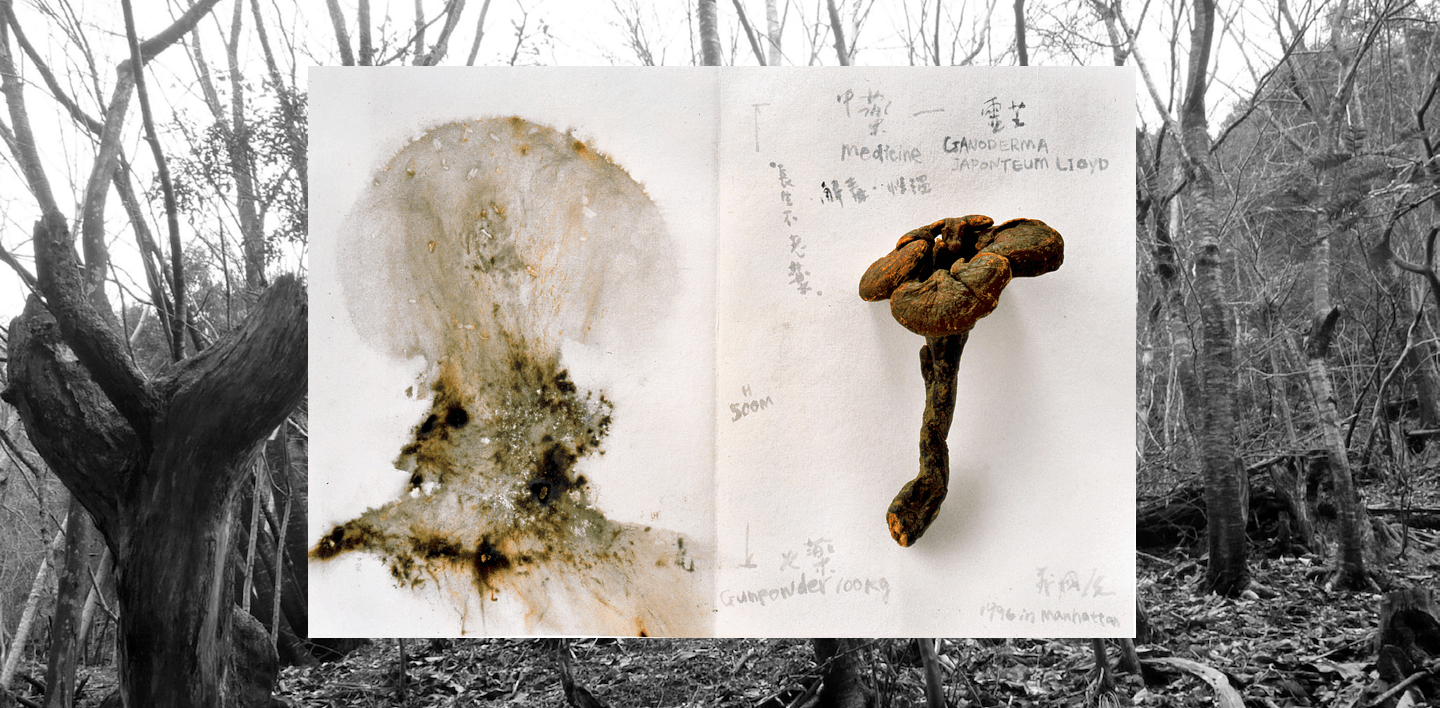
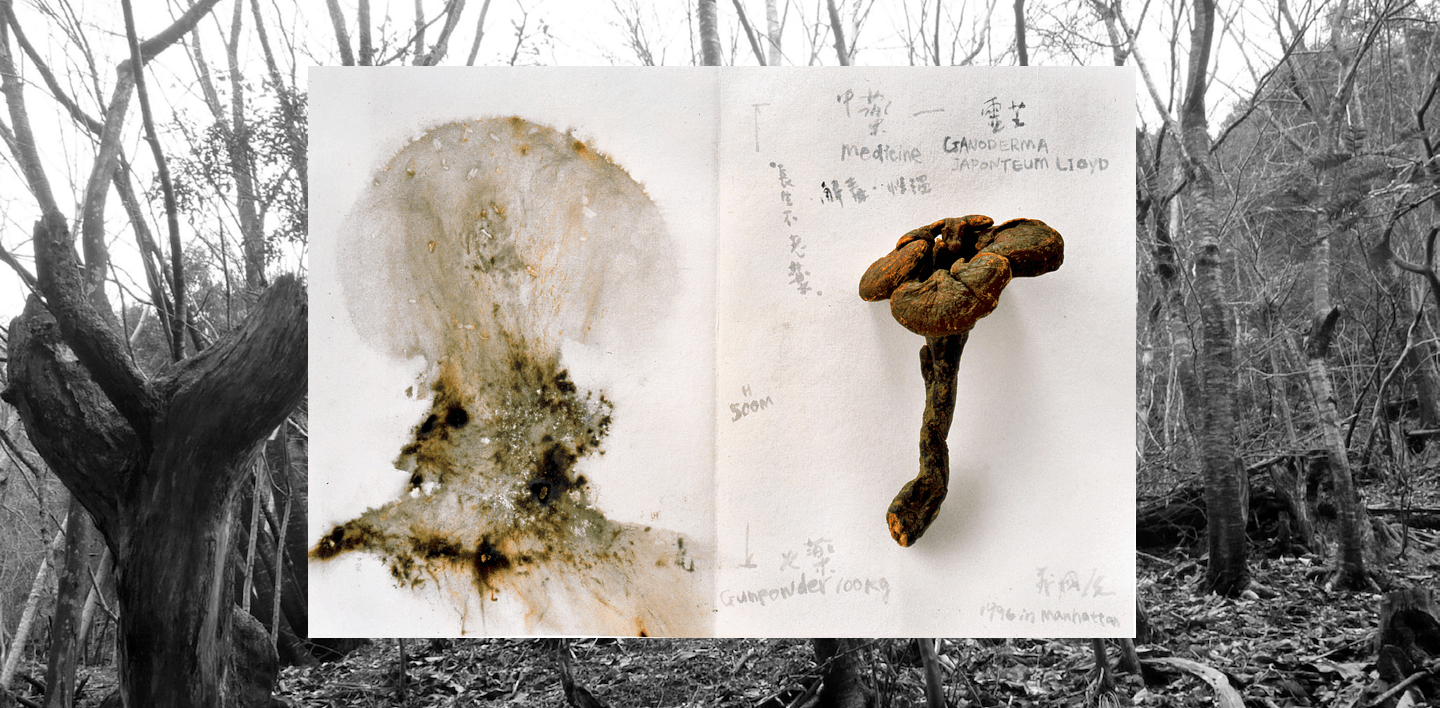
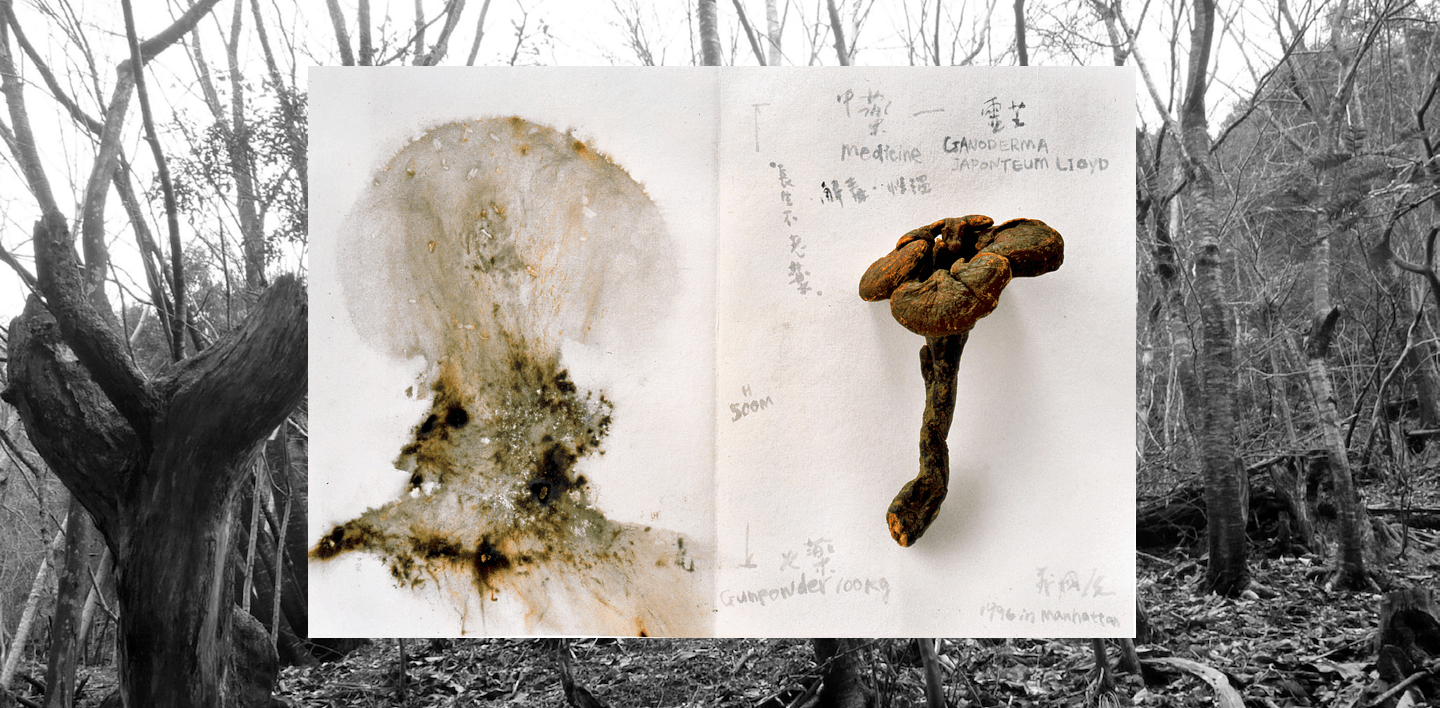
U n fungo è un fungo è un fungo. Eppure, al fungo matsutake è toccata la sorte di diventare una spugna di significati a tal punto da farci chiedere dov’è che finisce la metafora e inizia il fenomeno sociale – o dov’è che finisce il mondo e inizia la metafora. Il matsutake (Tricholoma matsutake) è infatti al centro di Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, libro dell’antropologa Anna Lowenhaupt Tsing che ha suscitato un ampio dibattito internazionale sia nel mondo accademico che al di là dei circoli di specialisti. Una delle ragioni di tale successo è che, alla sua uscita, è da subito apparso il punto di congiunzione fra alcuni degli interessi più in voga nel dibattito delle scienze sociali, antropologia in primis: il rapporto fra umano e non-umano, il paradigma delle rovine, l’interesse per le forme vegetali e le loro interconnessioni – metaforiche o meno – con le società umane, oltre ad alcune istanze teoriche piuttosto fortunate (e talvolta abusate) quali l’idea di “assemblaggio”, che da parte sua l’autrice chiama in causa per raccontare “scene per prendere in esame la vivibilità: la possibilità di vita comune su una terra perturbata dall’uomo”. Il libro è uscito nel 2015 ed è ora arrivato anche in Italia grazie a Keller e alla traduzione di Gabriella Tonoli.
Il matsutake è frutto di una micorriza, ovvero un’associazione simbiotica fra il micelio di un fungo e le radici di un’altra specie vegetale, una pianta superiore, nel suo caso i pini. È un fungo commestibile ritenuto estremamente prelibato e generalmente piuttosto costoso. Non è possibile coltivarlo. Cresce per lo più in Giappone, Corea, Bhutan, Laos, Estonia, Polonia e nei paesi scandinavi, ma anche in alcune zone della costa pacifica di Canada e Stati Uniti.
Ma i funghi selvatici matsutake hanno una particolarità fondamentale: quella di spuntare per lo più in foreste perturbate dall’uomo, ovvero zone di sfruttamento industriale intensivo e di successivo abbandono, di gestione altamente antropizzata di quegli spazi “naturali”, talvolta zone vittime di disastri ambientali, e così via. Anna Lowenhaupt Tsing indaga quelle forme di perturbazione e le forme di sussistenza umana che generano o che, secondo l’autrice, lasciano intravedere o immaginare:
Seguire le tracce dei matsutake ci apre alla possibilità di coesistenza all’interno di perturbazioni ambientali. Non è una scusa per arrecare altri danni, ma un esempio tangibile di sopravvivenza collaborativa.
Tali forme di perturbazione diventano esse stesse parte dei fenomeni di cui il libro rende conto, attraverso una postura che si vuole a suo modo profondamente epistemologica: “i paesaggi perturbati dall’uomo sono gli spazi ideali per un’attenzione di tipo umanista e naturalista”. Del resto, l’intenzione da parte di Tsing di assegnare ai funghi in questione la responsabilità di farsi metafora è esplicita e programmatica:
Dovremmo provare a guardarci attorno e osservare questo nuovo mondo, e dovremmo ampliare gli orizzonti della nostra immaginazione fino ad abbracciarne i contorni. E qui ci vengono in soccorso i funghi. La prontezza con cui i matsutake spuntano in paesaggi devastati ci permette di esplorare le rovine in cui ora abitiamo tutti.
I funghi matsutake vengono assunti dall’autrice come “beni modesti” capaci di “far luce su grandi storie” e di svelare l’economia mondiale nel suo essere frutto di congiunture storiche. Per indagare tutto questo, Tsing si dichiara interessata alle “arti dell’etnografia e della storia naturale”, ed è in questa prospettiva metodologica che si snoda il racconto etnografico del libro, che passa per le comunità di raccoglitori di funghi e per le pratiche di trasporto e vendita, che attraversa le foreste della Catena delle Cascate, dell’Oregon, della Lapponia finlandese, e che arriva fino ai mercati di Tokyo e degli altri luoghi dove si va a cercare quel fungo così caro a chi, in certi ristoranti chic, spesso vi cerca un sapore dal proprio passato: una sorta di madeleine con le spore.
Il fungo alla fine del mondo ha segnato un’ampia area del dibattito antropologico globale degli ultimi anni, tanto che ci si è talvolta spinti a proporre quello dei funghi e delle loro caratteristiche come un paradigma epistemologico in sé (sollevando così anche qualche critica: cosa si perde e cosa si guadagna nel trasformare un elemento naturale in metafora nei casi in cui, come appunto il mondo dei funghi, le caratteristiche sono talmente interessanti e dense che basterebbe limitarsi al loro studio in sé, prima di una loro distillazione metaforica talvolta frettolosa e sbilanciata?).
In ogni caso, Anna Lowenhaupt Tsing era decisamente la figura ideale per un’indagine come quella condotta per Il fungo alla fine del mondo, visto il suo percorso scientifico e biografico – Tsing è di stanza alla University of California a Santa Cruz e a capo di un progetto di ricerca sull’Antropocene all’università di Aarhus, in Danimarca –, e vista la sua precedente e altrettanto fortunata opera del 2004: Friction. An Ethnography of Global Connection. Lì l’antropologa analizzava come le forme legali e illegali di sfruttamento capitalista delle risorse naturali e le dinamiche della globalizzazione abbiano modificato il paesaggio delle foreste pluviali dell’Indonesia, teatro, fra le altre cose, di degrado ecologico, di attivismo ambientale e di quella che, con il senno del suo libro successivo, potremmo già leggere come vita fra le rovine di una foresta. La metafora che Tsing proponeva in quel libro – che appare una sorta di prontuario di metodi etnografici per studiare le interconnessioni globali e gli inattesi effetti creativi dell’incontro fra differenze –, era quella della “frizione”: un’immagine ritenuta particolarmente efficace per la descrizione dei modi in cui le varie e conflittuali interazioni sociali plasmano il mondo contemporaneo, attraverso le “problematiche, ineguali, instabili e creative qualità dell’interconnessione attraverso la differenza”.
Interessata all’etnografia e alla storia naturale, con Il fungo alla fine del mondo Anna Lowenhaupt Tsing ha segnato un’ampia area del dibattito antropologico globale degli ultimi anni.
Fra i molteplici punti d’interesse offerti dall’etnografia di cui Il fungo alla fine del mondo dà conto, uno dei più densi riguarda le traiettorie di molti dei cercatori del prezioso fungo, che appartengono a minoranze culturali senza diritti costrette a emigrare. Sono per esempio rifugiati, dalla Cambogia e dal Laos, sono Khmer – ancora impegnati a guarire dalle ferite di guerra –, sono rifugiati Lao, sono Hmong – ai cui occhi i paesaggi della foreste dei funghi ricordano quelli della loro lotta –, e sono anche veterani statunitensi bianchi.
Di fronte a queste tensioni storiche, l’autrice vede la raccolta dei funghi come una “pratica di libertà” che sembra distillarle e, in definitiva, pacificarle. A leggere gli episodi e le parole riportate dall’etnografa – che si trova per esempio a interagire con persone per le quali cercare i matsutake poteva significare riattivare i ricordi traumatici della guerra in Vietnam o corrispondere a una dolorosa e permanente rinegoziazione della propria identità e dei propri diritti di cittadinanza in un paese che si sta rilevando attivamente ostile –, viene però un dubbio. Più che una pratica di libertà, non assistiamo piuttosto alla una riproduzione di varie forme di conflittualità, conflittualità che riesce a esprimersi solo in spazi che paiono così interstiziali proprio perché radicalmente marginalizzati e disinnescati attraverso un processo di depoliticizzazione (più che di pacificazione economica e sociale)? D’altra parte, a tale processo di depoliticizzazione paradossale sembrano talvolta concorrere, loro malgrado, anche le letture analitiche in termini di “diversità contaminata” che l’autrice offre. E non mancano poi nel libro considerazioni come: “fortunatamente abbiamo ancora compagnia, umana e non umana”, o riferimenti all’“aroma dell’autunno”, ovvero passaggi in cui a un certo incanto stilistico-poetico pare tradursi in un invito al disincanto politico. It’s the end of the world as we know it / and I feel fine, cantavano i R.E.M.
Tsing sembra insomma mostrare una fiducia quasi mistica nella capacità umana e ambientale di offrire allo stesso tempo vie di fuga al disastro che stiamo combinando e possibilità di rendere udibili le storie di chi quelle vie di fuga le crea o già le percorre da tempo: “è ascoltando questa cacofonia di storie di turbamento che potremmo incontrare le migliori speranze di sopravvivenza precaria”. In questo senso, da una parte il libro offre effettivamente alcuni esempi illuminanti di quanto Tsing chiama “indeterminazione dell’incontro”, ovvero di possibilità di nascita di modi di vita adatti a un mondo post-industriale (a partire dalla sopravvivenza attraverso la ricerca degli scarti della società capitalista o di ciò che cresce beffandone i sistemi produttivi e la relativa distruzione ecologica – come i matsutake, talvolta salvifici ma pur sempre rari e inaffidabili). Dall’altra parte, però, la proposta dell’antropologa pare quella di un indulto globale in cui deconflittualizzare tutte le congiunture e le responsabilità passate e presenti alla base delle vite precarie di cui il libro dà parzialmente conto, a partire dagli attori e quadri normativi del sistema socio-economico e di sfruttamento ambientale che quei margini territoriali e sociali li produce e riproduce. È solo in questa prospettiva che le storie raccontate possono apparire, come vorrebbe l’autrice, “melodie” che si uniscono in “momenti inaspettati di armonia e dissonanza”.
Ed è forse solo sotto questa luce che sembra comprensibile come, dopo aver raccontato la precarietà delle vite e della sussistenza sempre appesa a un filo di molti dei raccoglitori di matsutake, l’autrice possa scrivere, deliziata: “il fatto che per molti anni non ci siano matsutake [da raccogliere] è di per sé un dono: un’apertura verso l’irregolarità temporale delle storie che le foreste creano”. Ma non si capisce bene quanto tale mancanza possa sembrare così tanto un “dono” se sei qualcuno che, senza quel fungo, non sa bene come sbarcare il lunario. Tsing scrive delle “curiose congiunture che caratterizzano la sopravvivenza collaborativa”, o perfino del fatto che “la vita precaria è sempre un’avventura”. Già. Questa fiducia nella capacità di vita fra le rovine sembra essere la chiave che Tsing trova per sgomberare il campo dall’angoscia della cosiddetta fine del mondo. Ma se questo avviene – anche – attraverso una depoliticizzazione, può andar bene solo a chi quella apocalisse quotidiana si può permettere di osservarla da una posizione protetta.
La fiducia nella capacità di vita fra le rovine sembra essere la chiave che Tsing trova per sgomberare il campo dall’angoscia della cosiddetta fine del mondo.
Da questo punto di vista, i moltissimi elementi di grande interesse offerti dal libro, incluse le disparate e sempre affascinanti storie convocate in questa costellazione di spore, appaiono talvolta come un tentativo di offrire un elegante e affascinante placebo umanista all’inquietudine dello stato attuale del mondo e di ciò che possiamo verosimilmente aspettarci, al di là dei margini d’imprevedibilità e della, secondo la formula così cara a Tsing, “indeterminatezza degli incontri” futuri. Tsing cita eventi, vite, episodi, cita John Cage (il grande compositore ha dedicato una serie di miniature musicali, dal titolo Indeterminacy, al suo incontro con i funghi); scrive che “gli intrecci fanno esplodere categorie e stravolgono identità” e si lancia alla ricerca di una traccia di queste sue intuizioni direttamente nella storia genetica dei funghi e delle specie a essi contigue. Ma le preoccupazioni teoriche e descrittive di Tsing appaiono più di ordine estetico ed etico che politico o scientifico, in uno squilibrio che finisce per stemperare troppo proprio la possibilità di un intervento sul mondo.
A fiammate di acutezza analitica e intuizioni rivelatrici – l’autrice è del resto una delle più affidabili osservatrici mondiali della vita quotidiana e della marginalità ai tempi del tardo capitalismo – si alternano così ripetuti passaggi in cui il disincanto pare travestirsi da falsa ingenuità, come se la devastazione in corso fosse troppo emotivamente dura da affrontare con le sole armi delle scienze sociali:
Vi è qualcosa di peculiare e spaventoso in questo dedicarsi al recupero, come se tutti approfittassero della fine del mondo per racimolare ricchezze prima che ne vengano distrutti gli ultimi brandelli.
Ecco allora che il punto che il libro sembra ignorare è che quei margini – umani, non-umani, naturali e “naturali” – sono profondamente organici alla disciplina capitalista, e non residui che essa lascia inavvertitamente o scarti che produce involontariamente. Il fungo in questione si fa perfino più indigesto quando le argomentazioni paiono sbattere contro i limiti della metafora che gli viene incollata addosso: “non è facile sapere come guadagnarsi da vivere, ancor meno come evitare una distruzione planetaria”. Ne è un esempio l’assenza pressoché totale di riferimenti a ciò che, in quel mondo capitalista dai margini tanto romanticamente affascinanti agli occhi dell’autrice, fa sì che coesistano pacificamente in una stessa etnografia, da una parte raccoglitori di funghi che faticano a procurarsi di che sopravvivere in quel sistema che li ha così marginalizzati e, dall’altra, persone benestanti che possono permettersi di andare al ristorante a mangiare un costoso fungo in cui cercare proustianamente il ricordo olfattivo e gustativo del loro passato. In una simile visione deconflittualizzata di un mondo dai margini che sostituiscono il centro, la disuguaglianza fa la figura della guastafeste e la sua aperta denuncia appare forse un argomento poco elegante da trattare.
La possibilità di vivere nelle rovine del mondo non deve però confortarci, o portarci a rinunciare a intervenire sul mondo prima che questo si faccia definitivamente rovina.
Concentrarsi sui “margini della disciplina capitalista” e sulle “estremità incolte dei nostri paesaggi deflagrati”, come li definisce l’autrice con la sua eleganza stilistica, rischia così di essere una resa: un atto di rinuncia di fronte a ciò che marginale non è, rispetto a ciò che di gigantesco e maggioritario sta in mezzo a quelle estremità incolte: rispetto al mondo intero intorno al fungo. La possibilità di vivere nelle rovine del mondo non deve confortarci, o portarci a rinunciare a intervenire sul mondo prima che questo si faccia definitivamente rovina. Visto sotto questa luce, il paradigma offerto da Il fungo alla fine del mondo ci appare come una tentazione a cui non dovremmo cedere. Non ancora.
Del libro, rimangono però le felici possibilità offerte dalla vera e propria pratica etnografica, che permette di andare al cuore delle dinamiche incarnate e quotidiane, delle questioni in gioco e dei bisogni e desideri dei soggetti, e di farlo attraverso un tipo di informazioni interstiziali e di dettagli solo apparentemente minori. Come quando Tsing, etnografa sopraffina, racconta delle mappe che il servizio forestale dà ai raccoglitori di funghi, in Oregon. Fogli che risultano sempre inutili, con spazi astratti e delimitazioni che i raccoglitori non rispettano. In fondo a una nota a piè di pagina l’antropologa aggiunge: “alcuni usano le mappe come carta igienica, che scarseggia negli accampamenti”.