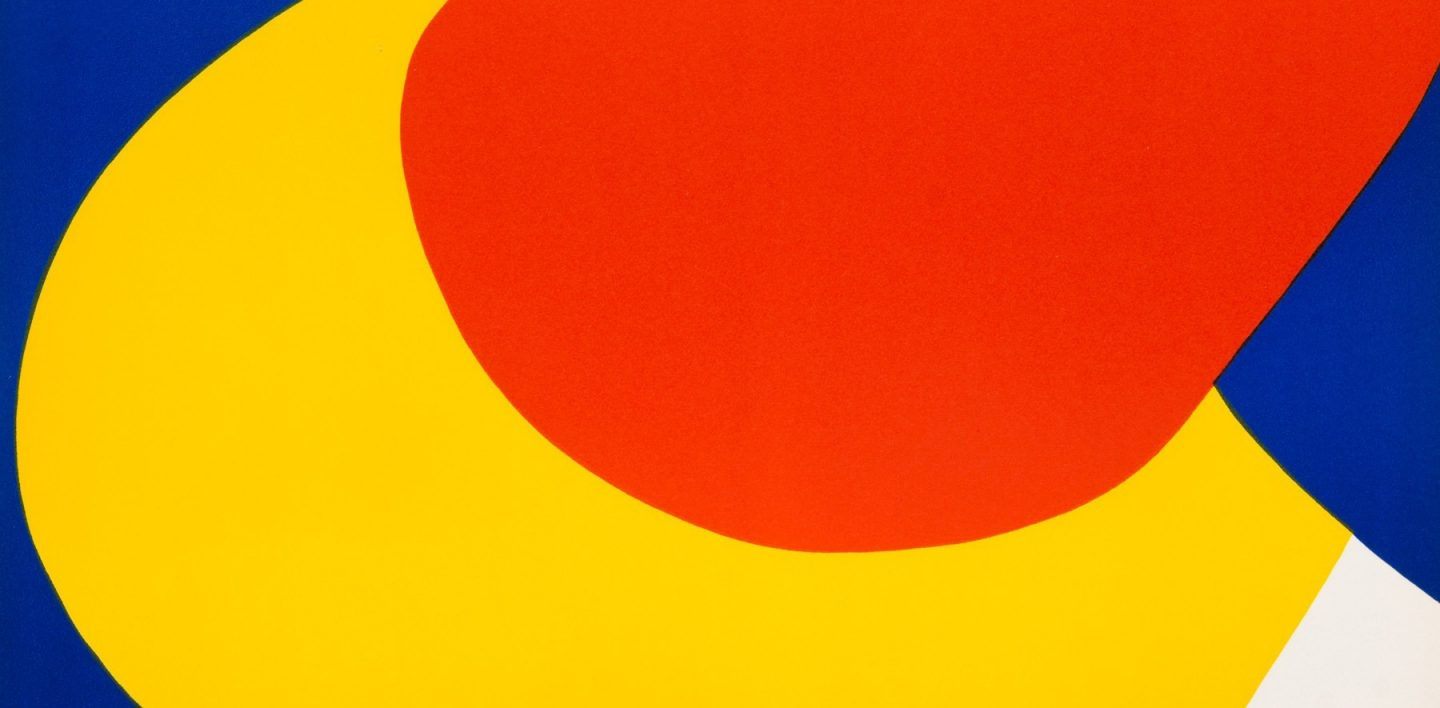
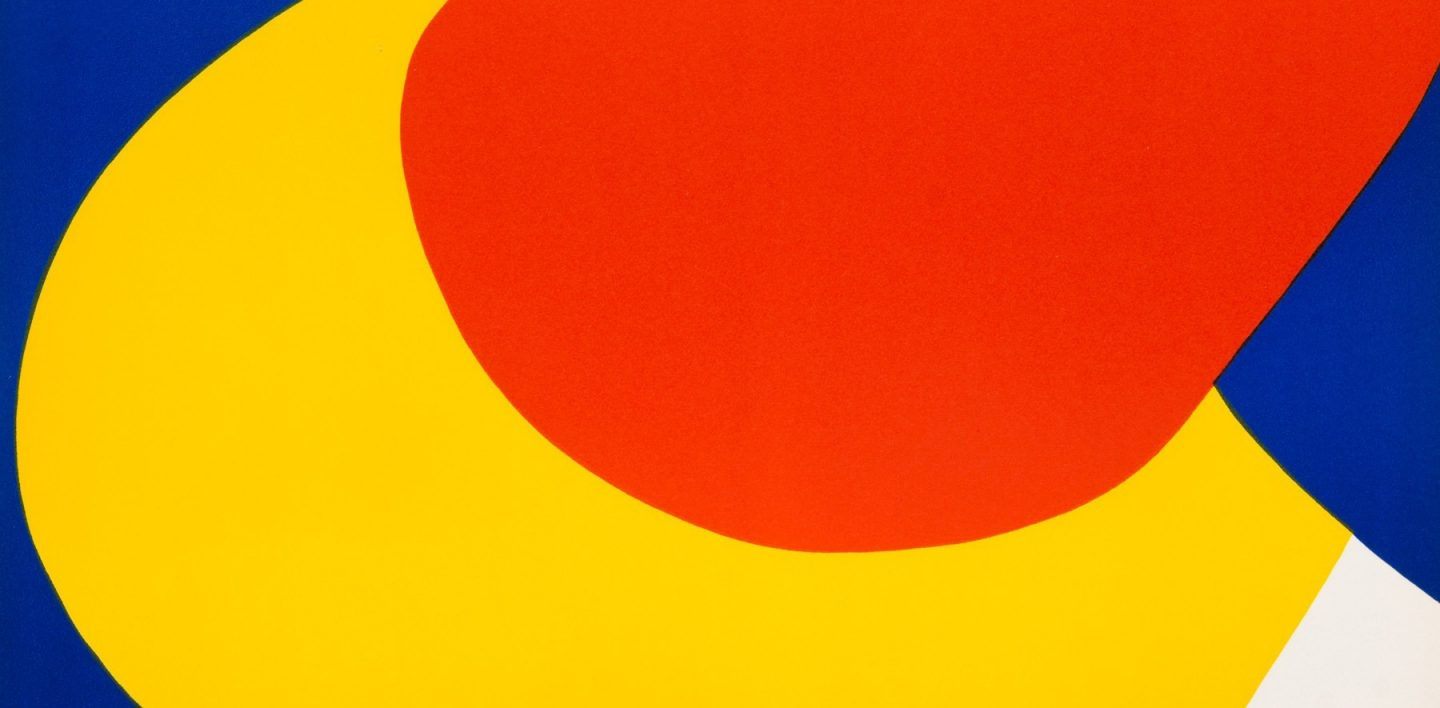
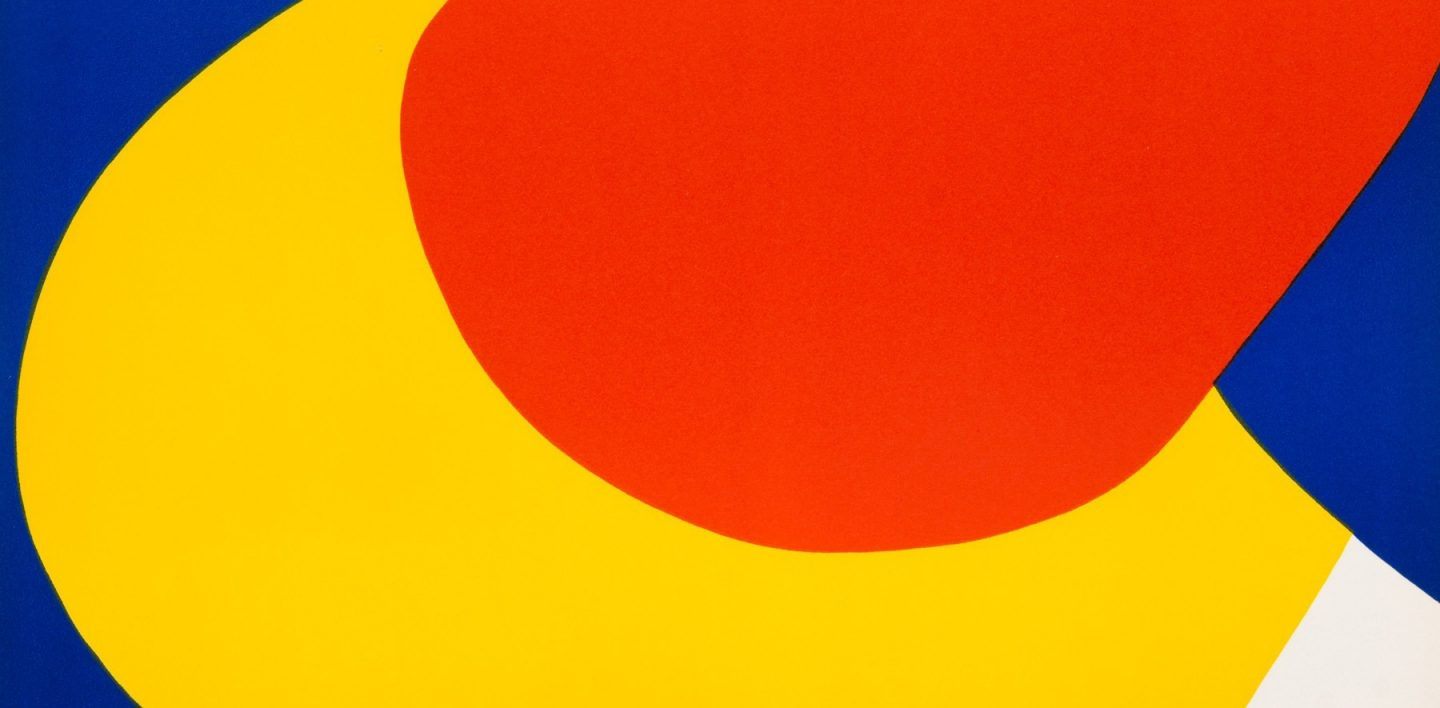
B loccati tra cacciatori di teste a nord e sanguinari guerrieri a sud, gli Hanunoo dell’isola di Mindoro, nelle Filippine, hanno sviluppato una società pacifica ed estremamente particolare, a partire dal sistema di scrittura. Fatto rarissimo, questi indigeni scrivono dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra. Scrivere, per la loro cultura, è prima di tutto una necessità sentimentale: prima imparano a farlo, prima riusciranno a comporre una canzone d’amore per il futuro partner. Ma questo popolo ha un’altra particolarità, ben più nota: hanno un sistema per descrivere i colori unico al mondo. Usando solo quattro termini, che non si riferiscono a colori precisi, riescono a descrivere ogni sfumatura associando a ogni base alcune sensazioni, in uno spettro estremamente sofisticato che va dal “bagnato” al “secco”, dal “forte” al “debole”, dallo “scuro” al “chiaro”. Un sistema che a noi appare complicato ma che loro utilizzano da centinaia di anni.
Gli Hanunoo non sono i soli. A ben guardare, i nomi che noi esseri umani abbiamo dato ai colori rivelano non poche stranezze. Ma bisogna partire da un dato di fatto: non esiste una lingua più precisa delle altre. Ogni popolo ha compiuto delle scelte linguistiche, ossia ha raggruppato i colori che, ci insegna la fisica, sono uno spettro, una continua sfumatura. Negli anni Sessanta, uno dei linguisti più celebri del secolo scorso, André Martinet, ha elaborato la teoria dell’economia linguistica. Secondo lo studioso francese ogni lingua è il risultato di un bilanciamento tra esigenze di completezza comunicativa e sforzo richiesto dalla parola. In altri termini, ogni lingua tende ad avere il numero minimo possibile di parole che garantisca comunque significato alla comunicazione.
La scelta dei nomi dei colori, quindi, va considerata seguendo questi due parametri fissi: nessuna lingua ha un sistema perfetto e ogni lingua risponde a un principio di economia.
Gli antichi erano daltonici?
Il primo dei misteri che circondano la categorizzazione dei colori è abbastanza noto, e porta un nome che tutti conoscono: Omero. L’Iliade e l’Odissea contengono delle stranezze cromatiche rilevanti, alcune volte davvero incomprensibili. Il primo ad accorgersene fu Johann Wolfgang von Goethe nella sua Teoria dei Colori (1808-10). Il grande filosofo, stupito da evidenti incongruenze nei loro testi, definì il senso dei greci per i colori come “incerto”. La tesi fu poi ripresa e sviluppata (e resa celebre) dal classicista e primo ministro britannico William Gladstone. L’autore degli Studi su Omero (1858) notò infatti che in tutta l’epica greca non era mai citato il blu e l’arancione. Omero vedeva il mare “color del vino”, ovvero dello stesso colore con cui descriveva i buoi. Non solo: per il cantore ellenico la pelle umana era dello stesso colore delle piante, i capelli biondi uguali al rosso del fuoco, l’arcobaleno era in realtà viola. Il maestoso cielo dell’Egeo era di ferro o di bronzo, stellato e enorme, ma mai “blu” o “azzurro”.
La scelta dei nomi dei colori segue due parametri fissi: nessuna lingua ha un sistema perfetto e ogni lingua risponde a un principio di economia.
La domanda sorge spontanea: perché Omero non vedeva i colori come li vediamo noi? Per alcuni anni, in effetti, si pensò che fosse daltonico e che, anzi, tutti i greci antichi soffrissero di problemi nella visione del colore. Con un notevole lavoro, il filologo Lazarus Geiger a metà Ottocento analizzò tutti i principali testi antichi. Né la Bibbia ebraica, né il Corano, nemmeno i Veda indiani o le antiche saghe cinesi o islandesi: da nessuna parte gli oggetti che oggi ci appaiono blu erano descritti con quel colore. Stessa cosa, seppure in maniera minore, accadeva con l’arancione. Non era un problema dei singoli greci. Per un momento sembrò plausibile che tutti i popoli antichi condividessero il problema di distinguere “correttamente” i colori, con una particolare avversione verso il blu.
Per quasi tutta la prima metà del Novecento si pensò che la difficoltà a riconoscere quei colori fosse dovuta a una “inferiorità” fisica, a una “minore evoluzione”. Queste tesi sembravano confermate dalla conoscenza che via via si faceva dei popoli remoti del mondo: i nomi dei colori di base sembravano un caos disorganizzato. Gli inglesi avevano 11 colori di base, i russi 12. Molti popoli africani solo 3.
L’ordine dei nomi
A un certo punto successe qualcosa. Nel 1969 due ricercatori americani, pur tra molte critiche, iniziarono a fare un po’ di luce sul mistero dei nomi dei colori. In quell’anno, infatti, l’antropologo Brent Berlin e il linguista Paul Kay pubblicarono un libro, divenuto poi una pietra miliare. In Basic Color Terms: Their Universality and Evolution i due studiosi proposero una teoria semplice e rivoluzionaria: si poteva definire con precisione il tipo di colori considerati a seconda del numero di termini presenti nel vocabolario della lingua in questione. Ovvero, se una lingua aveva solo due termini per descrivere i colori di base, allora sicuramente erano “bianco” e “nero” (o “chiaro” e “scuro”). Se aveva un termine in più, allora sicuramente era “rosso”. Solo negli stadi successivi si incontrava il “giallo”, poi il “verde” e infine il “blu”. Sebbene inizialmente fosse molto criticata (soprattutto perchè il campione su cui si basava era molto stretto, circa 12 persone), la teoria venne confermata, con qualche piccola modifica, anche da uno studio successivo, il “World Color Survey”, condotto su 2600 parlanti 110 di lingue diverse, soprattutto indigene di luoghi abbastanza isolati. Sempre tra numerose critiche metodologiche, la teoria di Kay e Berlin si consolidò negli anni.
Nel 1969 due ricercatori americani proposero una teoria semplice e rivoluzionaria: si poteva definire il tipo di colori considerati in una lingua a seconda del numero di termini presenti nel suo vocabolario.
L’ordine con cui le lingue nominano i colori sembra quindi abbastanza fisso, ma questo, più che risolvere la faccenda, apre nuovi interrogativi. In primo luogo: perché il rosso è sempre al secondo posto? E il blu: come mai il colore del cielo e del mare viene tanto dopo? Infine: com’è possibile che quasi tutte le lingue del mondo sembrano rispecchiare questo ordine?
Il rosso è protagonista
La questione del rosso e del blu è stata spiegata in vari modi, anche se ancora nessuno sembra definitivo. Alcuni ritengono che sia un fattore puramente percettivo e relativamente semplice: il rosso spicca sugli altri colori e ha forti connotazioni emotive. Quando ci arrabbiamo diventiamo rossi, rossi sono i nostri genitali. La componente emotiva di questo colore è talmente forte che è stato dimostrato che i giocatori che indossano divise di colore rosso sono considerati più forti dagli avversari e loro stessi hanno prestazioni migliori.
Tuttavia, è stato anche notato, il rosso in natura non è un colore così prevalente. Il verde e il blu sono molto più presenti (le foglie, l’erba; l’acqua, il cielo), eppure molto più lontani nella scala di Berlin e Kay. Addirittura in molte lingue esiste un’unica parola per descrivere sia il verde che il blu (il cosiddetto grue).
Se anche gli antichi non riuscivano facilmente a fabbricare oggetti blu, questo fatto da solo difficilmente giustifica l’assenza di un termine per quel colore, essendo così diffuso in natura.
Una seconda spiegazione è, invece, di ordine culturale: l’essere umano ha avuto molta più facilità a riprodurre il rosso rispetto ad altri colori. La porpora, un pigmento rosso con cui anticamente si produceva anche il viola e il giallo, si estrae con facilità da un mollusco molto comune nel Mediterraneo ed è nota sin dall’antichità. Il blu, al contrario, è stato un pigmento estremamente più difficile da produrre, soprattutto prima dell’avvento dei colori chimici. Per ottenerlo si dovevano polverizzare pietre preziose come i lapislazzuli. Il blu era talmente costoso da assumere ben presto connotazioni di potere e divinità: è per questo, ad esempio, che la Vergine Maria o Gesù vengono spesso raffigurati con abiti azzurri e non dorati. La parola italiana “celeste/celestiale” è un chiaro esempio di commistione tra il colore blu e i suoi significati culturali.
Ma anche questa teoria non è accettata universalmente. Se è vero che è più facile produrre manufatti rossi piuttosto che blu, è anche vero che basta alzare gli occhi al cielo e vedere l’azzurro. Insomma: se anche gli antichi non riuscivano facilmente a fabbricare oggetti blu, questo fatto da solo difficilmente giustifica l’assenza di un termine per quel colore, essendo così diffuso in natura. Dobbiamo, forse, rivolgerci di nuovo alle scienze cognitive.
Il colore del cielo
Alma Deutscher, nata nel 2005, a soli 6 anni ha composto la sua prima sonata per violino, a 7 anni la sua prima opera intera e a 10 anni ha tenuto un concerto, da lei interamente scritto, come violinista solista. Da molti è considerata una bambina prodigio, spesso paragonata a Mozart. Alma è la figlia di un linguista israeliano, Guy Deutscher. Il padre, quando Alma era ancora nei primi anni di vita, ha provato a capire attraverso di lei qualcosa di più su come percepiamo i colori. In particolare, Deutscher ha evitato accuratamente di fornire alla figlia indicazioni o suggerimenti riguardanti il colore del cielo, lasciando che Alma stessa decidesse in quale categoria inserirlo.
Se non abbiamo parole per descrivere un colore, tendiamo a non distinguerlo dagli altri colori di tonalità simili.
Fino quasi ai 5 anni la bambina, nei disegni, non ha colorato il cielo, definendolo “bianco” o “neutro”. Successivamente – una volta entrata in contatto con una varietà di altri oggetti blu nella sua vita quotidiana, ha passato un periodo di indecisione: il cielo, per lei, era indifferentemente o bianco o blu. Solo con la crescita ha definitivamente fissato il cielo come tonalità di “blu”, quando ormai l’influenza sociale nella categorizzazione di quel colore non poteva più essere ignorata. Già un esperimento del 2004 aveva dimostrato che il percorso di Alma era comune a tutti i bambini, anche appartenenti ad etnie differenti.
Le parole per dirlo
Se non abbiamo parole per descrivere un colore, tendiamo a non distinguerlo dagli altri colori di tonalità simili. Gli Himba, una popolazione della Namibia, non hanno parole per descrivere il blu (cosa che, abbiamo capito, è piuttosto comune), ma hanno molti vocaboli per le sfumature di verde. Jules Davidoff, ricercatore dell’Università di Londra, ha mostrato ad alcuni Himba un cerchio composto da undici quadrati, di cui dieci di colore verde chiaro e uno blu scuro, quindi con una differenza che a noi appare palese. Quasi tutti gli Himba, tuttavia, non riuscivano a notare alcuna differenza tra gli undici quadrati e chi ci riusciva impiegava molto tempo e incappava in molti errori. Nella seconda fase dell’esperimento, Davidoff ha mostrato agli Himba un medesimo cerchio con dieci quadrati di una stessa tonalità di verde e uno con un verde di una tonalità leggermente diversa: per la maggior parte degli occidentali, tutti gli undici quadrati avrebbero avuto la stessa tonalità. Gli Himba invece distinguevano nettamente il quadrato differente.
In sostanza, una possibile spiegazione della teoria di Berlin e Kay può essere che alcuni popoli non creano categorie mentali, con relativi vocaboli, per determinati colori, e dunque non li distinguono nettamente. In altre parole si ricorre ad una nota teoria delle scienze cognitive, chiamata “ipotesi di Sapir-Whorf” o relatività linguistica, secondo cui la lingua influisce direttamente sul modo in cui percepiamo il mondo esterno. Gli Himba vedono benissimo il blu: qualsiasi occhio umano (tranne nel caso di alcune patologie) vede gli stessi colori. È nel momento di processarlo che il cervello inserisce l’informazione nella “scatola” più congeniale: se non esiste la scatola blu, la metterà in quella più affine, il verde.
E Omero e gli antichi greci? Probabilmente non avevano la “scatola blu” per una semplice ragione di economicità: nel loro mondo il blu era onnipresente, tra cielo e mare, un “rumore di fondo” che poteva tranquillamente essere ignorato.