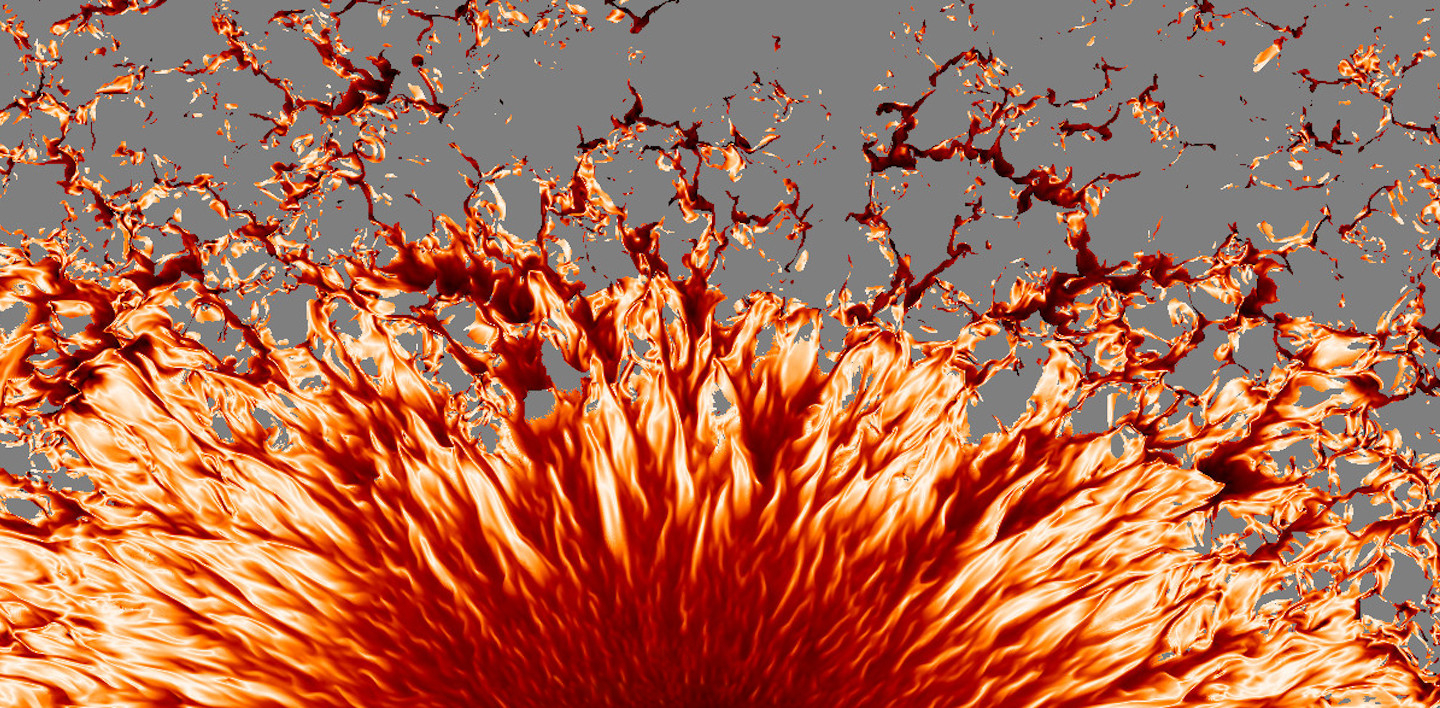
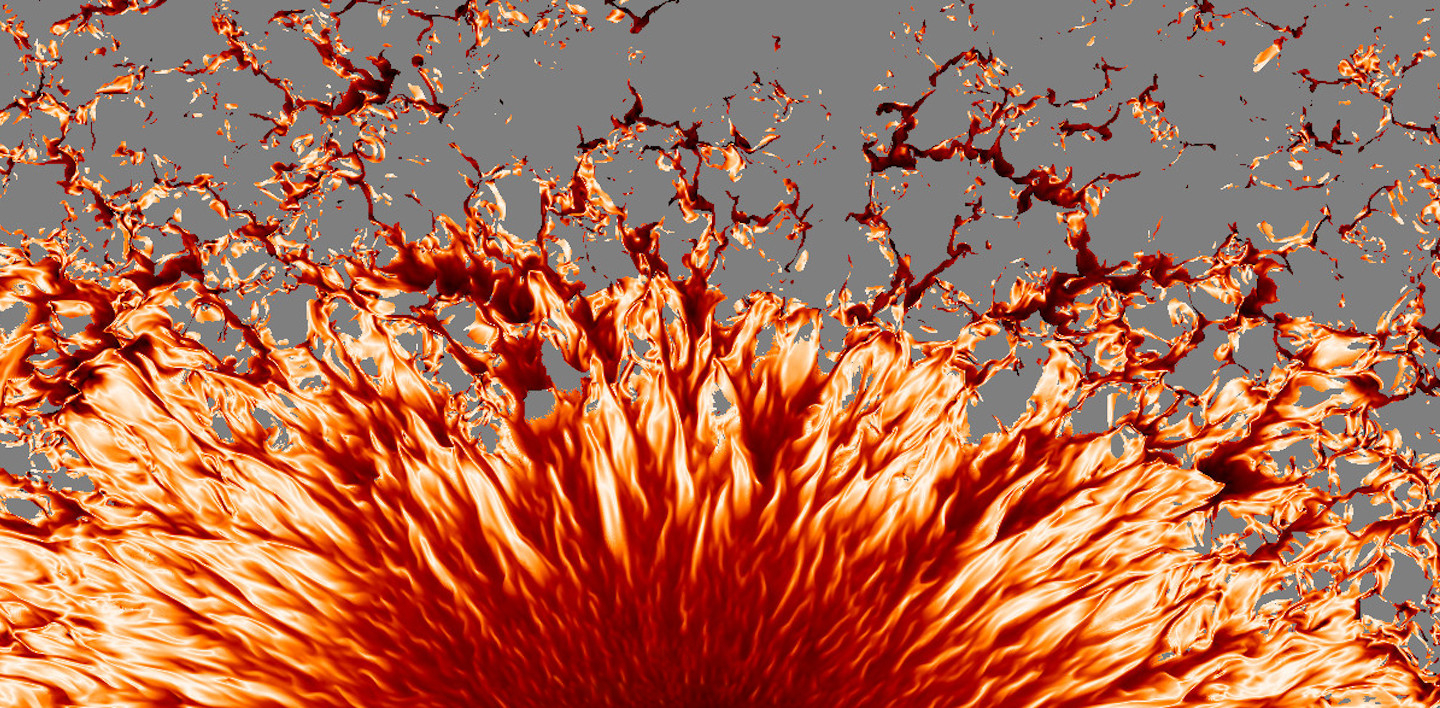
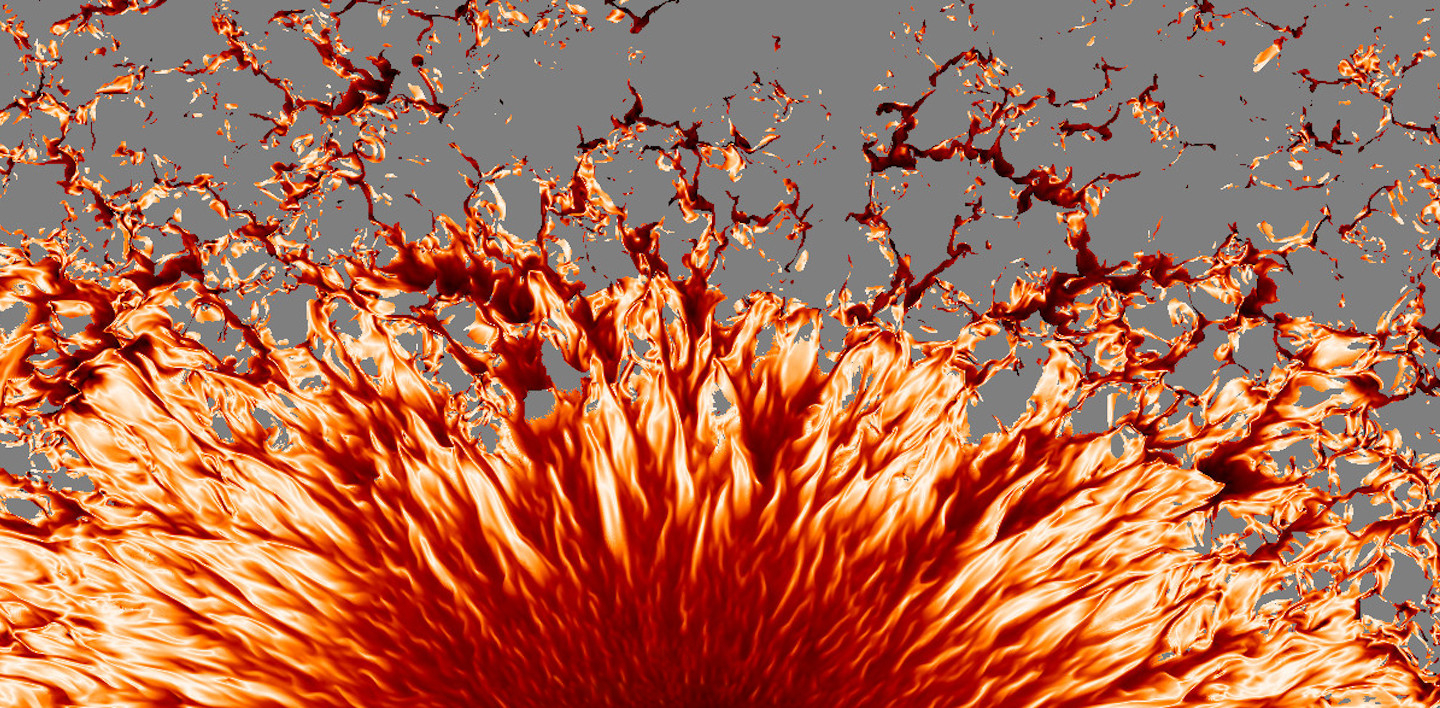
I l prossimo primo novembre è una data tra le più importanti e attese dell’anno per chi si occupa di riscaldamento globale: a Glasgow, prenderà avvio la ventiseiesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio nota con l’acronimo COP26. L’evento, rimandato di un anno per via della pandemia di coronavirus, vedrà i leader della Terra riunirsi tutti allo stesso tavolo, con l’ultimo report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a portata di ciascuno, e all’ordine del giorno l’obiettivo comune di disegnare articolate geometrie politiche per stabilizzare la concentrazione atmosferica di gas a effetto serra. È un rito annuale che si ripete dal 1995, quando ad andare in scena fu la COP numero 1 di Berlino. Ma la convinzione che con la diplomazia climatica si possa far fronte al riscaldamento globale risale ancora più indietro, alla nascita della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (Unfccc) in occasione del Summit della Terra di Rio, nel 1992, e all’istituzione dello stesso IPCC alla World Conference on the Changing Atmosphere del 1988.
Trent’anni e più di conferenze internazionali per il clima appaiono un lasso di tempo sufficiente per trarne un bilancio, e porre magari la più scomoda e diretta tra le domande: quella della diplomazia climatica è una storia di un lento ma incontestabile successo, oppure di un disastroso fallimento?
Il giudizio di Dale Jamieson, professore di filosofia e studi ambientali alla New York University, è tagliente: i tentativi di prevenire il riscaldamento globale con la politica internazionale sono tutti e immancabilmente naufragati, al punto che oggi possiamo soltanto sperare di adattarci al clima che sarà, tentando di attenuarne almeno un po’ gli effetti. Nel suo Il tramonto della ragione. L’uomo e la sfida del clima, scritto prima dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e tradotto quest’anno da Treccani (l’editore di questa rivista), Jamieson ricostruisce la cronistoria dell’insuccesso della diplomazia climatica partendo dagli anni Sessanta, quando l’idea che i gas serra stessero destabilizzando il clima era ormai ampiamente accettata dai climatologi e i movimenti per la difesa dell’ambiente iniziavano a muovere i primi passi. Nel ventennio successivo, però, a imperare furono l’incertezza sul da farsi e la strumentalizzazione politica delle evidenze scientifiche intorno all’origine antropica del riscaldamento globale:
Tra coloro che studiavano il cambiamento climatico stava cominciando ad aprirsi una linea di faglia. Mentre alcuni mettevano in guardia contro un approccio “attendista”, altri invocavano esattamente quello. C’era chi riteneva che la scienza stesse premendo per ulteriori ricerche e finanziamenti, e c’era chi pensava che appoggiasse l’azione politica. Gli economisti tendevano a favorire la ricerca rispetto all’azione; da una prospettiva esclusivamente economica, infatti, ritardare l’azione fino all’ultimo momento possibile avrebbe implicato di agire quando fosse stata risolta la maggior parte delle incertezze, quando i costi della riduzione fossero diminuiti, e quando il rischio di mancare il bersaglio fosse minore.
Qualcosa a livello internazionale si scosse soltanto sul finire degli anni Ottanta, ma la stagione dei primi accordi per il clima venne di fatto sospesa dal conservatorismo neoliberale e negazionista dei due Presidenti repubblicani che si avvicendarono in quegli anni alla guida degli Stati Uniti, Ronald Reagan e George Bush senior. Le loro politiche ambientali, osserva Jamieson, furono straordinariamente coerenti: “fare il meno possibile per il cambiamento climatico e razionalizzare il tutto sia gettando dubbi sulla scienza sia gonfiando le stime dei costi di un’eventuale azione”. Il rifiuto da parte degli Stati Uniti di un intervento precoce e determinato per abbattere da subito le emissioni ebbe un’influenza enorme sui primi trattati per il clima, e culminò nella celebre dichiarazione di Bush al Summit di Rio sulla non negoziabilità dello stile di vita degli americani.
Quella della diplomazia climatica è una storia di un lento ma incontestabile successo, oppure di un disastroso fallimento?
Pochi mesi dopo, Bill Clinton sconfisse Bush alle elezioni e scelse come vicepresidente Al Gore, che aveva appena dato alle stampe il suo primo bestseller ecologista: La terra in bilico. Come ricorda lo stesso Jamieson, “gli ambientalisti si sentirono al tempo stesso sollevati ed euforici”. Eppure, nel corso del suo doppio mandato presidenziale, lo stesso Clinton non fece altro che confermare il disimpegno degli Stati Uniti dalle politiche climatiche internazionali. Si deve soprattutto all’indolenza dei diplomatici americani l’improvvida clausola del pledge and review, ossia degli impegni volontari, non vincolanti e rivedibili che portarono il Protocollo di Kyoto del 1997 a non stabilire alcun obiettivo concreto di riduzione delle emissioni per il Paese più inquinante al mondo (la Cina) e nemmeno a trattenere nell’accordo il secondo maggiore emettitore della lista (gli Stati Uniti). Le COP successive, comprese quelle che ebbero luogo durante la presidenza di George Bush junior e Barack Obama, non furono che un impietoso tentativo di arrivare al summit successivo con un compromesso finalmente vincolante per i firmatari.
Neanche l’accordo di Parigi del 2015, dinnanzi al quale si ferma la ricostruzione storica proposta da Jamieson, ha avuto la forza di scardinare lo scacchiere ossificato della diplomazia climatica. Gli Stati Uniti continuano ancor oggi a recitare la parte del giocatore cinico e baro che possiede da solo il peso sufficiente a far saltare il banco, Cina ed India si trovano nelle vesti dei principali imputati con l’alibi però di non essere tra i responsabili delle emissioni storiche, l’Unione Europea indossa invece la maschera dello scolaretto diligente e convinto d’aver fatto il suo delocalizzando all’estero le attività con maggiori emissioni, e infine il resto del mondo nel ruolo di vittima innocente e sacrificale di un riscaldamento globale causato dal progresso altrui. Sullo sfondo di questa pantomima, una curva delle emissioni di gas serra che ha sempre continuato a crescere nelle ultime tre decadi, dalle 22 gigatonnellate di CO2 rilasciate globalmente nel 1990 alle 38 del 2019, con gracili ed estemporanee battute d’arresto soltanto in corrispondenza del collasso del comunismo nel 1991, della crisi finanziaria nel 2008 e della pandemia di SARS-CoV-2 nel 2020.
Eppure, nel fallimento storico della diplomazia climatica Jamieson rileva qualcosa di più latente e profondo, identificabile con il tramonto del progetto illuminista di porre la scienza e la ragione al centro di un nuovo ordine sociale. “Anziché essere un’umanità che governa razionalmente il mondo e se stessa”, scrive, “siamo alla mercé di mostri che abbiamo creato noi”. Sulla ragion pratica abbiamo fondato le leggi della convivenza civile, del libero mercato e del buon governo, ma allora perché non siamo riusciti a mobilitare la sua forza anche per rispondere efficacemente e tempestivamente al riscaldamento globale? La spiegazione che azzarda Jamieson chiama in causa ostacoli all’azione di natura psicologica (“il cambiamento climatico non è percepito con i sensi, ma deve essere pensato; e noi non siamo bravi a farlo”) ed evoluzionistica (“la nostra dotazione biologica ci rende difficile non tanto risolvere, ma anche solo riconoscere questo tipo di problema”), tuttavia la motivazione forse meno astratta – e dunque più credibile e “politica” – è che il riscaldamento globale rappresenti “il più grande problema di azione collettiva mai affrontato dall’umanità”.
L’azione collettiva è un classico problema da teoria dei giochi: risolverlo è nell’interesse di tutti, ma nessuno è incentivato ad agire senza la garanzia che anche gli altri facciano lo stesso.
Quello dell’azione collettiva è un classico problema da teoria dei giochi: risolverlo è nell’interesse di tutti, ma nessuno è incentivato ad agire senza la garanzia che anche gli altri facciano lo stesso. Di più: comunque scelgano di comportarsi le controparti, a ognuno converrebbe più la defezione che l’impegno comune. Abbattere globalmente le emissioni di gas serra è quindi un problema di azione collettiva che rende necessario tenere a bada i free rider della diplomazia climatica ed evitare che la responsabilità condivisa dell’atmosfera esiti nella più classica tra le tragedie dei beni comuni, poi c’è anche da bilanciare i diversi interessi intergenerazionali che gravitano intorno allo stato del clima. Spiega Jamieson: “ogni generazione è incentivata a non controllare le proprie emissioni giacché trae da esse un beneficio, scaricandone peraltro i costi sulle generazioni successive. Inoltre, poiché ogni generazione (salvo la prima) soffre per le emissioni delle generazioni precedenti, beneficiare delle proprie emissioni nel presente può sembrare una giusta compensazione”. Come se ne esce? Secondo Jamieson i motivatori più potenti di cui disponiamo per risolvere i problemi di azione collettiva sono l’economia e l’etica, ovvero la ragion pratica e la ragion pura, che tuttavia si sono rivelate clamorosamente impreparate di fronte alle grandi questioni pragmatiche e morali poste dalla scoperta del riscaldamento globale.
Salvare il mondo con la ragione
La diplomazia climatica non funziona perché da una parte non riesce a convergere sul fatto che è nell’interesse economico futuro di tutte le parti in causa agire in maniera vigorosa nel presente, dall’altra perché si fonda su una filosofia morale obsoleta, incapace di tutelare gli enti di natura. Prendiamo la motivazione economica a ridurre le emissioni: chi s’impegna a decarbonizzare oggi sostiene un costo in cambio di un beneficio futuro. Qual è il valore attualizzato al presente di quel beneficio? Quanta utilità futura potremmo trarre da ogni dollaro investito in questo momento per mitigare il riscaldamento globale? E conviene decarbonizzare subito oppure tra qualche decennio, quando (forse) avremo tecnologie più efficaci, saremo tutti più ricchi e ridurre le emissioni ci costerà proporzionalmente meno sacrificio? Com’è ovvio non esiste una risposta univoca e insindacabile a questi interrogativi, così finisce tutto per dipendere dal tasso di sconto che si decide di adottare nelle analisi economiche: “se i costi futuri del cambiamento climatico sono fortemente scontati, allora nel presente sono giustificati solo modesti investimenti per la salvaguardia del clima; ma se il tasso di sconto è basso, allora sono giustificate politiche aggressive”.
Chi s’impegna a decarbonizzare oggi sostiene un costo in cambio di un beneficio futuro. Ma qual è il valore attualizzato al presente di quel beneficio? Quanta utilità futura potremmo trarre da ogni dollaro investito in questo momento per mitigare il riscaldamento globale?
Sull’entità del tasso di sconto da adottare per attualizzare i costi futuri del riscaldamento globale si contrappongono due scuole di pensiero: quella “descrittiva” di William Nordhaus e quella “normativa” di Nicholas Stern, entrambi economisti e insigni cattedratici. Stern è più cauto e pessimista, la sua analisi contempla addirittura la possibilità che la razza umana possa anche estinguersi nel giro di qualche secolo. Nordhaus lo accusa di sporcare le sue considerazioni economiche con giudizi di valore sul rischio di un collasso ambientale e sulla disuguaglianza sociale tollerata, quando dovrebbe preoccuparsi del fatto che nella realtà attuale nessuno sembra davvero disposto a farsi carico di una drastica riduzione delle emissioni. I loro tassi di sconto differiscono al tal punto che l’imposta sul carbonio ottimale calcolata da Stern è di un ordine di grandezza maggiore rispetto a quella di Nordhaus. Dalla diatriba tra i due Jamieson conclude che “la teoria economica non ha le risorse per fissare il tasso di sconto in un modo che risulti conveniente su una scala temporale rilevante per il cambiamento climatico”. Detto altrimenti: la razionalità economica non è in grado di stabilire da sola quanto energicamente e tempestivamente agire contro il riscaldamento globale. Il fatto preoccupante è che nemmeno l’etica, la ragion pura, appare sufficientemente reattiva al clima che si scalda.
Che la ragione possa essere fonte di una sensibilità morale lo diceva già Kant: non è necessario scrivere ciò che bene e ciò che è male su monumentali codici di pietra, dal momento che la ragione in sé ci permette di sentire il bene, e dunque di sceglierlo. John Rawls, il filosofo morale più importante del Novecento, avrebbe poi chiamato questa capacità della ragione “senso intuitivo di giustizia”: di fronte a un dilemma morale, la maggior parte degli esseri umani avverte “naturalmente” quel che è più giusto fare. In ecologia il senso intuitivo di giustizia si manifesta per esempio nel disagio misto a dolore che possiamo provare al cospetto di una foresta d’alberi abbattuti, oppure alla vista della sofferenza degli animali macellati in un mattatoio. Il senso morale che si attiva per le emissioni atmosferiche di gas serra, però, non sembra destarsi con altrettanta efficacia e prontezza: gli sconsiderati spostamenti in aereo per una vacanza in una località esotica, per intenderci, non urtano ancora con la nostra sensibilità morale e dunque non li biasimiamo, così come il possesso di una grossa automobile, anziché disturbarci ed essere socialmente stigmatizzato, viene considerato un simbolo di status desiderabile. Neanche la violazione dei protocolli ambientali internazionali ci scandalizza poi così tanto, perché?
Il nostro senso morale non sembra destarsi con efficacia e prontezza davanti alla crisi climatica. Neanche la violazione dei protocolli ambientali internazionali ci scandalizza poi così tanto, perché?
Il senso di giustizia si è evoluto per regolare i rapporti tra gli esseri umani, in società a bassa densità e con accesso a risorse ambientali percepite come illimitate, perciò strumentalizzabili ed escludibili dal dominio della valutazione morale. Le responsabilità etiche si fermano così alle mura della polis, al di fuori delle quali vengono concessi la violenza e la depredazione nei confronti tutto ciò che non è umano, clima compreso. Per Kant è l’umano a essere il fine, con la natura sempre e comunque ridotta a mezzo, mentre nella nota “posizione originaria” di Rawls, dietro al fantomatico velo di ignoranza sulla propria posizione in società, troviamo un manipolo di umani che scelgono per se stessi i principi di libertà e uguaglianza: dei non-umani non c’è la minima traccia, Rawls non ne fa alcuna menzione nella sua teoria liberale della giustizia. Tra gli eticisti del clima c’è chi suggerisce di considerare il riscaldamento globale come violazione dei diritti umani, ma si tratta ancora un a volta di una proposta viziata di un antropocentrismo ormai vetusto, incline a salvaguardare il clima soltanto perché ad esclusivo vantaggio degli umani. Bisognerebbe al contrario estendere la responsabilità morale ai non-umani, conferire al clima e agli ecosistemi diritti protetti per legge, superare la concezione strumentale degli enti di natura e fare dell’ambiente il fine, non il mezzo o lo sfondo, della condotta umana. Volendo dare all’ecologia una definizione condivisibile, questa potrebbe essere una tra le migliori.
A detta di Jamieson, i nostri progressi morali di fronte al clima che si scalda sono troppo lenti perché rimaniamo ancorati a un’etica climatica che lega la responsabilità al danno. Che la “causazione del danno” abbia un ruolo centrale nella concezione della responsabilità morale è un’idea messa in circolazione due secoli fa da John Stuart Mill, ma questo caposaldo dell’etica classica non pare del tutto capace di attagliarsi al riscaldamento globale. Per esempio: la responsabilità dell’emissione è in chi produce il combustibile fossile, in chi lo consuma o in chi ne rende legale l’estrazione e l’utilizzo? La consapevolezza di quanto i propri comportamenti possano inquinare l’atmosfera fa la differenza fra la responsabilità e la colpa, i mezzi a disposizione del singolo individuo tra l’emissione evitabile e quella inevitabile. La morale dovrebbe scattare automaticamente e farci percepire come scorretto quell’atto che comporta un danno ambientale maggiore rispetto a un’alternativa facilmente disponibile. Ma siamo ancora lontani da realtà morale del genere.
A detta di Dale Jamieson, i nostri progressi morali di fronte al clima che si scalda sono troppo lenti perché rimaniamo ancorati a un’etica climatica che lega la responsabilità al danno.
Diceva Rawls che proprio come una teoria scientifica viene abbandonata quando non è più vera, una teoria politica e morale dovrebbe essere modificata quando non è più giusta. Le rivoluzioni nel campo dell’etica e della giustizia non sono poi così rare: “una di queste ultime fu associata all’ascesa del capitalismo”, ricorda Jamiesion. “Quelli che in precedenza erano considerati vizi morali (per esempio, l’egoismo) furono ridefiniti e trasformati in virtù”. Oggi ci troviamo alle soglie di un nuovo rivolgimento: col clima che si scalda ci faremo tutti utilitaristi nel senso originario, più nobile e letterale del termine, che fa coincidere la giustizia con la massimizzazione dell’efficienza sociale e la minimizzazione del dolore, compresa però anche la sofferenza recata all’ambiente e al resto del vivente. Quale autorità si farà depositaria di una giustizia globale di questo tipo, finalmente emancipata dagli interessi specisti e improntata a quelle che lo stesso Jamieson chiama “virtù verdi”? Con ogni probabilità non sarà lo Stato-nazione, l’attore al centro della diplomazia climatica contemporanea, ma qualcosa di più vasto e di là da venire, eppure già nato in quegli stessi tavoli internazionali in cui si decide oggi il futuro del clima.
Un Leviatano per il clima
Lo Stato-nazione è un assetto politico utile a mantenere il pianeta vivibile oppure un ostacolo? Nell’ultimo trentennio la diplomazia climatica ha naturalizzato l’idea che debba essere la cooperazione interstatale a occuparsi del riscaldamento globale, ridotto così a problema di giustizia tra gli Stati, ma come fa notare lo stesso Jamieson “l’atmosfera non si cura dei confini nazionali e una molecola di diossido di carbonio ha sul clima lo stesso effetto ovunque venga emessa”. Ogni tentativo Stato-centrico di risolvere il riscaldamento globale si scontra quindi con la discrepanza tra l’autorità degli attori in gioco e la portata planetaria del problema che si pone. Sarebbe però sbagliato scorgere nel susseguirsi anodino delle COP per il clima la storia di un’ingloriosa disfatta, o almeno questo è ciò che pensano Geoff Mann, professore di economia politica alla Simon Fraser University di Burnaby, in Canada, e Joel Wainwright, geografo della Ohio State University. Nel loro Il nuovo Leviatano. Una filosofia politica del cambiamento climatico (pubblicato anche questo da Treccani, nel 2019), avanzano un giudizio meno critico sulle COP per il clima e in particolare sull’accordo di Parigi, considerato l’atto di nascita di una nuova autorità sovranazionale per la regolazione e il controllo delle emissioni. Un “Leviatano climatico”, appunto, espressione dell’adattamento del politico al clima che si scalda.
Di fronte a questioni planetarie come il riscaldamento globale, i rapporti tra Stati rimangono paralizzati dai principi secolari di sovranità e autonomia nazionale.
Quella del Leviatano è una figura biblica e mitologica che Thomas Hobbes ha introdotto in filosofia politica per designare la sovranità potente e terrifica dello Stato, cui viene conferita autorità dal contratto sociale stipulato dai singoli individui per sfuggire alla vita “solitaria, povera, brutale e corta” degli esseri umani in balia della natura. Il nuovo Leviatano immaginato da Mann e Wainwright è frutto invece del contratto sociale “verde” sottoscritto dagli Stati-nazione per costituire una forma di sovranità mondiale: un Leviatano di secondo grado insomma, capace di “governare un pianeta più caldo e di gestire gli inevitabili cambiamenti economico-politici che ne scaturiranno”. Di fronte a questioni planetarie come il riscaldamento globale, infatti, i rapporti tra Stati rimangono paralizzati dai principi secolari di sovranità e autonomia nazionale, che dalla pace di Westfalia del 1648 in avanti condannano le relazioni interstatali a “una perpetua anarchia caratterizzata da reciproco sospetto, incessanti preparativi per la difesa (guerra) e, nella migliore delle ipotesi, una stabilità basata sull’egemonia”.
L’idea di un regime cosmopolitico che sedi le tensioni e ricomponga gli interessi dei singoli Stati non è nuova: negli anni l’hanno sostenuta per le più diverse ragioni pensatori del calibro Kant, Russell ed Einstein, ma è stata anche osteggiata da chi, come Arendt, ne leggeva l’anticamera del totalitarismo. Secondo Mann e Wainwright le pressioni esercitate dalla crisi climatica spingeranno necessariamente verso la formazione di una governance transnazionale che “assuma il comando, dichiari un’emergenza e porti ordine sulla Terra, il tutto in nome della sopravvivenza umana”. Il nuovo Leviatano godrà di un’autorità tecnica che si pone al di sopra delle parti, le cementa in un’unità compatta ma artificiale, fonde politica e morale. Ricostituirà una sovranità di ordine superiore “capace di coordinare gli investimenti, distribuire le capacità produttive e distruttive e tenere a bada i free rider”, con l’obiettivo di esercitare una governance mondiale in tempi climatici turbolenti. “Quando si tratta di clima, sarà lui a decidere, ed è precisamente a questo fine che viene costituito”. Se sarà giunto il momento di applicare un qualche progetto di geoingegneria, sarà il Leviatano climatico a stabilirlo.
Andiamo incontro a una tecnocrazia centralizzata e pianificatrice? A una coalizione climatica internazionale che demanderà proprio al mercato il compito di occuparsi della gestione del carbonio?
Non è chiaro quale forma politica possa assumere un’entità del genere, se sarà più simile alla “repubblica mondiale” sognata da Kant per la pace perpetua dei popoli o a un totalitarismo regolatore che applicherà in ogni dove provvedimenti aggressivi di sorveglianza e rigore. A giudizio di Mann e Wainwright molto dipenderà dal ruolo che sarà riconosciuto al capitalismo: sarà trattato come un problema oppure come la soluzione ai cambiamenti climatici? Il nuovo Leviatano avrà le sembianze di una tecnocrazia centralizzata e pianificatrice oppure di una coalizione climatica internazionale che demanderà proprio al mercato il compito di occuparsi della gestione del carbonio? Per i due autori l’alternativa ad oggi più realistica, la sola forse davvero possibile, è quella di uno “Stato globale keynesiano” che affronti il riscaldamento globale con una netta intensificazione delle misure già esistenti di regolazione politica del libero mercato – sussidi alle energie rinnovabili, stimoli governativi e green new deal, tassazione del carbonio, mercato dei permessi di emissione, sistemi di compensazione e altre politiche climatiche oggi per la maggiore.
Negli ultimi anni questo “keynesianismo verde planetario” ha incontrato il favore di araldi di spicco tra i quali gli economisti Thomas Piketty, Joseph Stiglitz e il già citato Nicholas Stern, ma anche di intellettuali influenti come Naomi Klein o di profeti discutibili come Jeremy Rifkin. Per Mann e Wainwright la ragione di una tale egemonia va rintracciata nella promessa di un miracolo: “articolare una trasformazione rivoluzionaria senza una rivoluzione”, azzerare le emissioni senza pregiudicare la crescita del capitale. Cambierà tutto, ma in modo incruento, con la sensazione diffusa che non sarà mutato alcunché di rilevante. Anche Jamieson appare concorde nel ritenere il riformismo ambientale di uno Stato globale keynesiano la migliore delle opzioni sul tavolo, quando chiude il suo saggio raccomandando sette priorità politiche, tre principi di governo e un’azione immediata per evitare un cambiamento climatico catastrofico – un programma minimo di misure per salvare la Terra, o almeno per rendere il riscaldamento sostenibile. Congetture? Forse. Ma il prossimo primo novembre, a Glasgow, si passa ancora una volta dalla teoria alla pratica, e toccherà scegliere per davvero una linea etica ed economica comune a tutte le nazioni contro il clima che cambia.