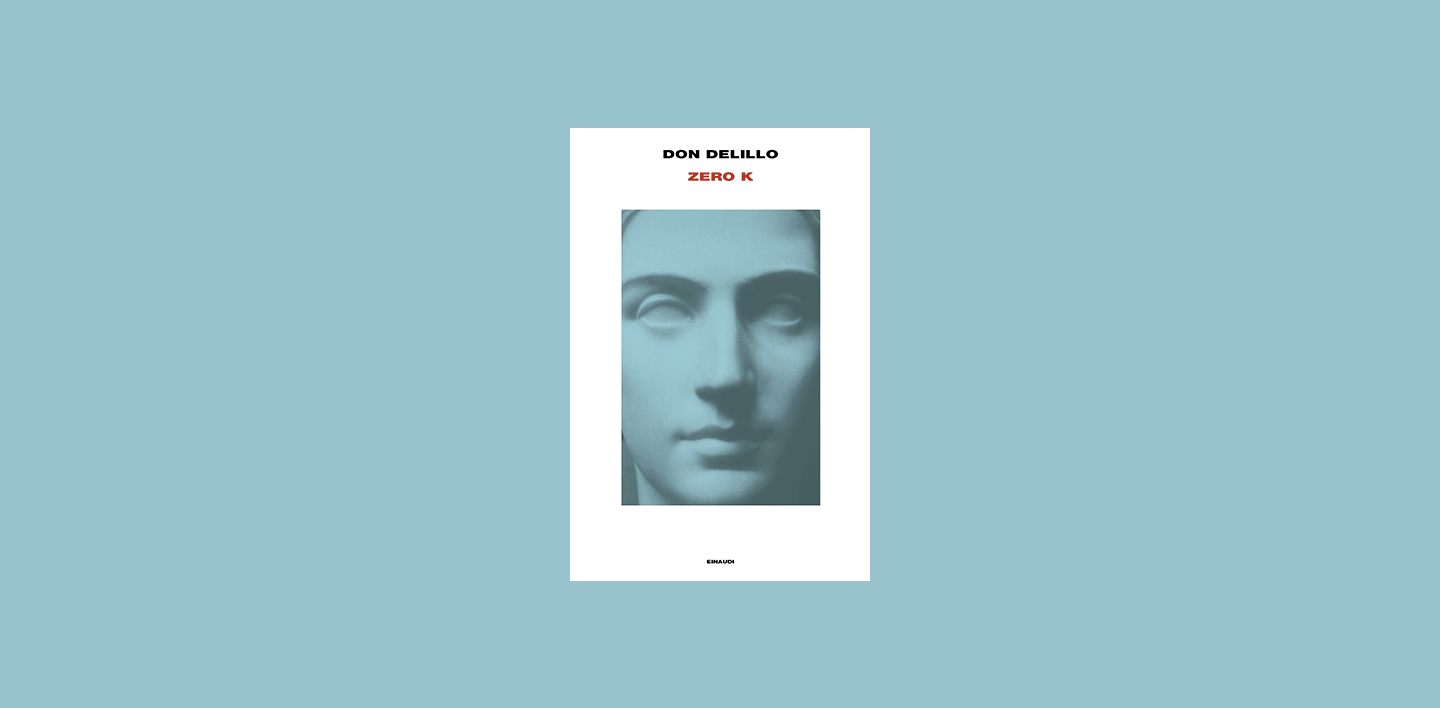Se scrivere è una forma focalizzata di pensiero allora
la forma più concentrata di scrivere probabilmente
termina in una qualche sorta di riflessione intorno al morire.
Q
uella in esergo è una frase di Don DeLillo, da un’intervista concessa a The Paris Review nel 1993, ma potrebbe tranquillamente essere una frase di uno dei suoi personaggi, tanto le voci di questi ultimi col tempo sono diventate indistinguibili da quella asciutta e oracolare del loro autore. Il morire – la paura di, l’inevitabilità di – è la tematica che innerva tutta l’opera di DeLillo: i quarantacinque anni di una carriera che con Zero K giunge al ventiduesimo atto tra romanzi, novelle e testi teatrali. Il dilemma della mortalità proiettava la sua ombra sugli esordi letterari ancora non del tutto a fuoco, sui Grandi Romanzi Americani della maturità dello scrittore – quelli che lo definiscono presso il grande pubblico come Rumore Bianco e Underworld – e infine sulle nebulose di personaggi, situazioni e dialoghi, così rarefatti da assomigliare a visioni, delle sue opere tarde: Cosmopolis, L’uomo che cade, Point Omega e appunto Zero K.
Parlando di visioni, in DeLillo c’è da sempre una tensione profetica. Rumore Bianco raccontava di una nube tossica sfuggita al controllo della tecnica un anno prima di Chernobyl. Riflessioni sulla potenza estetica del terrorismo globale impregnavano già i suoi romanzi, su tutti Mao II, quando un evento come l’11 settembre era ancora inimmaginabile. Cinque anni prima del collasso di Lehman Brothers, infine, Cosmopolis esplorava gli istinti autodistruttivi al cuore di Wall Street.
Oggi, nel nostro presente di annunci sulla concreta possibilità di raggiungere Marte in un decennio, colossi tecnologici uniti in nome dell’intelligenza artificiale, vaghe promesse di sconfiggere per sempre tutte le malattie, DeLillo sceglie di scrivere di un luogo sperduto tra le asperità dell’Asia centrale, dove i finanziamenti di facoltosi donatori incontrano i disegni di un manipolo di scienziati, simili ad artisti concettuali, simili ad asceti. Questo luogo si chiama la Convergenza e nei suoi locali, a metà tra la Cappella Rothko e una base spaziale, uomini nelle fasi terminali delle loro esistenze attendono di farsi criogenizzare, nell’incerta speranza di tornare in vita quando la loro causa di morte – se non la morte tout court – sarà stata debellata dalla nanotecnologia. Se vi sembra fantascienza, forse dovreste conoscere Alcor o Kryorus.
Zero K riluce di una levitas poetica che fa risaltare lo spessore politico delle domande al cuore del romanzo.
Tra i clienti della Convergenza troviamo Artis Martineau, un’archeologa in punto di morte per una malattia neurodegenerativa. Ad accompagnarla verso la sua scommessa sulla scienza sono il compagno Ross, uno dei ricchi finanziatori del progetto, e Jeffrey Lockhart, l’io narrante di Zero K. Figlio unico di Ross, ma da un precedente matrimonio, Jeffrey è un trentaquattrenne che per scelta vive senza beneficiare dei privilegi del padre, in uno stato di permanente crisi di identità, come quasi tutti i narratori creati da DeLillo a cominciare dal David Bell di Americana (1971).
Per gran parte delle sue pagine Zero K segue le deambulazioni di Jeffrey attraverso lo spazio asettico della Convergenza. Lì conosce alcuni degli ideologhi del progetto, con i quali intreccia quel genere di conversazioni del tutto astratte – in realtà quasi dei monologhi a due voci – che sono ormai un marchio di fabbrica dei romanzi dello scrittore italo-americano. Quel genere di dialoghi e situazioni – come per esempio il confronto continuo con l’arte concettuale, un confronto onnipresente da Cosmopolis in poi e che in Zero K assume, tra le altre, la forma di una lunga scena di fronte alla Levitated Mass di Michael Heizer – che hanno fatto parlare di un DeLillo ormai manierista, prosciugato dalla Storia, ridotto a citare continuamente se stesso.
Eppure, questi stessi momenti tardo-delilliani che altrove, in romanzi meno riusciti degli ultimi anni, suonavano inerti e quasi autoparodistici, in Zero K riprendono vigore, grazie a un’ironia che DeLillo non si concedeva con tanta generosità da Cosmopolis (2003).
Se le indagini esistenziali dei suoi ultimi libri scadevano in una seriosità che rasentava il ridicolo, Zero K riluce di una levitas poetica che sottolinea lo spessore politico delle domande al cuore del romanzo. Cosa significa vivere e cosa significa morire. E cosa resterà di entrambi, se davvero la tecnica arrivasse un giorno a sfumarne i confini, quegli stessi confini che per millenni hanno definito il senso più profondo dell’esperienza umana. Arrivato a ottant’anni, DeLillo si è permesso di sondare questi interrogativi con la grazia di chi sa che, per quanto lo riguarda, the joke is on us.