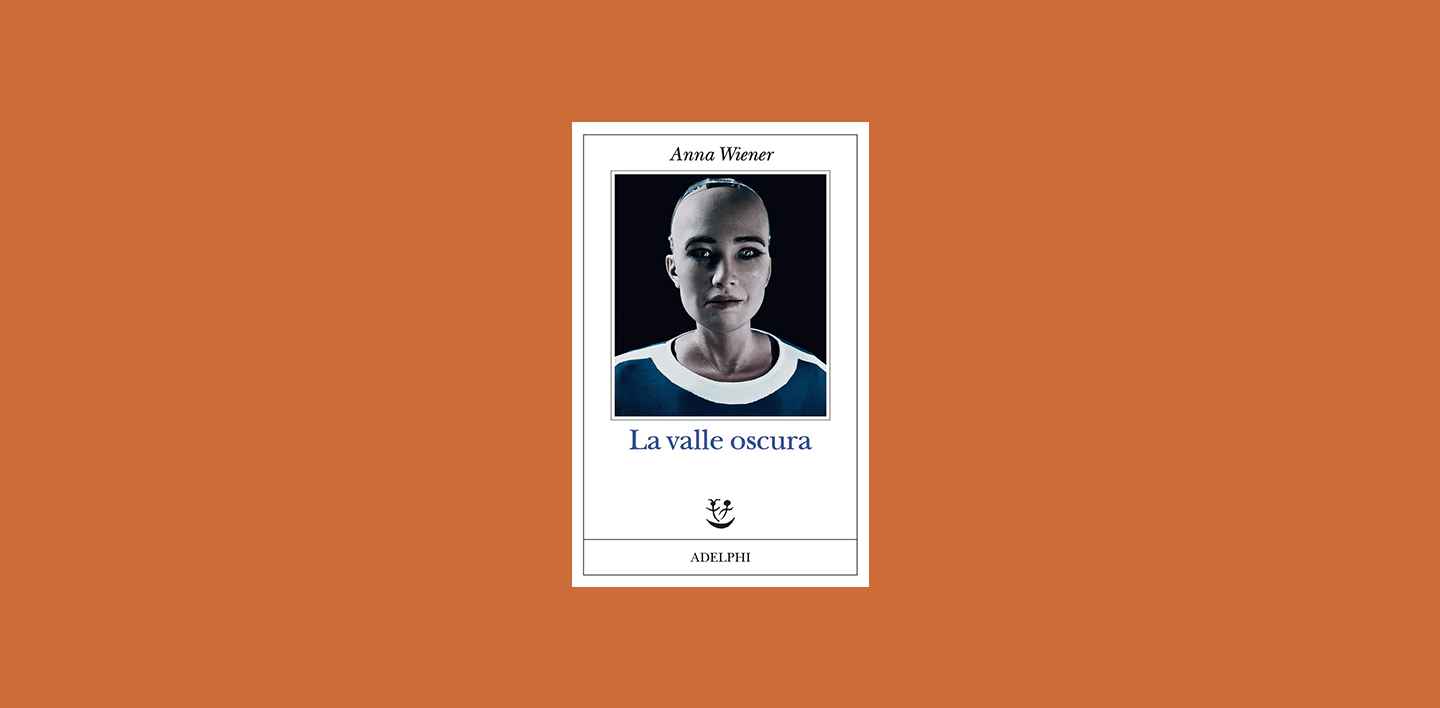
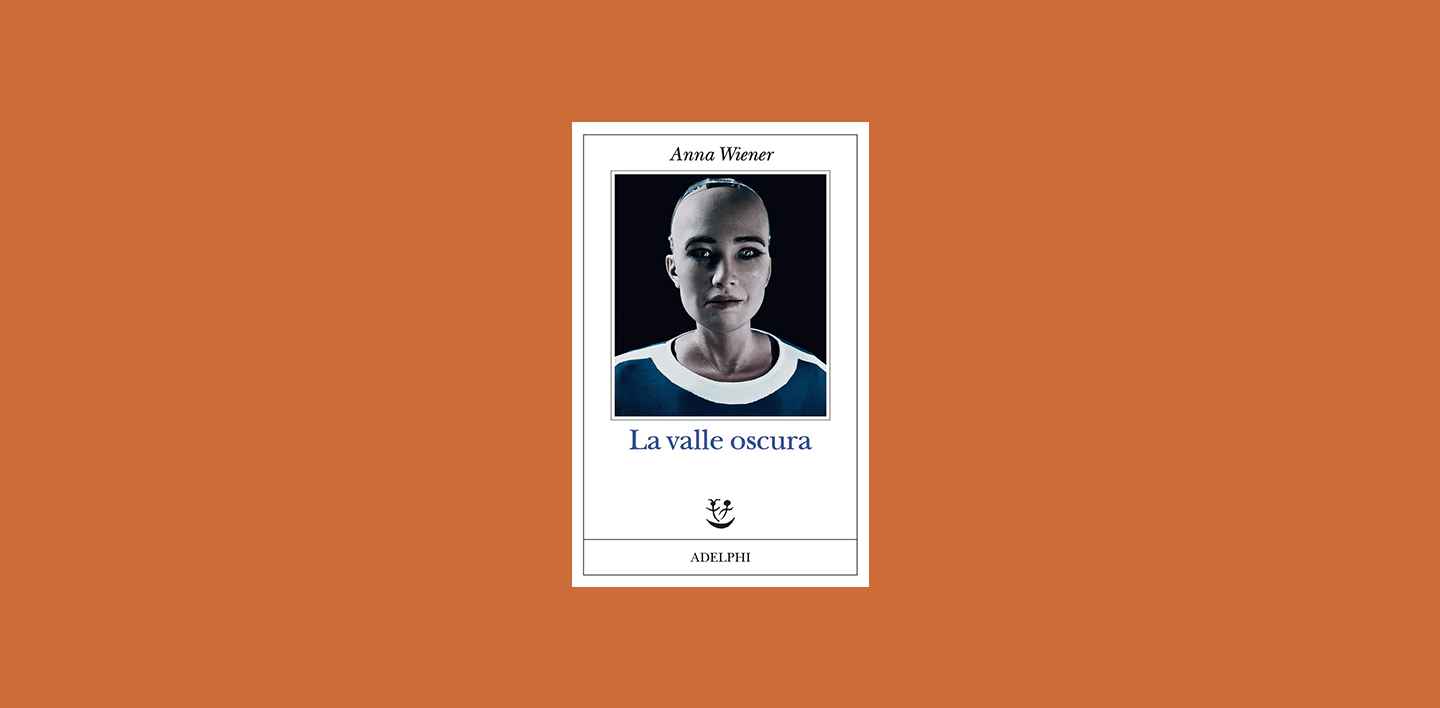
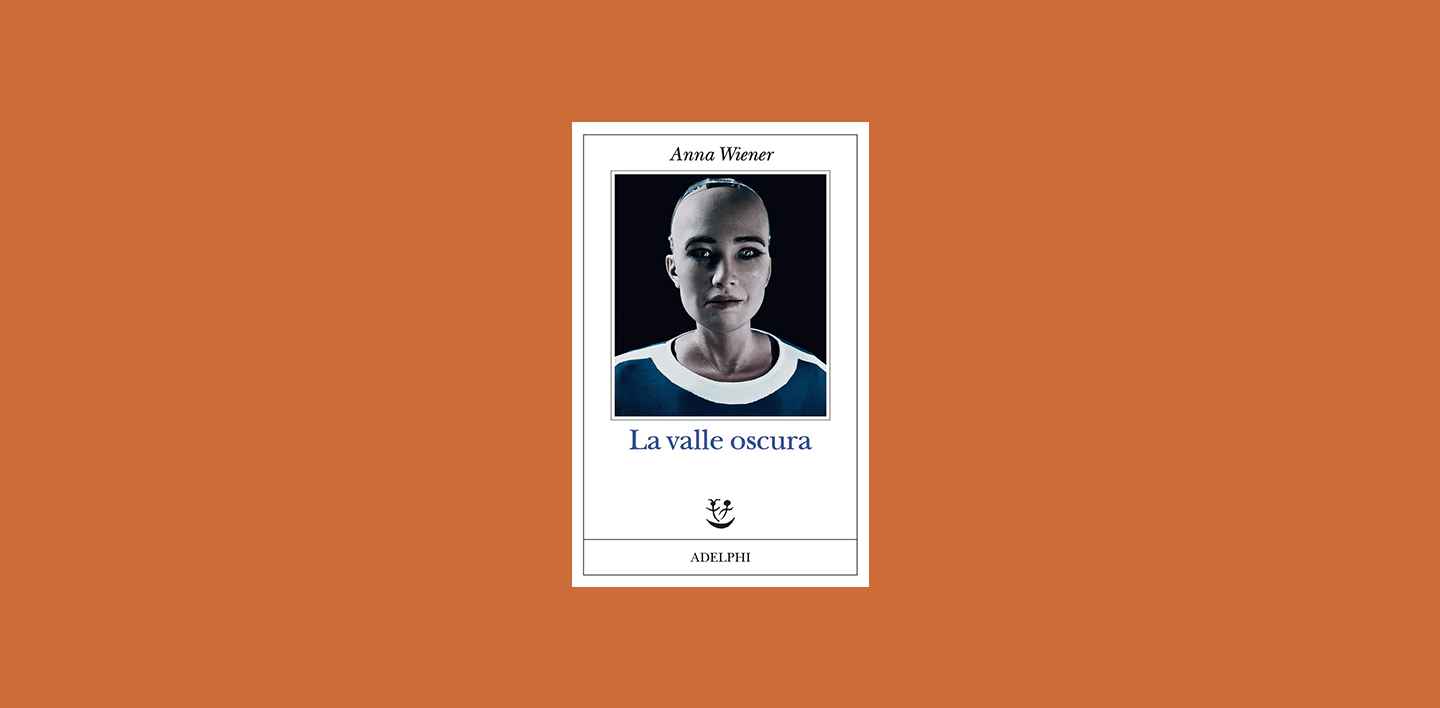
L eggere La valle oscura di Anna Wiener con la pretesa di apprendere qualcosa di nuovo sul lato nascosto delle app è indirizzare male le proprie aspettative: qui degli algoritmi che mimano le forme di vita, senza essere davvero vita, non c’è quasi traccia. L’androide Sophia, fotografato nei laboratori di Hanson Robotics di Hong Kong, che campeggia sulla copertina dell’edizione italiana (Adelphi, traduzione di Milena Zemina Ciccimarra) è un’immagine fuorviante: chi si aspetta di incontrare il nuovo perturbante nella forma di un’interfaccia attraente che seduce per poi uccidere (come nei migliori cliché del genere) resterà deluso. La valle oscura è un libro sul lavoro e la cosiddetta realizzazione personale – e su come per un’intera generazione queste due questioni coincidano, con buona pace di quella che un tempo si chiamava la vita privata.
A chi arriva qui da film come Ex Machina o fomentato dalle questioni di cybersicurezza, vorrei dire: l’uncanny valley non è uno spazio fuori da voi, bensì un luogo dell’anima – è il momento in cui siamo noi ad accogliere la prospettiva macchinica delle cose, a farci interfacce deliziose del mondo, non il contrario; e se non è perturbante questo, chissà cosa lo è. Il libro di Wiener quindi va letto come una mappatura di quel fenomeno che vorrei chiamare il desiderio di partecipare alla cultura integrata, non originario di una specifica area della California del Nord, ma che di sicuro qui ha trovato terreno più che fertile. È una cartografia di una assolata valle oscura: un mondo ideale e progressista, in cui gli abitanti si sottopongono volontariamente a un esperimento collettivo, il cui obiettivo è la totale adesione alla società come unica possibilità di esistenza, come struttura di senso.
La possibilità di effettuare questo carotaggio nel cuore del nuovo mondo, l’eroica e ottimista Silicon Valley, arriva ad Anna Wiener, quando, da redattrice editoriale nata e cresciuta a New York, squattrinata ma non troppo, si trova ad accettare un lavoro in una start up di analisi dati di San Francisco – un ruolo non tecnico nel settore tecnologico che le permette di avere una posizione di vantaggio da cui poi descrive il mondo che le si presenta davanti – e di farlo stipendiata.
C’è chi lo chiama memoir, ma a me la parola reportage pare più calzante: questo è un testo di sociologia spicciola della generazione millennial, in cui Wiener non perde quasi mai la postura da scrittrice (nell’accezione di osservatrice), anche quando racconta le sue relazioni, le nuove abitudini alimentari che acquisisce nel momento in cui scambia New York con San Francisco, in cui si fidanza con un ragazzo del tech o che frequenta Patrick, il CEO ventenne di una start up, uno dei più giovani miliardari che si erano fatti da sé. C’è pochissima autoanalisi e molta interpretazione, insomma.
Dimostrazione di questa postura sono i momenti in cui Wiener si cimenta in saggi di puro party reporting, un’arte sottovalutata in Italia e limitata a siti come Dagospia, ma che invece è fondamentale per capire come ci rappresentiamo quando vogliamo sentirci irresistibili. Qui, mentre flirta con il suo futuro fidanzato, l’imperturbabile e bidimensionale Ian, ci regala una descrizione straordinaria di un gruppetto di persone sedute a terra che si chiede “Qual è la caratteristica ereditata dai tuoi genitori che ti piace di più, o di meno?” e che risponde, senza traccia di ironia, “La resilienza”; se non basta questo per descrivere un’intera generazione, così autoconsapevole, costruttiva e immensamente noiosa, non so cosa serva. Da qui, da questa festa di compleanno a nord di Panhandle, viene nostalgia dei circoli letterari newyorkesi che ora sembrano trasudare sesso e spreco – anche se sappiamo benissimo che poche cose come le feste letterarie di questa epoca hanno lo stesso grado di impaccio e crescente imbarazzo, malgrado le buone intenzioni da cui sono animate.
Anna Wiener però non si limita a descrivere il sottile imbarazzo delle feste post universitarie, quelle in cui tutti si vorrebbero divertire come un tempo, ma in cui ormai si è insinuata una certa autocoscienza – la cosiddetta rispettabilità – che impedisce di farlo davvero; o, per lo meno, non si limita a descrivere solo quell’aspetto: raccontando un weekend di team building aziendale sul lago Tahoe, a cui non può sottrarsi (“se svicolavi, non eri davvero devoto alla causa”), pare suggerire che tutto sommato ai suoi colleghi non spiace l’idea di passare un paio di giorni tutti insieme.
Quella che racconta è una generazione di persone iper istruite che sognano di lavorare per una causa comune e malvedono “il fatto di ammettere che un lavoro nel tech era un’operazione commerciale, e non una nobile missione”, in cui ci si accusa l’un l’altro di “insinuare che l’unica ragione per lavorare è il denaro”. Una generazione attenta all’etica, al Fare la Cosa Giusta, come spiega benissimo Elisa Cuter nel suo saggio Ripartire dal desiderio (minimum fax, 2020), incapace, in un certo senso, di esistere al di fuori dal ruolo lavorativo e quindi sociale che ha illusoriamente creduto di scegliersi, di scindere i due piani, e quindi convinta di poter migliorare il mondo solo partecipando alla società organizzata: “cercavamo di distinguere un atto politico e una visione politica; tra l’elogio di persone violente e l’elogio della violenza; tra commento e intenzione”. Qui persino i ricchi e i ricchissimi sono noiosi, niente affatto eccentrici, sempre zen e attenti a far funzionare le cose.
Al centro de La valle oscura ci sono venti-trentenni entusiasti che discutono “su come salvaguardare i loro cicli mentali, come raggiungere uno stato di ‘lavoro profondo’”, uomini (molti) e donne (poche) che parlano “dello stoicismo come fosse uno stratagemma per semplificarsi la vita. Erano sull’orlo dell’autorealizzazione”. Sono ottimizzati eppure si credono liberi, fissati con la controcultura anni Settanta e la vita comunitaria, ma “la cultura che questi abitanti cercavano e promuovevano era lo stile di vita”.
In questa workplace novel del tardocapitalismo, Wiener distilla in una frase quanto bene si sposino inclusività e potere:
E poi ci divertivamo. Aggiravamo la pedanteria e il protocollo del mondo aziendale […] Ci vestivamo come ci pareva. Ci venivano perdonate le nostre stranezza. Finché eravamo produttivi, potevamo essere noi stessi.
Nonostante la pulizia di questa frase, la sua accuratezza, a leggerlo davvero bene in questo libro non si trova davvero tutta questa critica al sistema, anche nel senso di quel discernimento che Cuter mette in pratica nel saggio prima citato, quando scrive “questa riscrittura della Storia solo apparentemente radicale finisce in realtà per ripeterci che viviamo nel migliore dei mondi possibili, e che l’unico problema di questo mondo dorato era quello di non essere abbastanza inclusivo.”
E succede per un fatto abbastanza semplice: ne La valle oscura si muove, silente, ma neanche troppo, il desiderio di far parte di qualcosa, l’idea che in fondo si possa lavorare e divertirsi insieme, partecipare al sistema integrato prendendone il meglio. Non è divertente scrivere questo libro? Non dà soddisfazione? Non è, anche, utile? Quando le capita di osservare le foto di una festa aziendale – a cui qualcuno commenta “l’altra sera è stata epica!” – Wiener (al netto della difficoltà di leggere questo libro come un memoir) scrive “riconobbi il loro orgoglio, mi immedesimai nel loro senso di realizzazione – era stato un anno infernale, ma ce l’avevano fatta, e avevano vinto. Provai un lieve malessere, simile alla nausea che avvertivo da bambina quando mi sentivo esclusa”. Alla fine l’osservatrice esterna altro non desidera che partecipare all’esperimento: il che include divertirsi alla festa aziendale, per quanto allucinante sia questo proposito una volta che lo si scrive nero su bianco.
Come riconosce anche lei, questo desiderio di dedicarsi al lavoro come fosse un’azione sociale non è proprio solo del settore tech, ma di tutti i settori, incluso quello editoriale, animato dallo stesso spirito di dedizione. E questo libro ne è un prodotto perfetto. Capita raramente di leggere un testo tanto privo di incrinature, di pagine da buttare, di frasi che girano a vuoto: tutto è funzionale, tutto è ottimizzato per la lettura, l’attenzione resta sempre all’interno della pagina, La valle oscura è impossibile da posare – ma non con il veleno dell’ossessione dei libri di Donna Tartt, assomiglia piuttosto a scrollare Facebook, possiamo farlo per ore senza rendercene conto. Le app – devo a Francesco Pacifico l’osservazione che parlare di ‘piattaforme’, ‘applicazioni’, ‘prodotto’ senza mai nominarli direttamente, trasforma queste conversazioni in opere di arte post-internet – vogliono da noi solo una cosa, l’attenzione, e sono disposte a tutto pur di ottenerla: a smussarsi, ad addolcirsi, ad abbandonare il mordente per lisciare la propria superficie. Questo libro adotta gli stessi mezzi: compete per la nostra più totale attenzione, ed eccoci nella valle oscura.