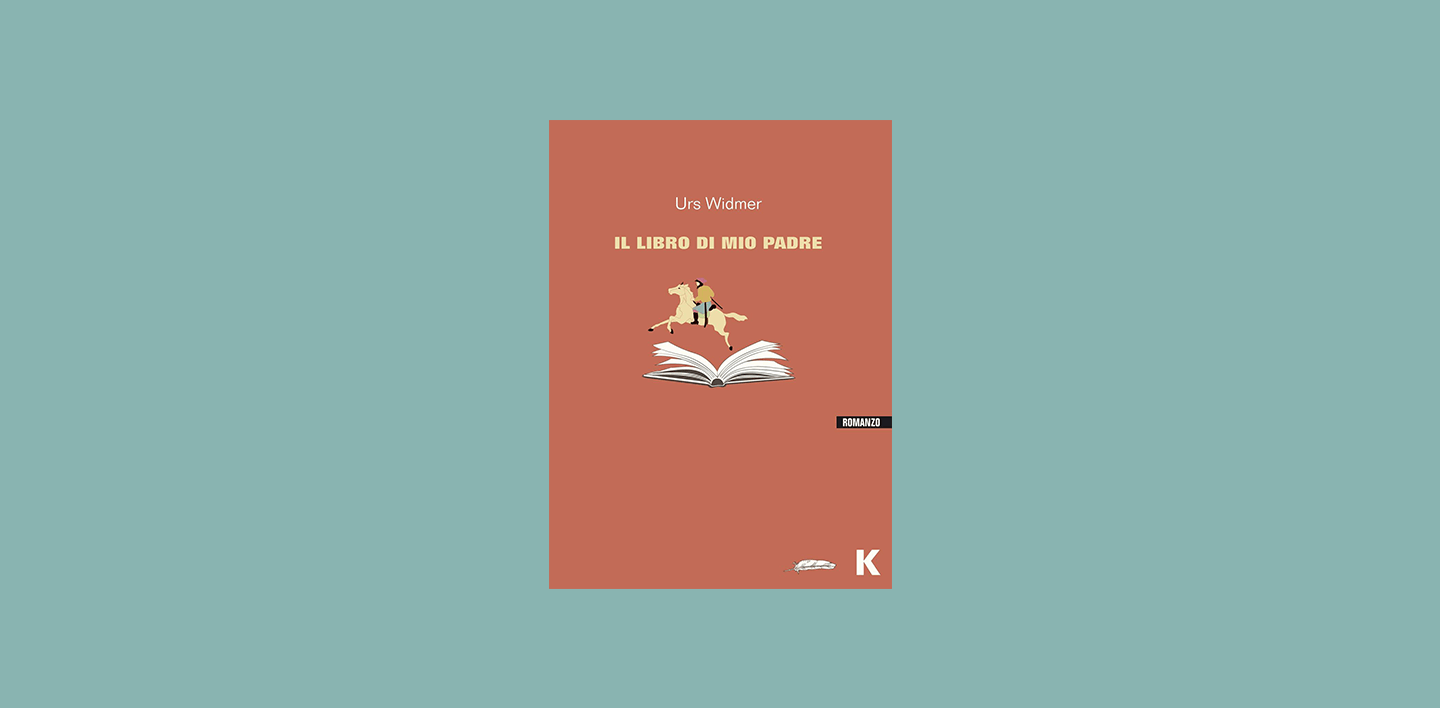I
n uno dei momenti più famosi di 2666, Roberto Bolaño in poche e icastiche parole sintetizza una visione del padre inappuntabile: “Un padre, disse, è una galleria immersa nel buio più profondo in cui camminiamo alla cieca cercando la via d’uscita”. Mentre si legge Il libro di mio padre di Urs Widmer (nella efficace traduzione di Roberta Gado), pubblicato da Keller dopo l’altro mirabile titolo di Widmer dell’anno scorso (Il sifone blu), non si può non assecondare la definizione di Bolaño, che diventa nel racconto dello scrittore svizzero realtà, così come diventa lavoro concreto il tentativo di illuminare un buio profondo. Il libro di mio padre racconta infatti il tentativo compiuto dall’autore di ricostruire la vita del padre Karl Widmer, traduttore e critico letterario, andando in cerca di un’assenza, tentando di riempire un vuoto incolmabile. All’età di dodici anni infatti al padre Karl fu consegnato, così come richiesto dalla tradizione di famiglia, un libro bianco, in cui lui avrebbe dovuto annotare ogni sera, giorno dopo giorno, la sua vita.
“Lo zio tolse un telo nero dall’altare scoprendo un librone altrettanto nero, un autentico in-folio con taglio dorato e segnalibro, sul cui dorso era impresso il nome di Karl. ‘Questo è il libro bianco’ declamò lo zio. ‘Si chiama così perché contiene solo pagine bianche. Ci scriverai ogni giorno fino a quello della tua morte. Tanto, poco, alla tua maniera. Come facciamo noi tutti. Poco, tanto, ciascuno alla sua maniera. Anche chi non ha mai imparato a scrivere, ci fa le sue brave tre croci tutte le sere’”. I dodici anni infatti rappresentano, per la tradizione montana svizzera in cui è nato Karl, il momento di ingresso nel mondo dell’età adulta; Urs Widmer descrive tutto il rito di iniziazione, che passa dall’abbandono nel mezzo del bosco al freddo, al bagno purificatore una volta ritrovata la via di casa, fino al momento topico, quello della consegna della bara:
Il corteo avanzava a passi sempre più piccoli perché si era formata la coda al varco nel muro di bare da oltrepassare per accedere alla locanda. […] Karl smise di respirare e un attimo dopo fu spinto così forte contro le bare impilate che quelle sopra di lui oscillarono. A un palmo da naso, la sua propria bara: la riconobbe subito.
Il libro donato al bambino repentinamente divenuto adulto, che nessuno avrebbe mai letto mentre l’autore era in vita, sarebbe stato aperto solo al momento della sua morte, dai discendenti che ne avrebbero così finalmente scoperto il contenuto. Ma così non accade e il libro, dopo la morte del padre che viene raccontata nelle prime pagine, viene perduto, rendendo così inconoscibile e insondabile il lavoro di una vita, la scrittura privata di un padre, non inaffettuoso, ma sempre distante e inarrivabile, e per cultura e per temperamento. Il figlio però non può sopportare questo ignoto e allora, in uno slancio di profondo amore, ricostruisce il libro scomparso del padre, ne ripercorre la vita, gli amori letterari e gli amori carnali, costruendo un volume che è un omaggio, che è una memoria ma che è soprattutto una storia d’amore, verso quel padre, Karl, sempre così inafferrabile e sempre così ammirato.
Il primo riferimento che viene in mente avvicinandosi al libro di Widmer è Lettera al padre di Franz Kafka. L’accostamento è immediatamente smentito non appena iniziata la lettura: nel libro di Widmer non si incontra una critica verso la figura autoritaria del padre, né la rivendicazione di una libertà mancata nell’infanzia perché troppo forte l’oppressione paterna. Il libro che invece si affaccia sempre più nitidamente durante la lettura, è uno dei più importanti della letteratura italiana contemporanea, Geologia di un padre di Valerio Magrelli. Perché il libro di Widmer, così come quello di Magrelli, è un libro sul padre ovviamente, ma è anche un libro sulla morte, che nasce nel momento della mancanza e della separazione. In un certo momento del suo libro, Magrelli scrive: “mi interessa l’aspetto geologico del passato, anzi, per meglio dire, la geologia della biografia”. Questo porta a caratterizzare la scrittura come un’operazione di scavo profondo in cui lo scrittore, il figlio, si traveste da speleologo o diviene, sempre per usare le parole care a Magrelli, una “carta moschicida del ricordo”.
Lo stesso vale per Il libro di mio padre, dove addirittura il movimento della scrittura tenta acrobazie ancor più complicate, non di ricordare il padre nei suoi movimenti, ma riscriverne la storia, confidando nel potere della parola, della scrittura e della letteratura. Nel momento della perdita Widmer trasforma i suoi ricordi in materiale prezioso per ricostruire una vita, trasformandoli, usando ancora le parole di Magrelli, nel “bandolo canoro di un’infinita matassa di storie”. Jabés, in quella pietra miliare del pensiero filosofico-religioso che è Il libro delle interrogazioni, sembra dare corpo al pensiero di Widmer per quanto riguarda il ruolo della scrittura e della letteratura in rapporto alla memoria: “Finché non saremo scacciati dai nostri vocaboli, nulla dovremo temere; finché le nostre parole conserveranno i loro suoni, noi avremo una voce; finché le nostre parole conserveranno il loro senso, noi avremo un’anima”. Questa è la parola di Widmer: riscrivere per far rivivere.
Il libro di Widmer non è però solo incentrato sul padre, ma è anche intento a ricostruire un’intera epoca. Ambientato soprattutto in Svizzera, ma con una importante parentesi a Parigi, il racconto del figlio attraversa, così come la vita del padre, i momenti più complessi del Novecento. Nato nel 1903, Walter Widmer fu, oltre che critico e traduttore (Balzac, Stendhal, Gide), anche insegnante in un liceo, vero amante della letteratura a cui ha dedicato un’intera vita, come ricorda il figlio quando rivede il padre, in casa, alla sua scrivania, seduto sulla stessa sedia, talmente immobile che “era come se il padre e la sedia fossero venuti al mondo insieme”. Non solo però amante della letteratura, ma anche della pittura e dell’arte in genere; il libro di Widmer custodisce infatti anche un’altra ricchezza, quella di consegnare al lettore una formidabile galleria di ritratti di personaggi appartenenti al mondo dell’arte, pittori, scultori, architetti e collezionisti come, tra gli altri, un allievo di Kirchner, gli scrittori del Gruppo 33 e addirittura Heinrich Boll. Da questo punto di vista il libro di Widmer si può leggere insieme alla Autobiografia di tutti di Gertrude Stein, integrando all’affresco della scrittrice americana sul mondo culturale francese la vivace realtà culturale svizzera.
Eppure l’esistenza del padre di Widmer si incrocia anche con il buio della seconda guerra mondiale, scoperta quasi per caso, (“Il primo settembre 1939 mio padre e Clara sentirono la voce di Hitler tuonare dalla loro radio Marconi”) e nella quale, nonostante fosse dispensato dalla leva, sarà chiamato per combattere in una stretta gola di rocce, detta Kessiloch, dove i soldati, per la noia, scrivono sulle pietre rendendole “più decorate delle grotte di Lascaux”. Ma la guerra non si allinea in alcun modo allo spirito del padre e diventa allora, anche a causa di un’attesa infinita e stancante di un attacco tedesco che non arriverà mai, il momento per riflettere sulla sua vita, sulla moglie Clara (che raggiungerà una notte fuggendo in bici dall’accampamento e riuscendo a tornare poco prima dell’appello mattutino), sul piccolo figlio e sulle opere da tradurre. Al ritorno dalla notte d’amore con Clara, Karl prende carta e penna e scrive una lettera lunghissima, commovente per la sua sincerità: in una scrittura che si avvicina quasi al flusso di coscienza, il soldato Widmer confronta la sua vita con quella di Denis Diderot, cogliendo o creando somiglianze attraverso il simile rapporto con la letteratura, considerata come l’occupazione principe a cui tutto rischia di togliere del tempo.
La guerra poi trascinerà con sé la povertà e le difficoltà di ritrovare posto tra gli uomini, rintracciabile in questo libro nei ritratti umani, crudi e fedeli, degli esiliati e rifugiati tedeschi in Svizzera, ridotti ad un’esistenza assai modesta ma impossibilitati a tornare nella Germania post-bellica. Karl Widmer, appena tornato a casa dal fronte si getta subito sulla macchina da scrivere, mettendo sulla pagina le traduzioni mandate a mente durante la guerra:
dunque fissò sulla carta i sospiri amorosi di Bérénice di Racine, la chiusa del Candide, tutto l’inizio della Chanson de Roland, sebbene non gli piacesse granché e le preferisse l’Histoire de Tristan et Iseut, che però non sapeva a memoria. Anche per l’incipit della Saison en enfer di Rimbaud aveva trovato parole proprie scalpitando avanti e indietro sulle traversine dei binari.
Perché la guerra è finita, la violenza si allontana e adesso, come sembrano far presagire gli scrittori e gli artisti che frequentano casa Widmer, “adesso bisognava cambiare tutto”.
Il libro di Widmer è infine, scrigno inesauribile, anche un libro sulla scrittura. Tra le sue agili e snelle linee, che non nascondono mai un’eleganza da vero scrittore mitteleuropeo, Widmer rivela una visione sul compito della scrittura e dello scrittore. Cosa è infatti il libro dalle pagine bianche e con elegante rilegatura, se non il simbolo di un bianco da riempire, di pagine che necessitano di essere scritte, una via di iniziazione al magistero dello scrittura che deve per forza partire da un vuoto? L’assenza diviene presenza e la perdita del libro motore di tutto: “tutti i canti si scrivono nero su bianco e bianco su nero” è scritto nel Talmud.