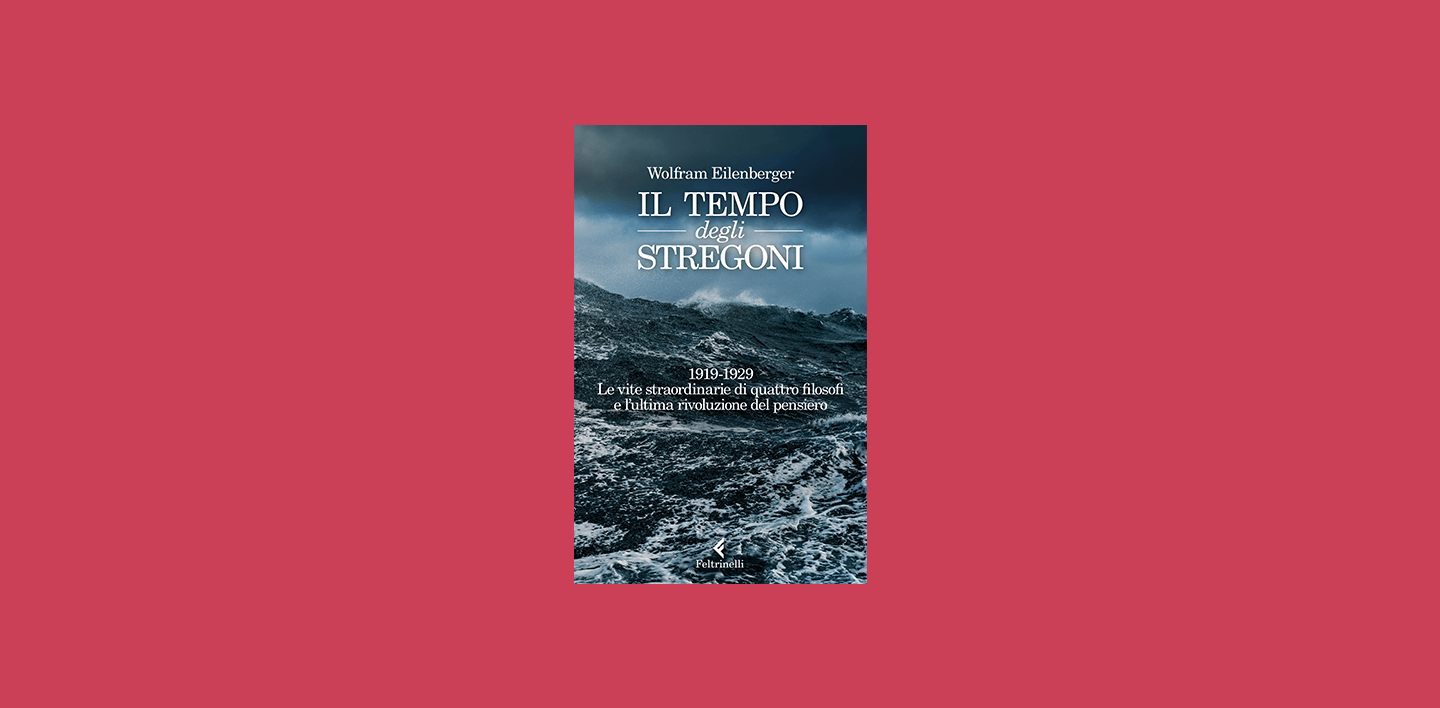
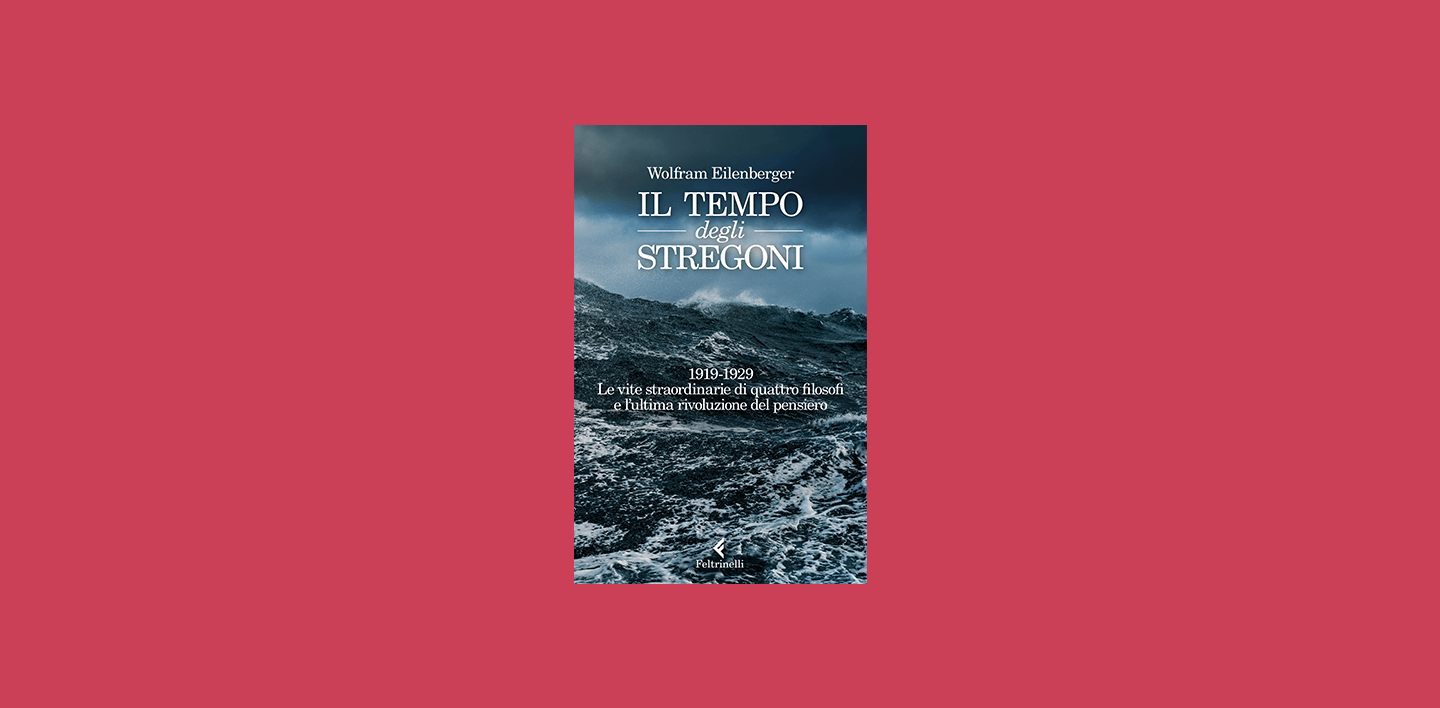
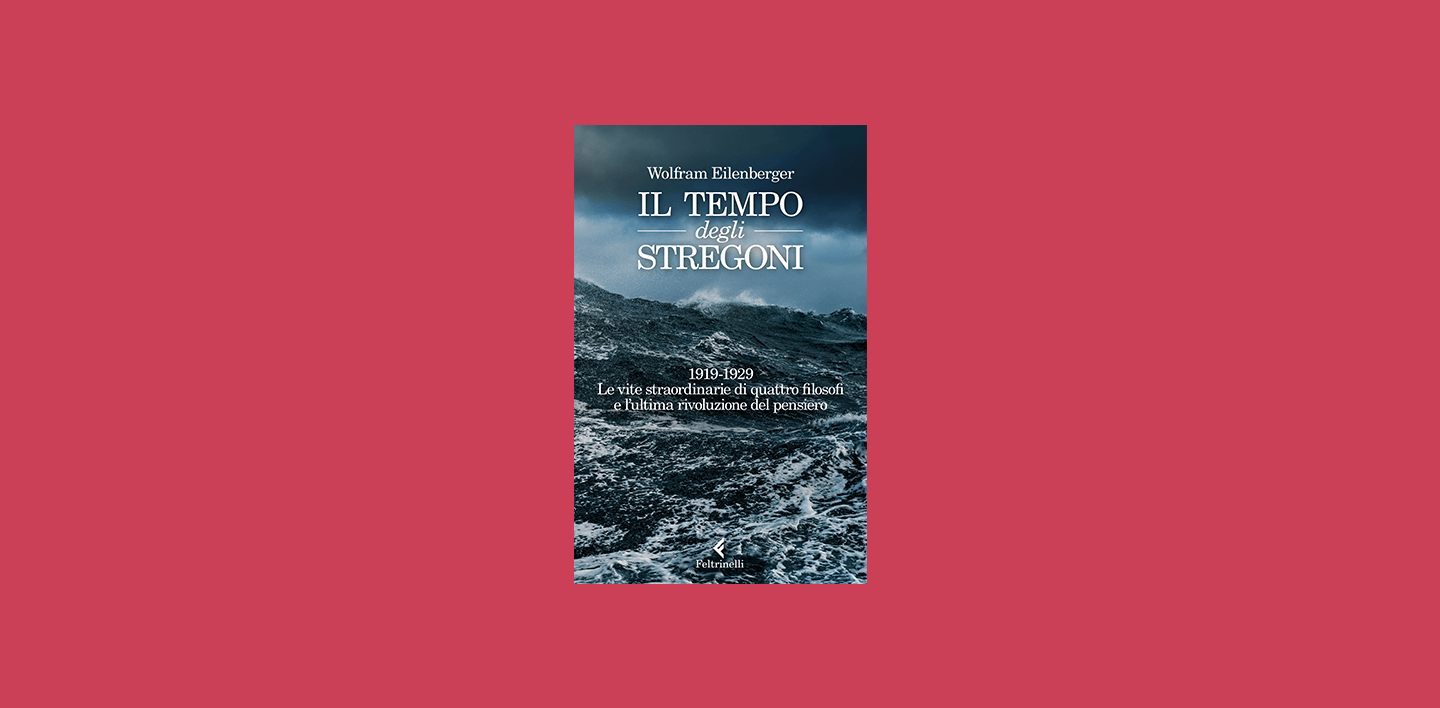
“C he cos’è l’uomo?”: è questa la domanda che si pongono Ernst Cassirer e Martin Heidegger durante la disputa filosofica che si tiene l’ultimo giorno dei seminari di Davos, nel marzo del 1929 sulle Alpi svizzere, nello stesso luogo dove Thomas Mann aveva ambientato solo cinque anni prima La montagna incantata. Il loro incontro è un evento: Cassirer, neokantiano, di acclamata fama, sereno e tranquillo, il cui ragionamento rigoroso procede senza accelerazioni o strappi, rappresenta la rigida istituzione accademica. Heidegger invece è la novità, è un giovane rampante che auspica un ritorno alle origini, alla morte della metafisica, a un modo tutto nuovo di fare filosofia. Solo qualche anno prima ha dato alle stampe il suo lavoro più importante, Essere e Tempo, in cui si tenta di mettere a nudo la domanda sul senso dell’essere. Gli occhi della platea (tra cui siedono Carnap, Lévinas e Ritter) sono tutti per lui. Heidegger ne esce vincitore: da quel momento niente nella discussione filosofica occidentale sarà più lo stesso perché
la posta in gioco, a Davos, è una decisione tra due modi inconciliabili di intendere l’evoluzione dell’umanità moderna, due visioni la cui forza di attrazione continua ad agire, in direzioni opposte, negli strati profondi della nostra cultura.
Nello stesso anno si presenta davanti alla commissione dell’esame dottorale di Cambridge un uomo dagli occhi accesi, vestito con una camicia senza colletto e pantaloni di flanella grigia. È Ludwig Wittgenstein che fa il suo ritorno in Inghilterra come un dio scacciato che torna al suo altare, dopo aver scritto un’opera leggendaria in un campo di prigionia italiano, aver fatto il maestro di scuola elementare in uno sperduto villaggio austriaco e aver consapevolmente rinunciato alla cospicua fortuna di famiglia. Wittgenstein è già una leggenda: in molti temono la sua incomprensibilità. Dopotutto, l’ultimo enunciato del suo Tractatus racchiude tutta la sua filosofia fino a quel momento: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”.
C’è un altro uomo poi, a Berlino, che ha passato gli ultimi dieci anni a cercare di trovare un posto fisso all’università, un’occupazione che gli permettesse di vivere degnamente mentre passava il tempo ad amare e a soffrire per Asja Lacis e a scrivere di tutto, note, articoli, recensioni, perché “chi è in grado di scrivere può scrivere di qualsiasi cosa”. Walter Benjamin.
Comincia così, dalla fine, il racconto di Wolfram Eilenberger sui dieci anni che sconvolsero il pensiero filosofico occidentale. Il tempo degli stregoni (traduzione di Flavio Cuniberto) racconta questo periodo di fascino assoluto intrecciando le biografie dei suoi quattro protagonisti principali. Eilenberger, giovane filosofo e professore tedesco (classe 1972), ha il merito di raccontare il dipanarsi della strutturazione della filosofia occidentale intrecciando le quattro vite dei filosofi come se fossero trame dello stesso tessuto senza rinunciare a tirare i fili più nascosti del loro pensiero filosofico. I riflettori si accendono uno per volta a illuminare gli studiosi nei momenti cardine della loro esistenza. Heidegger, che nella sua Hüitte nella selva nera ragiona sull’esserci e sull’angoscia; Cassirer, mentre pensa che “lo spirito umano” raggiunga “la sua vera e perfetta interiorità solo nel suo manifestarsi”; Wittgenstein che, mentre si ritira dal mondo, consapevole della portata delle sue scoperte linguistiche, sale sulla stessa scala che aveva descritto nel Tractatus: “Le mie proposizioni illuminano così: Colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è asceso per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettare la scala, dopo esservi salito)”, e infine Benjamin che, scappato dalla casa di sua padre per tentare di affrancarsi dalla sua famiglia di origine fa dello strumento della traduzione un modo per entrare in contatto con l’opera d’arte.
Le biografie mostrano il lato umano, a volte spiacevole e sofferente, altre volte divertente, di quegli uomini, cercando di mostrare come la filosofia di ognuno sia inseparabile dal modo che hanno di vivere la vita. È una tesi difficile da sostenere, ma piuttosto avvincente, che l’autore di questo ibrido, a metà tra la divulgazione e il saggio storico-filosofico, mette in campo scrivendo un’opera di livello assoluto, in cui l’aneddotica è al servizio della profondità del racconto e dove un consistente apparato di note e di citazioni rende coerente la voce dell’autore con il lato più umano dei quattro filosofi.
Ma che cos’è, allora, che accomuna e tiene insieme la narrazione di quattro personalità così differenti fra loro? Eilenberger rintraccia il punto di partenza comune a ognuno nel linguaggio:
Un filosofo, infatti, che nel 1919 non abbia nulla da dire sul ruolo del linguaggio nella sfera della conoscenza e della vita pratica – Cassirer ne è convinto – non ha nulla da dire in generale. Se c’è una convinzione comune a Wittgenstein, Heidegger, Benjamin e Cassirer in questa fase (e non solo in questa) del loro pensiero, una convinzione assoluta, senza riserve, è che la forma di vita propria dell’essere umano è legata al linguaggio. Il linguaggio non è, in questo senso, una forma simbolica tra le altre, ma è fra tutte la più importante ed elementare. È il terreno su cui matura la comprensione di noi stessi e del mondo.
Per ognuno di loro questo punto di partenza si tradurrà poi in lavori e opinioni diverse sul futuro e sullo scopo della filosofia. Heidegger cercherà in essa un rapporto originario col mondo, Wittgenstein l’interstizio che deve esistere tra dire e mostrare, Cassirer il significato dei simboli come vera struttura del mondo; Benjamin finirà dilaniato tra lo studio della filosofia e l’angoscia delle prospettive rivoluzionarie. Eilenberger mostra come intorno ai drammi esistenziali dei quattro ci sia anche tutto un mondo all’interno di cui si muovono personaggi di assoluto spessore come Warburg, Russell, Jaspers, Arendt e molti altri, in una Europa scossa dalla fine della prima guerra mondiale che in modo fallimentare cerca faticosamente di costituirsi un’identità propria.
Quello che viene mostrato è un periodo in cui il pensiero europeo poteva produrre vette di complessità e di significato tremende, senza rinunciare a spiegare in profondità gli ardui passaggi del loro pensiero filosofico. È difficile non mettere a confronto quegli anni con i nostri, e non accorgersi di come i pensieri di quei quattro “stregoni”, che come un nervo scoperto mettono in bella mostra i limiti della nostra stessa comprensione del mondo, siano ancora vivi nell’Occidente attuale. Loro e la loro pratica.
Poco prima di partire per le ferie, un assistente gli chiede con quale titolo dovrà essere annunciato il suo corso nel calendario dell’università. Wittgenstein riflette in silenzio. E alla fine risponde: “Filosofia. Che altro?”