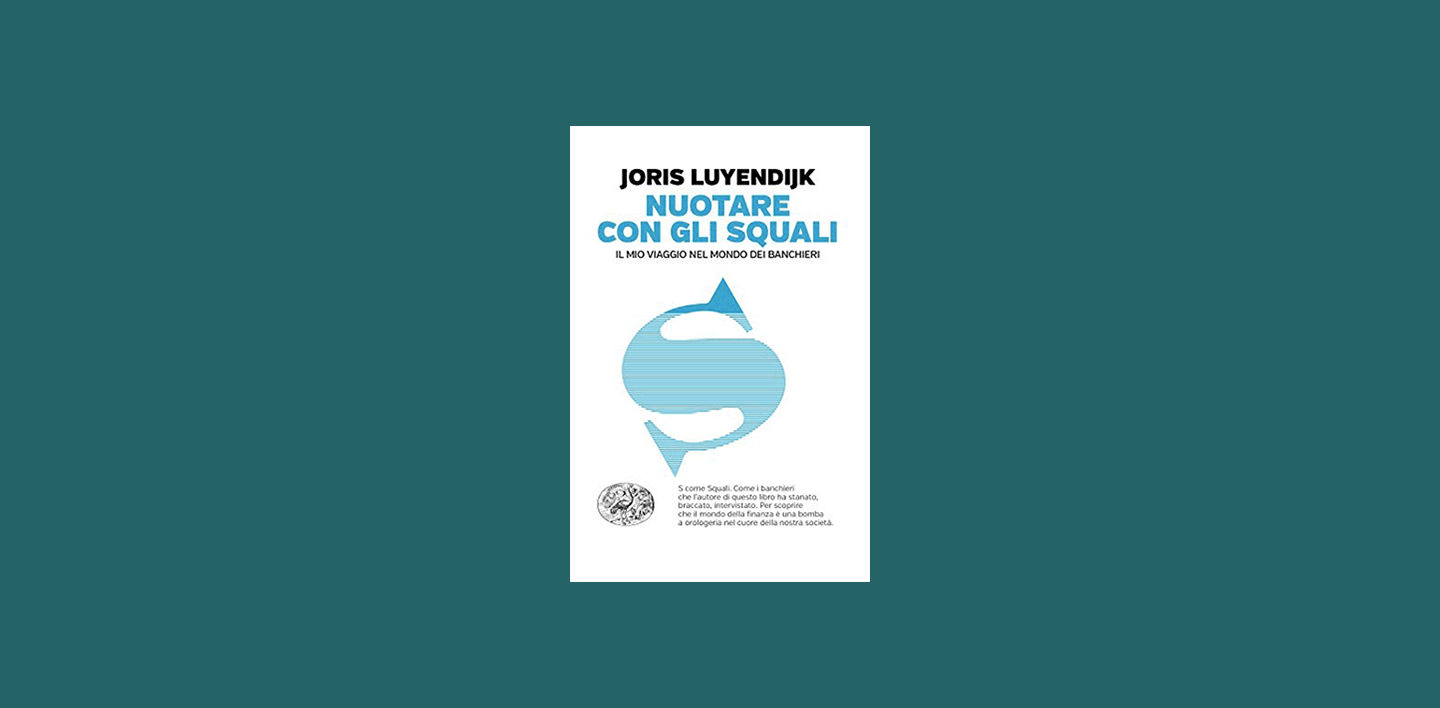
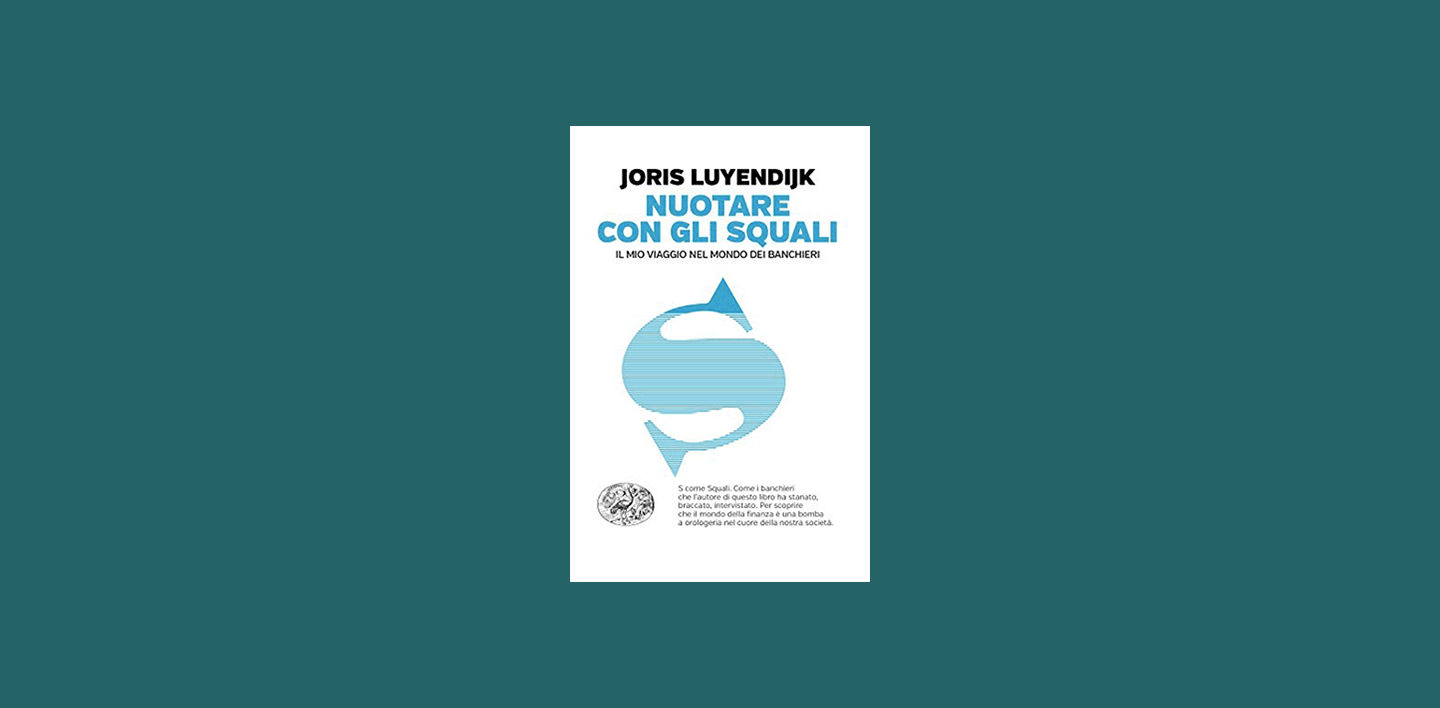
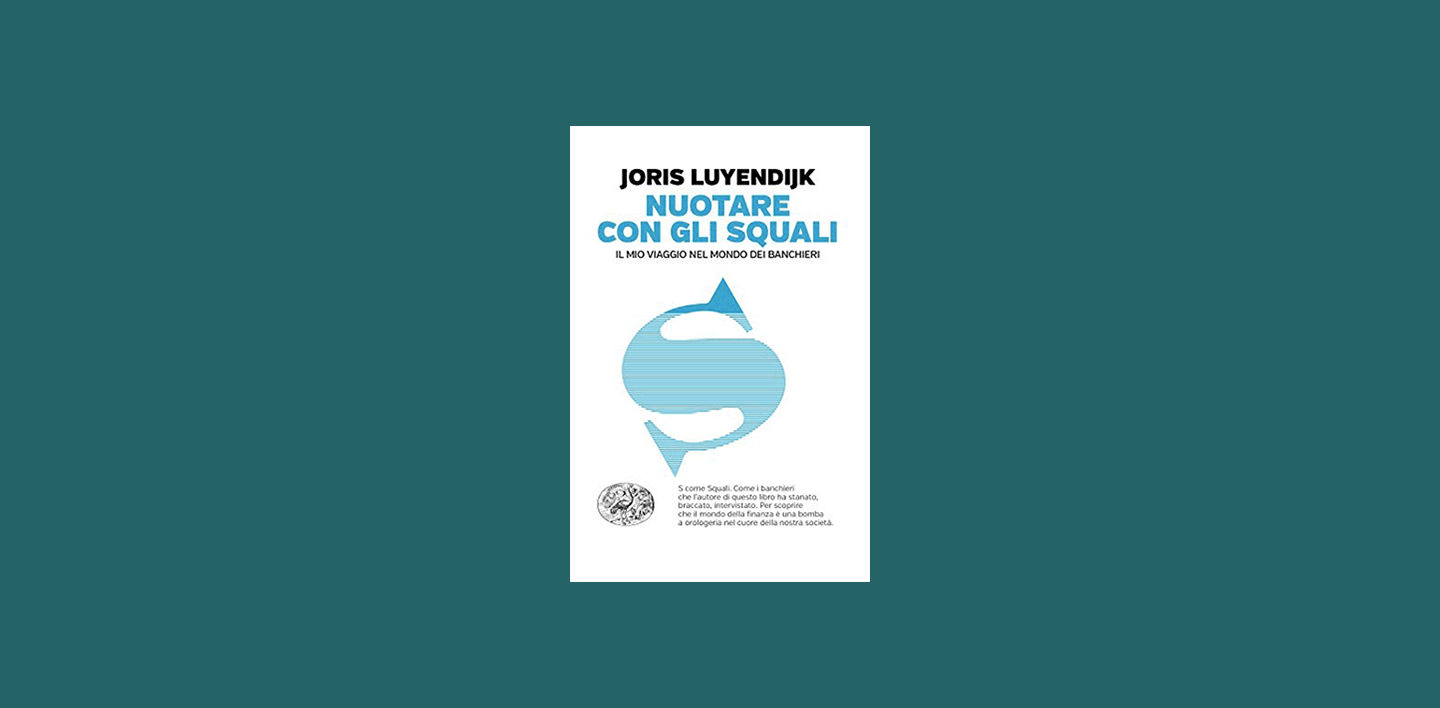
È il dilemma che tormenta chiunque si ponga il problema politico di capire come mai il mondo (qualcuno direbbe il capitalismo) continui a funzionare male: esistono i cattivi, gli spietati, i responsabili, esistono soggetti imputabili, condannabili, oppure (prospettiva molto meno consolatoria) il male è sistemico, strutturale, e nessuno, nessuna lobby o singolo centro di potere è direttamente imputabile davanti a un groviglio inestricabile di interessi, dentro una complessità malsana sfuggita di mano a tutti?
Joris Luyendijk è un giornalista (olandese) del Guardian e già corrispondente dal Medio Oriente per diverse testate (People like Us è il suo precedente libro tradotto in molte lingue – ma non in italiano – che riassume cinque anni tra Egitto, Palestina, Iraq) e quella di cui sopra è la domanda che lo ha guidato nella lunga inchiesta poi confluita in Nuotare in mezzo agli squali – Il mio viaggio nel mondo dei banchieri (Einaudi). La sua risposta si può facilmente desumere dal titolo dell’ultimo capitolo: “La cabina di pilotaggio vuota”. Il treno (o l’aereo) avanza a tutta velocità senza conducente. Per due anni Luyendijk si è abilmente insinuato nella patinata cittadella della finanza londinese, la City, uno dei distretti finanziari più grandi e importanti al mondo dove tra annessi e connessi lavorano quasi 300.000 persone, una cospicua e asserragliata élite economica i cui redditi annuali, tra stipendi e bonus arrivano facilmente sopra le 500.000 sterline. Luyendijk ha intervistato circa duecento lavoratori, persone coinvolte a vario titolo nel complicato mondo della finanza, banker e non: back, middle, e front office, traders, addetti ai controlli su rischi e conformità, strutturatori (chi inventa prodotti finanziari complessi), impiegati e manager delle agenzie di rating o di società private d’investimento, gli “hedgie” ovvero quelli dei famigerati “hedge fund”, consulenti finanziari, reclutatori, eccetera.
Ne esce un’immagine complessa, più sfumata di quella divulgata dai film di Stone e Scorsese (Wall Street, 1987; The Wolf of Wall Street, 2013 – ma da lettore italiano viene anche in mente il maledettismo normalizzato del finanziere protagonista di Resistere non serve a niente, il romanzo premio Strega di Walter Siti). I giovani yuppies drogati e assetati di denaro, ipercinetici e oscenamente cinici esistono e si affacciano a tratti da queste pagine rivendicando senza falsi pudori la loro battaglia machista e social-darwinista nella giungla della finanza. Ma sotto le cime di cattiveria ci sono iceberg di mediocrità, di normalità, a volte persino di innocenza e vittimismo. Ne esce un mondo claustrofobico, piuttosto blindato: il “codice del silenzio” e la “cultura della paura” (di essere licenziati, marchiati, “mobbizzati”), sono componenti fondamentali dell’atmosfera che si respira e portare a casa le interviste non dev’essere stato facile. Sono state pubblicate nel corso del tempo – quasi tutte anonime e spogliate di ogni indizio suscettibile di ricondurre all’identità dell’intervistato – sul blog dell’autore sul sito del Guardian, scatenando le reazioni scomposte di molti lettori animati da un rancore viscerale e giustizialista.
Luyendijk invece è molto distaccato. Di formazione antropologo, ha condotto il lavoro come una ricerca sul campo, utilizzando le interviste per ricostruire storie di vita in una specie di etnologia metropolitana, isolando i diversi rituali degli addetti alla finanza mondiale (gerghi, carriere, stili di abbigliamento, di alimentazione, eccetera) e tipizzando i comportamenti professionali dei soggetti interpellati. Ci sono i “ciechi”, i “neutrali”, i “repressi”, i “padroni dell’universo” (da Masters of the Universe, il documentario-confessione di Rainer Voss, l’ex investment banker pentito) e i “deliranti”. Di fronte agli smaniosi e faustiani lupi dei flussi finanziari emergono reazioni diverse, punti di vista meno prevedibili che gettano nuova luce anche sui primi. “Alla luce delle testimonianze degli intervistati a cui ho chiesto di indicare le motivazioni che li spingono a lavorare in finanza” scrive Luyendijk, “l’avidità non sembra una spiegazione valida a giustificare il loro comportamento. Sono giunto alla conclusione che in realtà l’errore più grave commesso dagli esterni al sistema nel periodo successivo al crac della Lehman è stato proprio quello di focalizzarsi sull’avidità”.
I giovani yuppies drogati e assetati di denaro, ipercinetici e oscenamente cinici esistono e si affacciano a tratti da queste pagine rivendicando senza falsi pudori la loro battaglia machista e social-darwinista nella giungla della finanza.
Emerge piuttosto la normalità psicologica di gente che segue percorsi in buona parte predeterminati (buone famiglie, scuole private di alto livello, circuiti sociali e culturali esclusivi, modelli dominanti) e che si trova incastrata nel proprio ruolo, spesso con grave spesa in termini di salute mentale e morale. Come dice un reclutatore intervistato: “I miei clienti non sono cattive persone. Sono persone che non ragionano più in termini di bene e male. Sono dei professionisti”. Al di là dei Leonardo di Caprio cotti di anfetamine, quelli che parlano a Luyendijk sono soprattutto piccoli Eichmann workaholic che squadernano con candore la banalità del loro male, il suo carattere operativo e sistemico, anche se questo collide con l’immagine demoniaca che vorremmo farcene. A volte sono persone abbastanza contrite, che però non riescono a uscire dal sistema e si sentono chiuse in una prigione d’oro.
Certo, qualcuno gonfia valori azionari e assume condotte chiaramente fraudolente, ma di solito tutto si muove in una legalità fluida dove il gioco è sporco per sua stessa natura ed è difficile capire se e dove qualcuno abbia effettivamente oltrepassato un limite, ha trasgredito regole che sembrano fatte apposta per essere aggirate. Ed è giustamente sul sistema che Luyendjik finisce a ragionare, come un antropologo appunto, che da singole pratiche risale alle strutture collettive che le pratiche alimentano e riproducono. C’è “l’atmosfera di sospetto reciproco; l’inesorabile e amorale corsa al profitto e la schiavitú della “responsabilità di fatturato”; la brutale cultura che regola le assunzioni e i licenziamenti” e che favorisce un individualismo spietato, ci sono gli incentivi perversi che sollecitano condotte discutibili, ma ancora più a monte ci sono fatti la cui evidenza da sola non basta a rendere emendabili, a quanto pare: incredibili conflitti (o meglio collusioni) di interessi tra controllori e controllati (la più clamorosa è la scoperta da parte del giornalista che le potentissime e oligopolistiche agenzie di rating sono pagate dalle stesse banche che dovrebbero valutare in maniera disinteressata), la formazione – che data grossomodo agli anni Ottanta – di megabanche che uniscono al loro interno funzioni e servizi prima separati e che sono diventate “troppo grandi per fallire”, come recita un ritornello che risuona spesso in queste pagine; c’è la politica follemente miope e “a breve termine” delle aziende che lavorano in finanza. Tutta roba relativamente facile da capire.
Facile anche la soluzione? In un certo senso: “Le banche innanzitutto vanno parcellizzate, in modo che non siano più troppo grandi o complesse per fallire e, di conseguenza, ricattarci. Secondo, non devono ospitare sotto lo stesso tetto attività passibili di creare conflitti di interesse tra il trading, la gestione patrimoniale e l’intermediazione finanziaria o tra la fornitura di servizi di base alla clientela da un lato e gli investimenti ad alto rischio dall’altro. Terzo, non devono costruire, vendere o possedere prodotti finanziari complessi; i clienti devono essere in grado di comprendere cosa acquistano e gli investitori devono potersi orientare nel bilancio di una banca. Infine, come si incassano i bonus, si dovrebbero incassare anche i malus, ossia sarebbe logico che fossero i banchieri che si assumono i rischi a preoccuparsi più di chiunque altro delle conseguenze delle loro operazioni sul capitale o la reputazione della banca” e non che i rischi ricadano su più o meno ignari risparmiatori o piccoli investitori. Eppure…
Leggendo questa inchiesta il lettore scoprirà forse per la prima volta la reazione degli insider alla crisi del 2008. Chi ci capisce sostiene che abbiamo sfiorato la catastrofe. Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio Europeo, nel 2014 ha ammesso in un’intervista che sei anni prima si era arrivati “a pochi millimetri dall’implosione totale”, dalla possibilità di un cambiamento radicale dei nostri paradigmi di vita. Di fronte a un’apocalisse appena schivata cosa è stato fatto? Sono state prese misure radicali per impedire che si ripeta, sono state estirpate le erbe infestanti che hanno portato alle creazioni di bolle e di bombe a orologeria? La risposta di Luyendijk è no. La risposta è: tutto come prima. La logica conseguenza è: succederà di nuovo, prima o poi.
Se i cattivi non esistono, se la loro psicologia è il sottoprodotto di un sistema complessivamente disfuzionale e se le istituzioni sono impotenti, allora il cambiamento non potrà che essere etico e culturale.
Se le democrazie occidentali non sono state capaci di intervenire sul sistema finanziario è, banalmente, perché la politica è più debole della finanza. Perché “le megabanche e le grandi istituzioni finanziarie operano a livello globale, mentre i politici e le normative sono organizzati a livello locale, o al limite continentale e di blocco. Le istituzioni finanziarie sono in grado di mettere Paesi e blocchi di Paesi gli uni contro gli altri e lo fanno spudoratamente”. La finanza è globale, la politica è locale, ergo: la politica è un nano sulle spalle del gigante finanza. Ecco perché, tra parentesi, i nazionalismi fanno il gioco del gigante cattivo. E così la politica è diventata non solo ostaggio ma una specie di stagista schiava della finanza: “In tutto l’Occidente la politica e gli incarichi pubblici, da poteri compensativi rispetto al mondo della finanza, sono diventati un trampolino per chi vuole entrarvi.” Seguono esempi di figure passate con disinvoltura da importanti incarichi politici ad attività (ben più redditizie) nel settore finanziario.
E insomma il libro si chiude lì, su un problema immenso irrisolto e su quella cabina di pilotaggio vuota che fa tremare. Si riparte dalla paura: quella che odiano le borse e i loro sudditi della politica – che perciò fanno di tutto per oscurarla a colpi di ottimismo dopato – ma anche una paura che servirà ad attivare forse qualche connessione a livello di cervello rettile, o qualche rete di meme, qualche sussulto dell’intelligenza collettiva. Se i cattivi non esistono, se hanno le mani legate, se la loro psicologia è il sottoprodotto di un sistema complessivamente disfuzionale e se le istituzioni non hanno la forza di opporvisi, allora il cambiamento non potrà che essere etico e culturale. L’educazione finanziaria e il sistema scolastico appaiono ogni tanto tra le riflessioni di Luyendijk ed effettivamente si potrebbe cominciare da lì.
Se oltre a inventarsi procedure di valutazione, ambiziosi e irrealizzabili programmi di update tecnologico, e sacrosanti ma astrusi protocolli di inclusione sociale, se oltre a tutto questo (e molto altro) il Ministero dell’Istruzione (i ministeri dell’istruzione) imponesse, per esempio, a ogni indirizzo di scuola superiore due o tre ore di studio alla settimana di economia politica e finanziaria (e se questo studio non fosse supinamente orientato al neoliberismo selvaggio che tutto ingloba e plasma), forse tra cent’anni – al netto di rivoluzioni prossime venture in cui non crede più nessuno, e qualora il mondo non fosse già trasformato in uno scenario da ambientalismo catastrofista – i nostri discendenti potranno voltarsi e guardare allo strapotere e ai prodotti tossici della finanza del ventunesimo secolo come noi oggi guardiamo al minculpop, al servaggio o ai tribunali dell’inquisizione.