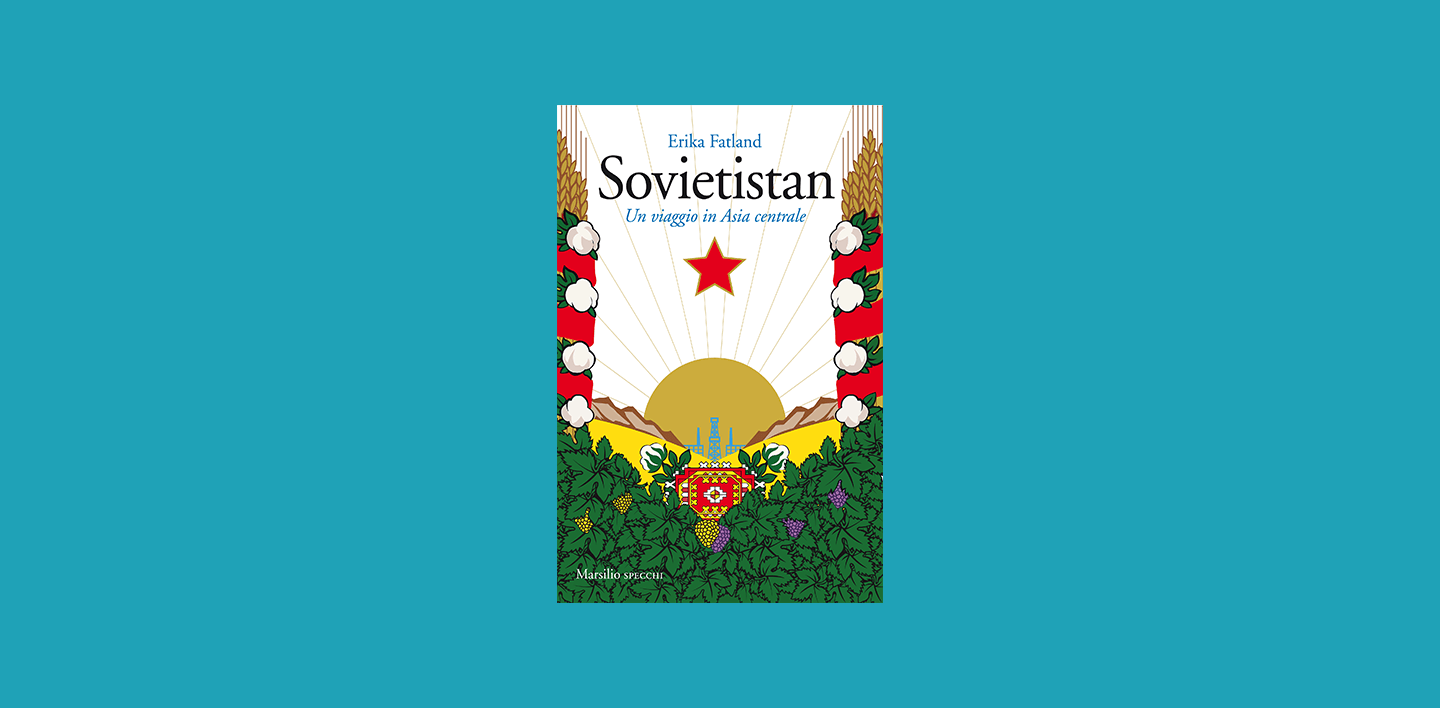
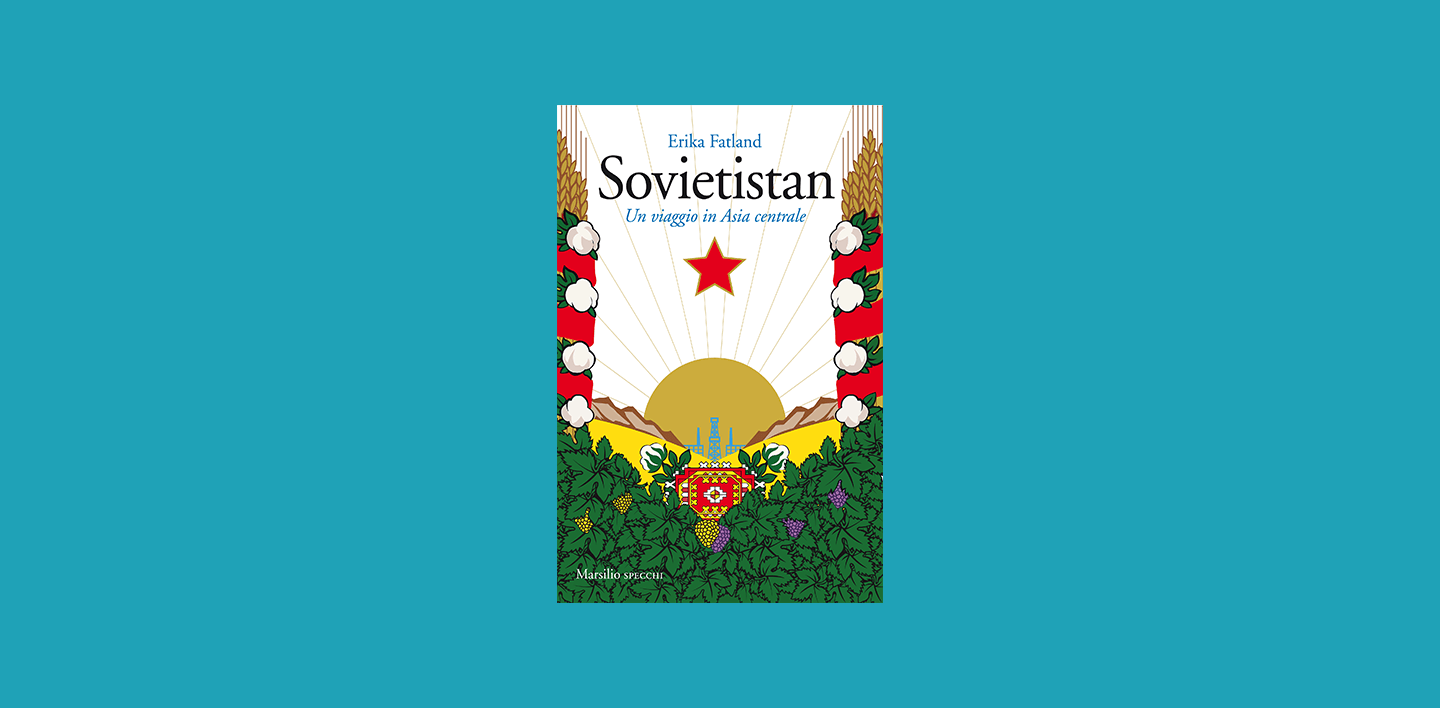
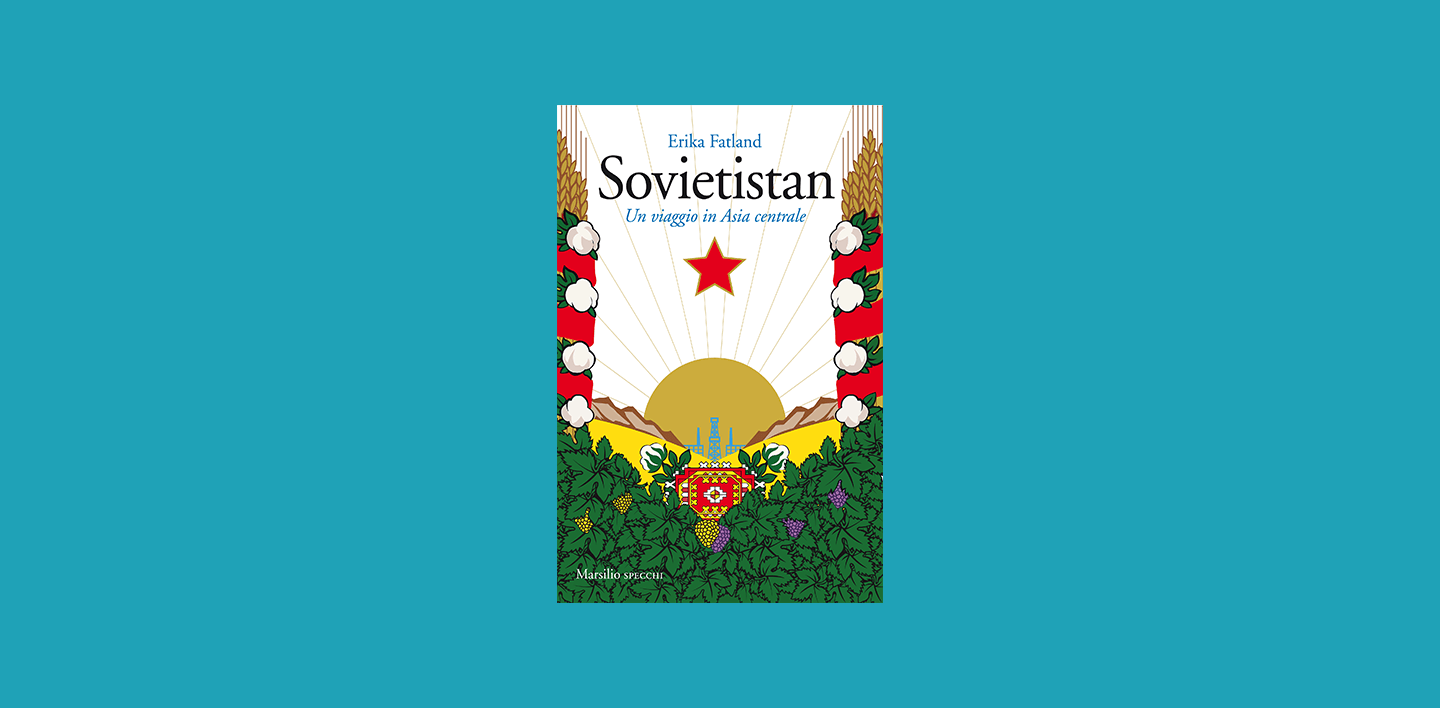
N ella piazza principale di Aşgabat, due volte al giorno, un monumento a forma di libro si apriva automaticamente mentre dagli altoparlanti una salmodia ne declamava un capitolo. Il gigantesco volume rappresentava il Ruhnama – “Libro dell’anima” – scritto nel 2001 dal primo presidente della Repubblica del Turkmenistan, Saparmarat Nyýazow, per educare e turkmenizzare il popolo. Nyýazow è morto nel 2006: da allora, il gigantesco volume è rimasto chiuso. A Semipalatinsk, un rilevatore di radiazioni ancora pigola impazzito non appena ci si avvicina all’ex centrale atomica, nonostante gli ultimi esperimenti nucleari in Kazakistan siano cessati nel 1991, con la caduta dell’Unione Sovietica: “più o meno una volta al mese udivamo un boato impressionante, seguito da una scossa che sembrava un terremoto”.
Ogni mese, per anni. Dušanbe, capitale di un paese, il Tagikistan, il cui PIL annuo non supera gli otto miliardi di dollari, vanta il bompresso più alto del mondo – costruito da una ditta tedesca specializzata – e la biblioteca più grande di tutta l’Asia centrale: può ospitare dieci milioni di volumi, ma è quasi costantemente chiusa. Le ragioni sono due: non ci sono i libri e la corrente è un lusso che va centellinato. In Kirghizistan per una ragazza in età da marito, vale a dire dai sedici anni in avanti, ma a volte già a quattordici si è ritenute mature, uscire a fare la spesa può voler dire finire sposa di un uomo che ha conosciuto nel preciso momento in cui, assieme a tre o quattro compari, lui l’ha caricata in macchina e l’ha portata a casa sua, dove la futura suocera l’attende con un velo bianco da porle in testa, gesto che sancisce l’avvenuto matrimonio.
Sono solo alcune tra le storie che Sovietistan (Marsilio, traduzione di Eva Kampmann) offre ai suoi lettori. Trentacinque anni, norvegese, poliglotta e laureata in antropologia culturale, Erika Fatland ha viaggiato per un anno attraverso le cinque repubbliche centroasiatiche nate all’indomani della dissoluzione dell’Unione Sovietica. La formazione dell’autrice traspare dal piglio con il quale descrive le persone nelle quali si è imbattuta: dall’anziano tagiko jaghnobi, nella cui valle si parla un dialetto diretto discendente del sogdiano del VII secolo d. C. (“quando tornerai a casa potrai dire di aver conosciuto un uomo triste”) alla guida turkmena più attenta a magnificare la statura politica di Berdimuhammedow (il successore di Nyýazow) che a spiegare alla propria ospite il museo deserto nel quale si aggirano. Dall’ultimo falconiere kirghiso agli abitanti di Rot Front, avamposto di lingua tedesca inghiottito da una prateria che non sembra avere fine; da una giovane cameriera tagika il cui marito si è trasferito in Russia e non è più tornato a Viktor Ivanovič Sarianidi, il “leone del Kara-Kum”, leggenda dell’archeologia centroasiatica.
Definire l’Asia centrale non è facile: da un punto di vista storico, il Korāsān iraniano e la valle del Gândhāra rientrano a pieno diritto all’interno di quello che gli antichi persiani avrebbero chiamato Tūrān: il paese dei barbari, in contrapposizione con l’Ērān, dove fioriva la civiltà. Lo stesso vale per l’Afghānistan. E giustamente Fatland non manca mai di sottolineare i legami storici economici politici e culturali tra le cinque repubbliche e le regioni circonvicine: dalla Persia di Dario a Bābur, fondatore della dinastia Mughal ed eroe locale della valle del Ferghana, dai sovrani Kušan a Timūr, fondatore di un impero la cui capitale, Samarcanda, all’apice del suo splendore non aveva nulla da invidiare alla Roma augustea o alla Baghdād ‘abbāside.
I sovietici in Asia centrale hanno portato la ferrovia, l’istruzione e la sanità di massa, ed è per questo che non di rado, specialmente tra le generazioni meno giovani, non è raro sentirne parlare con nostalgia.
La rivoluzione d’ottobre, tuttavia, cambiò in maniera irreversibile il destino delle cinque repubbliche, ed è da questa prospettiva che Sovietistan guarda all’Asia centrale. Senza il socialismo – nella peculiarissima veste che ha assunto in queste repubbliche, divenute membri dell’Unione tra il 1920 e il 1925 – non si potrebbe capire, tanto per fare un esempio, il rifiorire di tradizioni pseudo-nazionali e pseudo-turciche sotto l’egida dei nuovi presidenti, un tempo quadri del Partito e prontamente riscopertisi eredi dell’autentica cultura Uzbeka, Turkmena o Kazakha: il Ruhnama, pamphlet politico autocelebrativo travestito da compendio di storia turkmena è un figlio, sebbene molto particolare, del Tempo di seconda mano, come direbbe Aleksievič, in Asia centrale. I sovietici in Asia centrale hanno portato la ferrovia (la stragrande maggioranza dei treni uzbeki risale come minimo agli anni ’50), l’istruzione e la sanità di massa, ed è per questo che non di rado, specialmente tra le generazioni meno giovani, non è raro sentirne parlare con nostalgia.
È merito dei sovietici se, dopo il terremoto che la rase quasi interamente al suolo nel 1966, Samarcanda venne rimessa a nuovo con il fasto che oggi contraddistingue i suoi luoghi simbolo, operazione di cui, all’indomani dell’indipendenza, il presidente Karimov si è immediatamente attestato la paternità. Tuttavia, nonostante la predilezione di Stalin per il Tagikistan (che reputava il paese con la più antica cultura del mondo), l’industrializzazione forzata degli anni Trenta si è abbattuta in Asia centrale con violenza inaudita: nel solo Kazakistan, le collettivizzazioni forzate hanno ridotto all’inedia tra l’uno e i due milioni e mezzo di persone. Senza l’esperienza sovietica, ancora, non si comprenderebbero i rigurgiti di violenza che hanno segnato le dispute confinarie tra uzbeki e tagiki nella valle del Surkhan Dar’yā (con episodi di autentici pogrom a Samarcanda) o tra uzbeki e kyrgyzi nel Ferghana.
Gli anni dell’esperimento socialista, a trent’anni dalla sua fine, non smettono di alimentare il dibattito pubblico dalle rive del Caspio alle pendici dell’Hindūkūš. Si va dalla de-sovietizzazione forzata del Turkmenistan, dove Nyýazow fece cambiare l’alfabeto dall’oggi al domani, con il risultato che metà della popolazione turkmena di età compresa tra i cinquanta e i settant’anni oggi non sa più leggere la propria lingua; a quelle meno improvvisate, ma non meno radicali, di Uzbekistan e Kazakistan: qui il passaggio dall’alfabeto cirillico a quello latino è programmato per il 2025. Il Tagikistan, il cui PIL è composto per il 35% dalle rimesse dei lavoratori emigrati in Russia, ha sostituito Brežnev e Černenko con Putin, ma la fedeltà al Cremlino, coatta o meno che la si voglia giudicare, pare non sia stata nemmeno sfiorata dall’acquisita indipendenza. In Kirghizistan, invece, un agguerrito gruppo di ventenni affila le armi in attesa delle prossime elezioni politiche: sono i membri del partito neostalinista.
Qui come in Russia, la figura di Stalin si è cristallizzata intorno al mito della Grande Guerra Patriottica e del sogno modernista. Le purghe, la collettivizzazione forzata, l’NKVD, appartengono a un’altra storia. L’Asia centrale come la guardiamo oggi su una carta geografica è incomprensibile senza la storia sovietica: ciò non è meno vero oggi, ed è vero per il futuro politico delle cinque repubbliche non meno che per quello identitario. Il russo è ancora lingua franca da Türkmenbaşy a Terekty, ma il fatto che nell’Ichan Qala di Xiva gli unici lavori di restauro siano finanziati dal governo cinese (come un cartello di sei metri per quattro affisso di fianco ai cantieri non manca di rendere noto, in inglese, russo, cinese e uzbeko) o che il mercato di Oš sia invaso di prodotti made in China che valicano la frontiera in qualsiasi modo (tanto che, oltre la frontiera, Kirghizistan viene chiamato Contrabbandistan) segnala che il vento potrebbe presto cambiare. Russia permettendo.