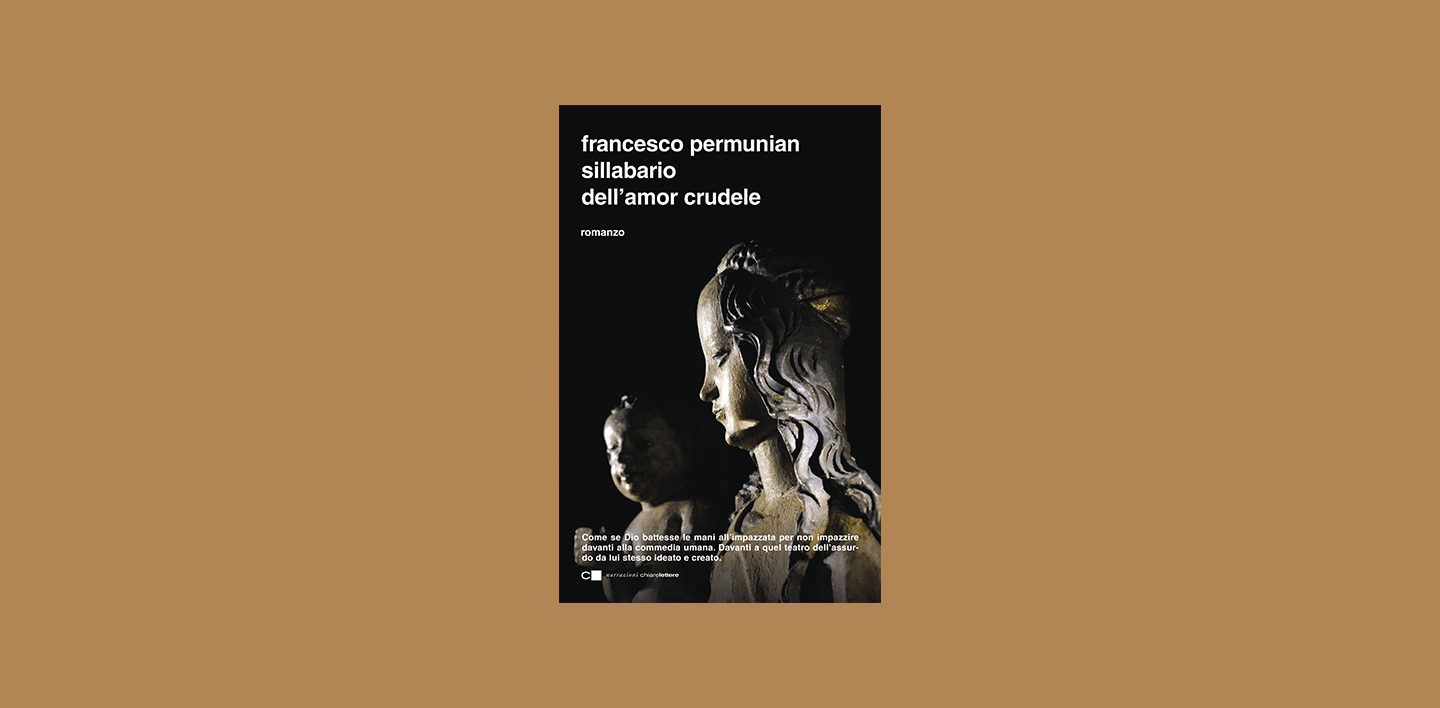
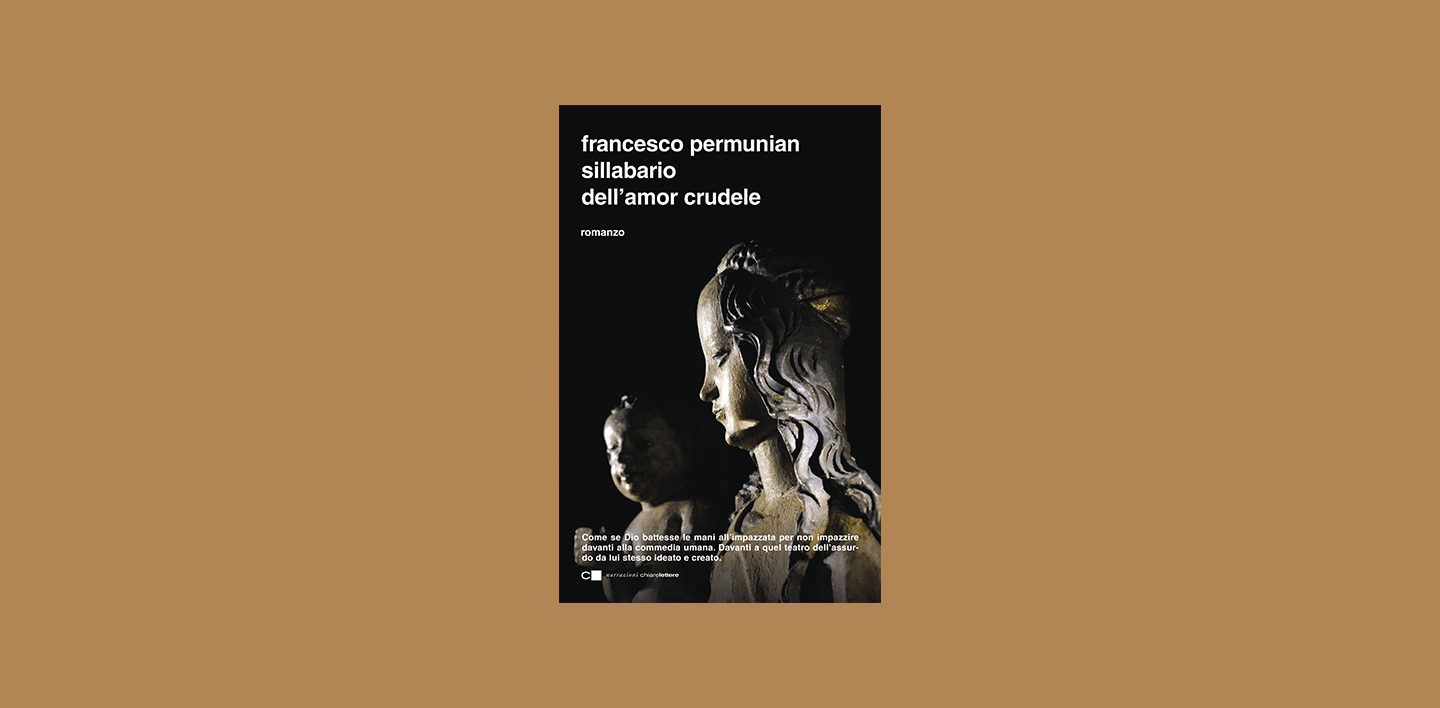
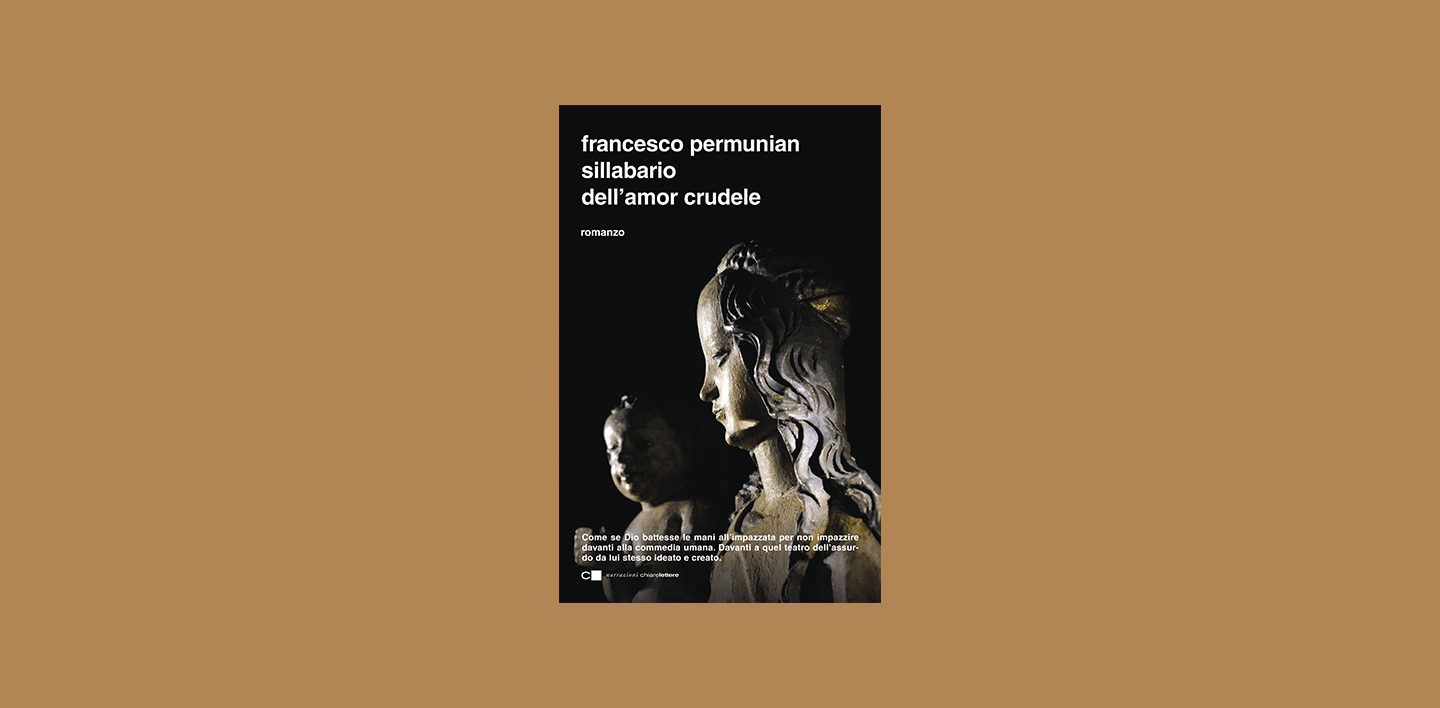
M ai ho trovato una risposta circa la natura di quel legame misterioso, e non di rado crudele, che la gente suole impropriamente chiamare amore”. Si interroga vanamente il protagonista e voce narrante dell’ultimo romanzo di Francesco Permunian, Sillabario dell’amor crudele (Chiarelettere). Abbandonato qualche anno dopo la nascita in un orfanotrofio alle porte di Verona, Teodoro Maria Baseggio elegge l’odio a esercizio di sopravvivenza.
Frugando tra la polvere dell’infanzia si scontra con figure che sembrano uscite da un quadro di James Ensor. Il rifugio gestito da suore Clementine per bambini con disturbi psichici o disfunzioni fisiche assumerà i contorni di una prigione dell’infanzia, teatro di abusi sessuali perpetrati da preti e monsignori. “Che cos’erano difatti, se non prigioni, quei posti nei quali, per secoli e secoli, vennero segregati tutti i bambini abbandonati ed esposti alla pubblica carità? Piccole creature destinate a un’esistenza segnata da un lacerante senso di emarginazione e da un altrettanto sordo e malcelato rancore verso il prossimo: ecco chi erano gli ospiti abituali di quelle atroci e tristissime carceri infantili”.
Il protagonista attinge ai ricordi dell’infanzia per descrivere gli esiti di quelle sevizie, gli aborti eseguiti da una mammana in una sala parto improvvisata nei sotterranei dell’orfanotrofio, la crudeltà dell’accanimento su vittime già segnate dal peso dell’abbandono. “È stato come svegliarsi da un incubo. Non saprei come altrimenti definire quell’oscena piaga segreta che per anni mi ha ammorbato l’anima, quell’oscuro senso di colpa che mi ha accompagnato per tutta la vita.”
Accanto a quella di Teodoro si inserisce la storia dell’amica costretta alla prostituzione in Bangladesh dai cinque anni che, una volta in Italia, diventerà oggetto delle attenzioni di un alto prelato. La chiamavano Baby Yaba, ne ricorda ancora la voce, associata al canto sommesso delle tortore,
un lamento così speciale, e inaudito, che pareva il pianto di un uccellino ferito a morte. Così singolare e speciale, ripeto, da risultare un richiamo irresistibile per tutte le tortore del circondario le quali, udendo quel gemito che vagava nell’aria, accorrevano a stormi sul tetto della Santa casa dei trovatelli.
Permunian intesse una narrazione anzitutto emotiva dell’odio e del rancore verso il genere umano: un magma incandescente di cui il protagonista si nutre per sopravvivere. Stilare un sillabario permette all’autore di incasellare il tragico attraverso una sua raffigurazione grottesca in chiave comica, strategia narrativa che considera la più efficace rappresentazione letteraria del dolore e che caratterizza la sua intera produzione.
La scelta formale diventa qui l’espediente per offrire una rappresentazione figurata dello svolgimento monotono di un’esistenza destinata a logorarsi “come un vecchio sillabario consunto” e, al contempo, delineare quel doloroso rimestare tra i ricordi per denunciare le violenze di un orfanotrofio cattolico. Una ricerca che guarda allo zibaldone leopardiano e che trova nel frammento l’identità stilistica di una scrittura caustica e sferzante capace di travalicare i confini di genere per fondere il diaristico col romanzo, l’artificio narrativo col biografico: “posso affermare di averlo scritto con scrupolo e serietà, questo privatissimo cahier de doléances, intingendo più volte la penna nel pozzo nero della memoria. Senza inutili menzogne o stucchevoli fronzoli, come si addice a una confessione sincera.”
A partire dall’Anabasi che apre le pagine, in cui si accenna alla pratica in uso presso i popoli antichi, di abbandonare neonati deformi o figli illegittimi dentro pentole lasciate per strada (secondo quanto riportato da Giuseppe Franco Viviani in L’assistenza agli “esposti”), la narrazione si snoda tra dettagli, incontri e immagini. Rivive con terrore il ricordo dell’inno al Signore che le Clementine recitavano ogni sera nell’ora della compieta: “Di tenebra la terra ormai si ammanta. / Quasi una dolce morte / scende sui corpi spossati / che alla luce del giorno rivivranno”. Un “lugubre parlottio di suore nell’ora incerta del crepuscolo” che per lui e i suoi compagni di orfanotrofio rappresentava invece “un inno alle tenebre. Un’accorata e inascoltata invocazione al dio della notte. Nell’attesa che il suo manto oscuro coprisse per sempre l’infamia e il dolore delle nostre misere esistenze.”
Il perno dell’intera narrazione risiede nel legame originario tra l’infanzia e la morte, reso anche nell’incedere per dicotomie, con un continuo gioco al contrasto dall’acuta vena ironica e una forte componente aneddotica.
Lo sguardo investigativo del protagonista si posa su personaggi che nell’incarnare vizi, perversioni e debolezze, diventano attori della commedia allestita sulla pagina: ex presidi cattoliche che cercano di rovistare, attraverso l’immondizia, tra le coscienze dei loro alunni; novantenni ex indossatrici che anelano l’immortalità inseguendo il mito dell’eterna giovinezza; prostitute gemelle; galoppini elettorali; ex editori che deridono l’industria letteraria italiana; vecchie levatrici che fanno abortire segretamente le bambine; alti prelati costretti alla fuga all’estero.
Interessato a indagare il disagio dell’uomo nella società, Permunian mette in scena figure disturbate, alienati mentali e esclusi dalla comunità per identificare una contrapposizione tra due grandi gruppi: chi ha vissuto relegato in un orfanotrofio diventando parte di quel “campionario teratologico”, e chi rappresenta il resto della società. Un conflitto solo apparente, perché quelle esistenze rese con una spiccata caratterizzazione caricaturale sono la manifestazione inconsapevole di quei “vizi e pazzie di cui la natura è stata prodiga”, come scrisse Swift.
Procede per rivelazioni, il protagonista di Permunian, per condurre il lettore tra ambienti ricorrenti anche in altri suoi lavori – come Il gabinetto del dottor Kafka, Nutrimenti, 2013, o Chi sta parlando nella mia testa?, Theoria, 2018 –, luoghi da cui osserva incessantemente quell’umanità intera che sembra srotolarsi davanti alle sue lenti fumé.
A questo punto mi corre l’obbligo di confessare che io frequento abitualmente la stazione dei treni del mio paese da più di trent’anni. E questa è, sia beninteso, un’esplicita ammissione di poetica, e non una chiacchiera vana o una réclame turistica! Perché è proprio là, in quella specie di porto di mare ferroviario, dove io vado in cerca dei personaggi che si agitano nelle mie fole, i quali finiscono quindi per assomigliare tutti a degli strani ircocervi partoriti tra i fischi dei treni e i rumori dei cessi della stazione. [..] Scruto i loro volti con estrema attenzione. Li studio e poi pazientemente li catalogo, uno dopo l’altro, come farebbe un provetto entomologo con degli insetti bizzarri. Oppure uno studioso di teratologia fantastica alle prese con degli zombi petulanti.
Il ridicolo che caratterizza i suoi personaggi racchiude l’impossibilità di accettare il presente e di raggiungere una reale conoscenza di sé, perché accecati da false credenze e preda di manie e ossessioni. In quest’ottica, una rappresentazione incentrata sull’eccesso e il paradosso permette di amplificare il reale per mostrare gli esiti individuali della deriva morale della società nel predominio dell’uso del potere. Attraverso un impiego continuo della farsa come messinscena del reale, Permunian riflette sul significato di giustizia, sulla necessità di vendetta che anima chi non è disposto a ritenersi irrimediabilmente dannato.
L’ironia dissacrante che vena la pagine, lontana da una sterile irriverenza, si innesta su riflessioni sul senso del peccato, su un’idea di blasfemia, sul significato della fede sulla scorta degli interrogativi mossi da Sergio Quinzio. “Se ci penso, e purtroppo ci penso spesso, arrivo alla conclusione che tutta la mia vita sia stata una farsa. Sì, una sporca e ignobile farsa con due soli attori sulla scena. E due soli spettatori, io e il Padreterno”. Si rivolge a Dio per imputagli la colpa di aver permesso e fomentato “siffatte aberrazioni cromosomiche al solo scopo di distrarsi dalla sua funesta solitudine. Un aberrante capriccio divino, questo sono io. Una minuscola pedina da gioco nelle mani di un dio solitario e malinconico che ha bisogno di nani e buffoni per la sua reggia celeste sempre più vuota e deserta”.
La solitudine che connatura esistenze a cui non sembra riservata alcuna salvezza racconta il dissiparsi e lo sfiorire di qualsiasi forma di bellezza, descritta anzitutto nella sua caducità. L’irrequietezza con cui i ricordi si inseguono nel romanzo traccia quanto di irrisolto rimane davanti a un abbandono, al vuoto che ogni perdita porta con sé, esasperato a partire dal modo di abitare perennemente i confini dell’assurdo. Tormenti generati da un oscuro senso di colpa per la sopravvivenza di cui il protagonista non riesce a sbarazzarsi, e che assumono le sembianze di demoni. Come quando, ogni anno, nel giorno della commemorazione dei defunti, decide di recarsi nel piccolo cimitero della bassa veronese in cui riposano le vittime che hanno condiviso con lui quegli anni.
Ci vado per portare un fiore ai miei compagni che, nell’indifferenza generale, morirono di stenti e botte nella Santa casa dei trovatelli; ci vado insomma per fare quattro passi tra quelle tombe anonime, da cui odo salire ancora un mormorio che emerge dai prati della nostra giovinezza. Voci e sussurri mescolati a pianti e sospiri. Cenere mescolata ad altra cenere. Un diluvio infernale di cenere che non cessa di scendere negli anfratti più segreti della mia mente allucinata.
Nel contrasto tra materiale e immaginifico Permunian tratteggia una follia che nel dolore assume i contorni di un concetto alternativo di realtà, e che in quell’incedere allucinato e visionario affonda le sue radici nei suoi riferimenti letterari primari, da Witold Gombrowicz, Thomas Bernhard, Juan Rulfo, Bruno Schulz, Antonio Lobo Antunes, a Eugène Ionesco e Emil Cioran, oltre a Tommaso Landolfi e Giorgio Manganelli. Il debito in particolare nei confronti di Ionesco è evidente, soprattutto nella scelta di immaginare una sorta di drammaturgia che sfiora l’assurdo.
Il visionario che caratterizza la sua scrittura si colloca nella direzione di un’evasione dalla sfera del razionale – non senza prima aver analizzato, mostrandola anche attraverso dettagli che si fanno portatori di significati metaforici, una realtà destinata a scorporarsi perché legata indissolubilmente all’orrore dell’infanzia:
[anni] a dir poco infernali! Popolati da inenarrabili offese e umiliazioni. E da un oscuro rancore che sentivo crescere in me come un fungo velenoso, giorno dopo giorno, nelle mie viscere di mostriciattolo. Tanto che quel fungo, com’era prevedibile, ha poi assunto le sembianze di un’orribile chimera. E questo semplicemente perché, a furia di guardarsi sempre indietro, come ho sempre fatto io, si finisce inevitabilmente per specchiarsi non tanto negli occhi dell’infanzia, bensì negli occhi di quella vecchia baldracca camuffata da bambina che è la morte.
“Cos’è, allora, la realtà?”, si chiede per voce del protagonista, cercando di individuare una via verso quella che Henri Barbusse definì “la conoscenza dei recessi più profondi della natura umana”. Nasce da qui l’urgenza di attuare travestimenti burleschi e immagini blasfeme per mettere in atto continui esperimenti di contraffazione, e compiere anzitutto una denuncia sociale e politica che non si riduce a un’invettiva contro l’ambiente ecclesiastico, ma che mira a evidenziare connivenze alla base di una società corrosa e complice.
Caricata dallo sguardo costante sulla morte, la dimensione dell’infanzia assume piena centralità nell’intera produzione letteraria di Permunian. Definita come una “remota stagione” di cui “non è rimasto che qualche brandello, qualche vela raminga nell’oceano del tempo perduto”, l’infanzia concepita in relazione alla morte, immaginata come “una vela sbrindellata che si dilegua e scompare all’orizzonte”, richiama la necessità di rintracciare i motivi della scrittura nell’elaborazione del dolore, con la convinzione che occorra “gettare le basi di una serena e consapevole morte fin dall’inizio, nel tempo dei primi passi puerili. O meglio al tempo delle culle” là dove, come scriveva Cristina Campo “infanzia e morte, allacciate, si confidano il loro reciproco segreto”.
Permunian inscena attraverso quelle storie tragicomiche una danza macabra a cui ogni personaggio è inevitabilmente chiamato a partecipare, una sfrenata sarabanda onirica che si mischia alle voci di fantasmi che popolano il suo immaginario.
La riflessione sul tempo, che più in generale domina le opere poetiche e in prosa di Permunian, impone a ogni personaggio di confrontarsi con esso, risultando inevitabilmente sconfitto nel timore di perdere, così, ogni ricordo e con la percezione di non riuscire ad arrestare l’inesorabile annientamento della memoria e della fantasia. “Ogni giorno è una battaglia persa contro il tempo che, rovinosamente, passa e va come un fiume in piena. L’onda del tempo mi sta sommergendo, lo sento, e ormai vivo nel terrore di perdere ogni ricordo e di smarrirmi nelle paludi della demenza senile”.
Quel “mal della morte, che si annunciava”, come scrive Salvatore Silvano Nigro, richiama costantemente un confronto con il senso della fine e con la contemplazione dell’assenza che sarà destinata ad arrivare da una panchina all’ombra di un vecchio pino d’Aleppo nell’ultima, quieta, attesa: “dentro questa piccola e affollata giostra del mio breve viaggio verso il nulla”.