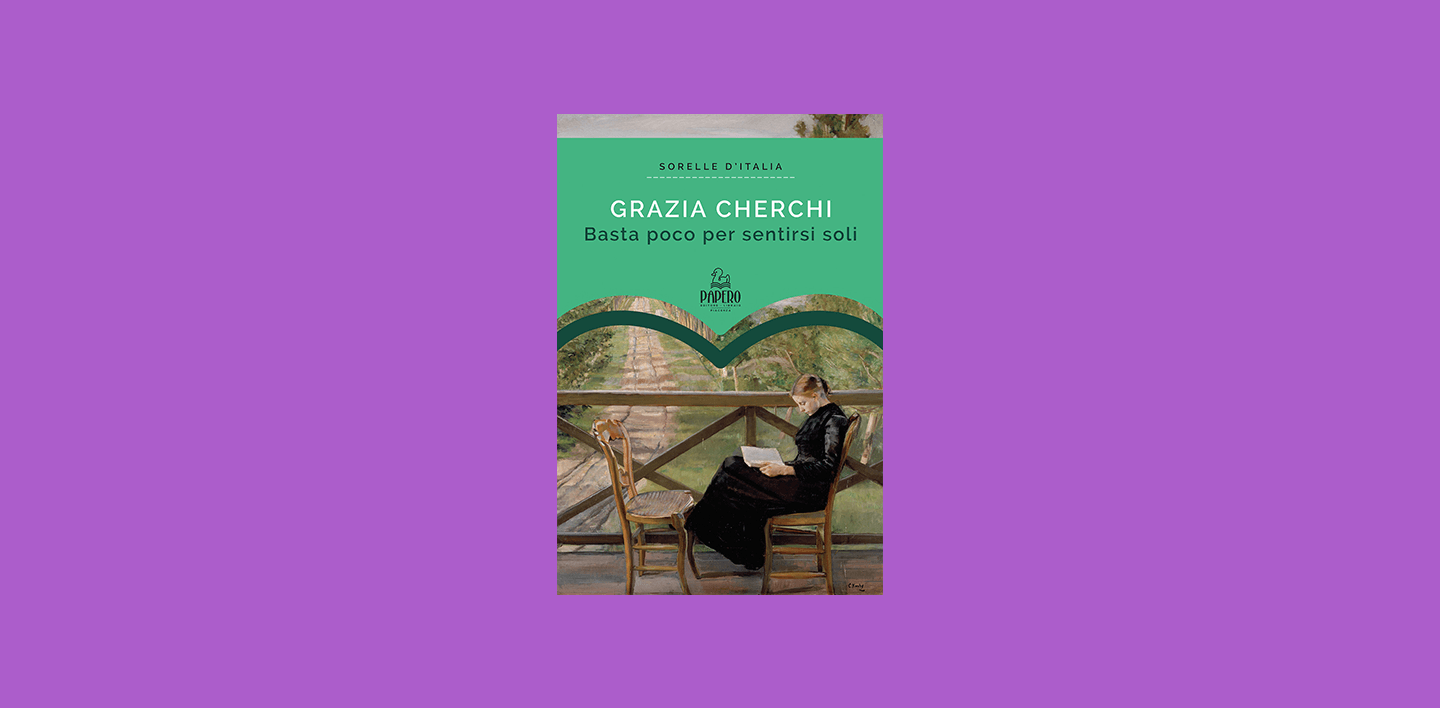
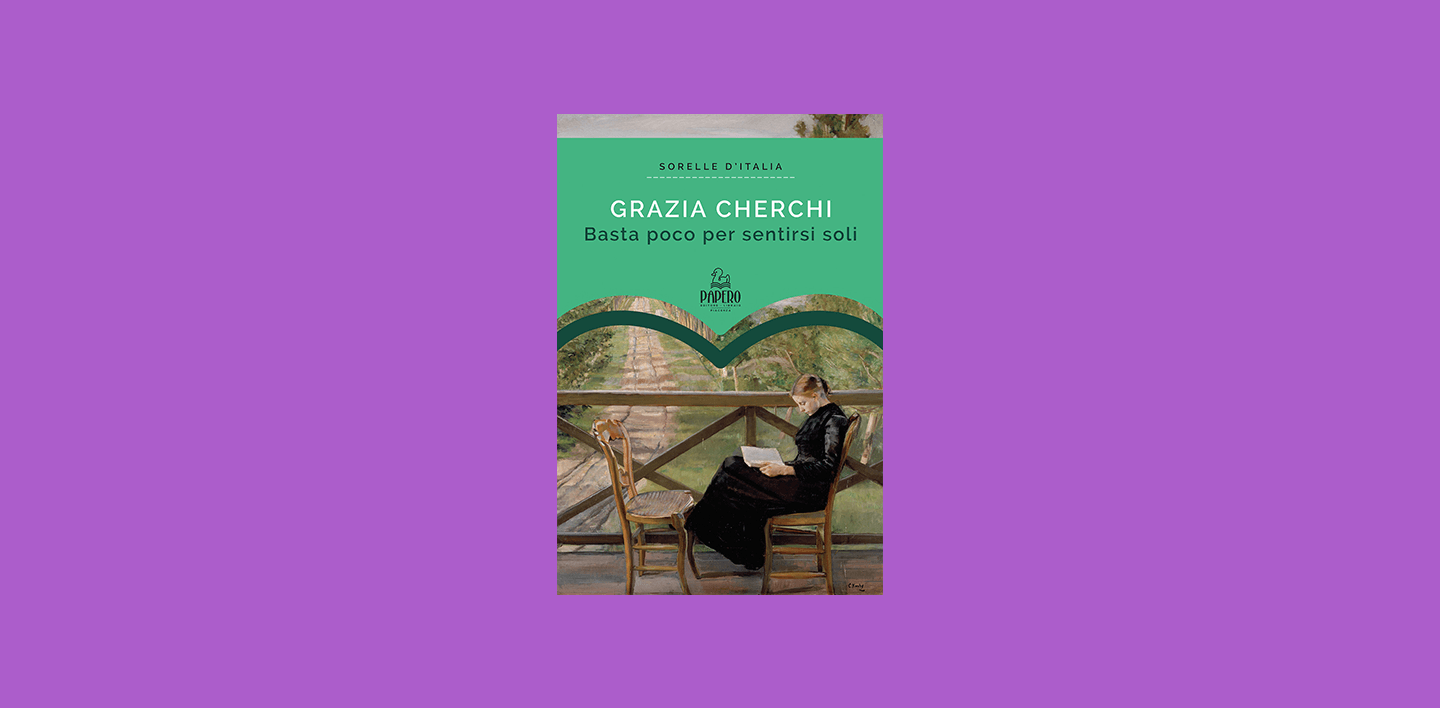
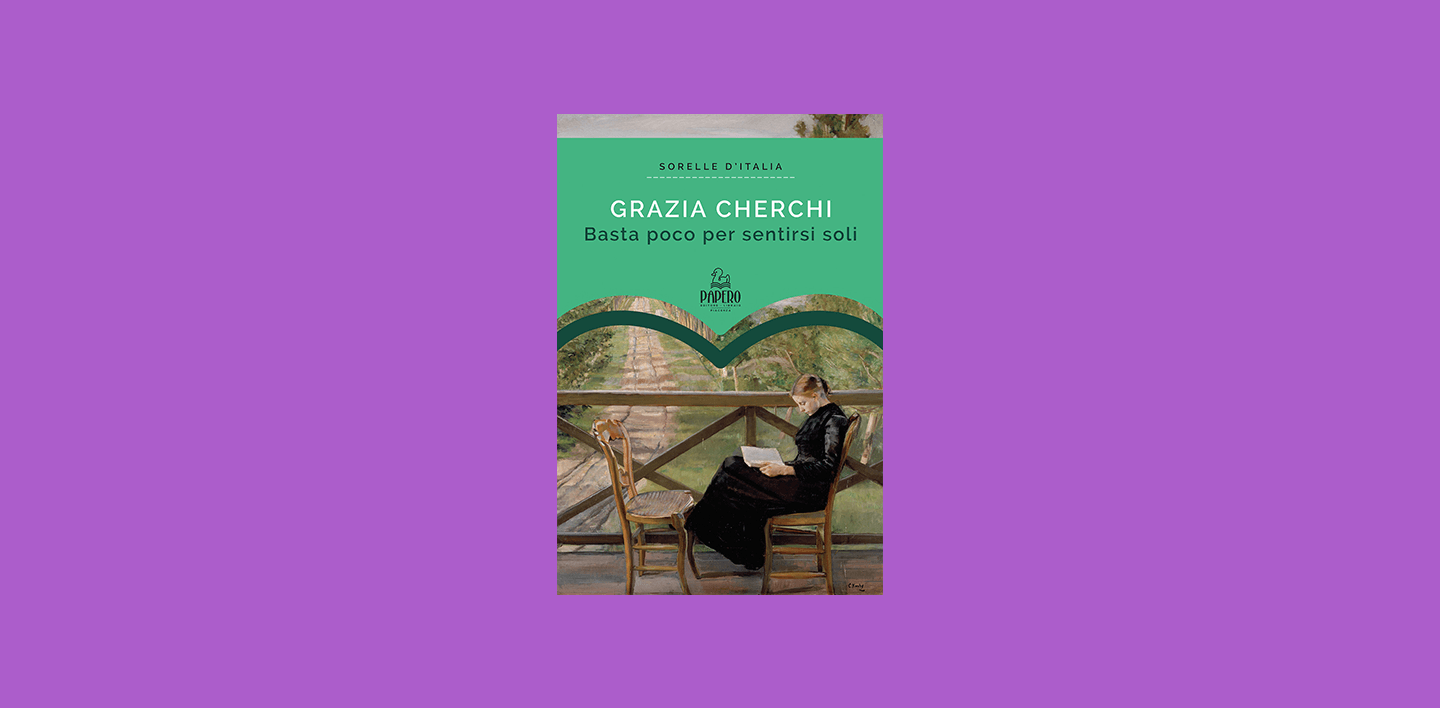
H o scoperto la raccolta di racconti di Grazia Cherchi per caso, attratta dall’antica copertina disegnata da Altàn e dal titolo più accattivante che mi sia mai capitato tra le mani: Basta poco per sentirsi soli. Scrivendo di Grazia Cherchi è impossibile non appropriarsi del suo tono, della sua lingua essenziale ed esatta che severamente redige gli svolazzi della finzione e dell’autobiografia anche nei testi propri. Per trent’anni Cherchi è stata infatti editor di altri – Stefano Benni, Enrico Deaglio, Massimo Carlotto figurano tra gli autori con cui instaurò un rapporto duraturo – e impiegata nelle maggiori case editrici ma anche consulente letteraria, critica e giornalista culturale per Linus, il Manifesto, Panorama e L’Unità. Soprattutto è stata fondatrice e instancabile redattrice dei Quaderni Piacentini fino alla chiusura nel 1984. Se la sua penna di editor ci viene tramandata in libri come Comici spaventati guerrieri o Castelli di rabbia e la sua verve critica riappare, organizzata, nella raccolta d’articoli Scompartimenti per lettori e taciturni (prima Feltrinelli, ora minimum fax), la sua voce di scrittrice rimane oggi dietro le quinte dell’industria letteraria dove aveva rivestito un ruolo essenziale ma allo stesso tempo ignorato dai non addetti ai lavori.
Del suo romanzo Fatiche d’amore perdute (Longanesi 1993) non è rimasta traccia e negli articoli che proliferano online gli ammiratori citano tutti gli stessi aneddoti. I pochi che sono riusciti ad accaparrarsi una vecchia copia di Basta poco per sentirsi soli ne elogiano le qualità senza tempo salvo poi giustamente lamentare l’irreperibilità del libro dopo quasi trent’anni dalla sua ristampa (1991 con E/O; prima con Tringale nel 1986). La frustrazione e l’impazienza che questa storia editoriale suscita, adesso che siamo abituati ad accedere a tutto immediatamente, sono placate dal viaggio nel tempo a cui ci invita: il mondo di Grazia è ancora popolato da macchine da scrivere, articoli dettati al telefono, interviste fatte di persona, cabine telefoniche, fotocopie, dattiloscritti pesantissimi che si sparpagliano per terra “con maliziosa vita autonoma”.
Carta, tantissima carta. Che resiste ancora oggi: Basta poco per sentirsi soli è stato per fortuna da poco ristampato dal Papero Editore, a inaugurare una collana – Sorelle d’Italia – dedicata a opere dimenticate di grandi voci femminili del nostro Novecento. La raccolta funziona innanzitutto come un trattato di antropologia della società culturale: Grazia (auto-nominatasi in diversi racconti) amministra – o, piuttosto, subisce – incontri con romanzieri suicidi, esordienti ansiosi, critici stizziti, poeti egocentrici, librai rassegnati, giornalisti affannati… Tutti personaggi che le piombano in casa e reclamano attenzione per consigli, lavori, lamentele. Quasi mai però ricambiano e anzi interrompono il flusso del suo lavoro o, a seconda della giornata, delle sue ansie. Conclusasi una visita inattesa, Grazia può finalmente lasciarsi andare alle preoccupazioni interrotte:
Ecco, ora può tornarmi la tachicardia. Ora, infine, posso concederle tutto il tempo di cui ha bisogno.
Dalla parete Kafka mi guarda dolorosamente. Lo so: “La fossa bisogna guadagnarsela”.
Ma per stigmatizzare – spesso sdrammatizzando, con la severità di una sorella maggiore – le nevrosi della classe intellettuale, bisogna naturalmente condividerle. Solo che l’autrice conduce la propria angoscia in solitaria, dimessamente; non spiattellandola ai quattro venti come i suoi colleghi bambinoni. Penare sempre, ma in autonomia:
“A proposito, come va il lavoro?”, chiese con fine intuito.
“Male, sono in disgrazia”.
“Posso fare qualcosa?”
“No”, dissi. A danneggiarmi basto io…
I racconti di Grazia Cherchi non sono solo un esilarante affresco socio-patologico, ma anche storico. E cioè di quando le donne che lavoravano nell’industria culturale erano pochissime. Unica in un mondo di soli uomini, è così ancor più esposta a tutti i loro difetti di genere: a un amico che non nota un suo radicale taglio di capelli (“ci vuol ben altro per distrarli da se stessi”), lei fa notare che tutti gli uomini dicono di preferire i capelli lunghi: “l’osservazione non gli piacque. È raro che accettino di rientrare nella media”. La gag più trita di sempre – maschi che non registrano acconciature femminili – acquista tutt’altra dignità. Perché il suo femminismo non è militante, piuttosto contemplativo. Il suo sguardo si addolcisce di fronte a una scena domestica osservata dal balcone:
Nella casa di fronte una donna stava versando un risotto giallo nella scodella di un uomo seduto a tavola. Parlando e sorridendo – lui a capo chino, col cucchiaio in pugno – gli si sedette davanti. Lui mormorò qualcosa e lei si alzò a prendere la saliera. Mai che se la prendano da soli. La donna riprese a parlare con vivacità. Ebbi un moto d’amore per lei, e per tutte le donne, che si consumano nella dedizione, nell’allegria, nella dolcezza, che tengono in vita gli uomini, tutti quanti. Questa è la verità.
La lingua di Grazia Cherchi è così sbrigativa – nel senso di concreta, dritta al punto; mai sciatta o imprecisa – che osservazioni come queste diventano aforismi universali. Basta poco per sentirsi soli (il cui titolo ne è un esempio) è puntellato da queste frasi epigrafiche, che magari l’interlocutore maschile percepisce come lapidarie o severissime (e dunque servono il loro scopo: liquidare lo scocciatore). In realtà sono perle di verità, applicate sarcasticamente a interazioni e tic quotidiani: “L’allegria del congedo: anche questa è fatta”; “L’infelicità è lì, a portata di mano, e tutti si servono con una specie di fame arretrata”; “Troppo comodo preannunciare sventure con la vita grama che si fa”.
Ovviamente è l’umorismo l’ingrediente necessario per trasformare la sentenziosità in generalizzazioni non solo condivisibili ma anche estremamente rivelatrici delle nostre cattive abitudini. Cogliere nel segno: un’espressione che forse come editor mi avrebbe depennato, ma che lo stile “graziano” materializza con precisione tale da trascendere i pretesti mondani di questi “raccontini” (era lei che li chiamava così). Un io narrante sempre azzeccato, ma serio solo a metà. Che parli tramite bimbi impertinenti per svelare le falsità degli adulti o che sia auto-ironico (sempre) o allegorico (spesso, nel suo bestiario cittadino di cani, gatti, uccelli e criceti), il suo senso dell’umorismo pare “lombardo” – o forse dovrei dire “padano” dato che la Cherchi è nata a Piacenza: spiccio, senza tempo da perdere, distaccato al limite della sprezzatura ma contemporaneamente ricettivo (sensibile) al logorio della vita moderna.
Quanto l’avrebbe indisposta quest’ultima incursione nello slogan televisivo! La ristampa del Papero contiene anche la sezione di racconti dedicata ai cosiddetti “tormenti d’oggi”, aggiunti nella seconda edizione del 1991: la cafoneria dei giovani, il vociare di televisioni sempre accese, la proliferazione del vitupero nella lingua italiana (glorioso però il racconto “Cazzo bar”, che comincia a Berlino). Come notava Spinazzola in una recensione dell’epoca:
Si affaccia qui il risentimento tipico dell’umanista verso il mondo moderno, colpevole d’essersi massificato. E assieme diventano percepibili le ombreggiature del patetismo.
La solitudine di Grazia è meno una scelta e più una conseguenza (dei tempi, del suo carattere); ma ciò avvelena la lingua e la trasforma nel vicino arcigno che bussa alle nove di sera per chiederci di fare silenzio. La maggior parte della raccolta parla però di una solitudine profonda quanto la generosità e rispetto per l’altro, mai corrisposti: “ho una maniacale attenzione per i gusti gastronomici degli amici, e in genere per le loro predilezioni minime, consapevole che a soddisfare le loro aspettative primarie non ce la farò mai”. E poco dopo: “non è il caso di preoccuparsi per me. Io ce la faccio, è notorio”. Ecco com’è appartenere a quella categoria umana che non impietosisce mai perché non chiede nulla e sa coltivare “l’arte di preservare le lontananze”, come scriveva Sergio Bologna in un elogio pubblicato sul Manifesto dopo la sua scomparsa.
Eppure nei racconti originari si legge un moto di apertura verso l’esterno: dalla chiusura e introversione domestica (la casa-lavoro contenitore di solitudini) il rapporto teso col mondo comincia a distendersi già sul balcone, da cui Grazia ascolta una Milano di schiamazzi e motorini scoppiettanti. Su tram e mezzi pubblici il suo sguardo si articola ancor di più, in una specie di “ginnastica del prossimo”, dove singolo e moltitudine riescono sorprendentemente a convivere al di là delle proprie follie (“che cosa furiosamente grande è la vita”). Al parco, in mezzo a persone che non sono dirette da nessuna parte, la generosità rivolta agli amici è la stessa che muove il suo sguardo verso il mondo; in cui, trova, finalmente, appagamento. Proprio perché dal mondo non ci si aspetta molto ed è insieme agli amici che si vorrebbe popolarlo.
In cammino verso un appuntamento, l’io narrante tiene sottobraccio il manoscritto di un esordiente: “si è messo improvvisamente a piovere, una pioggia fitta e aguzza. Il Corriere può finalmente essermi utile. Ma chi riparare: me o l’esordiente?”. È l’approssimazione tra letteratura e vita personale che guida la precisione del linguaggio di Grazia Cherchi. Anche se non è letteraria, la sua vita è votata alla letteratura. Tanto da diventare l’unica lingua con cui comunicare i propri sentimenti.
“Come diceva quello scrittore americano, chi va con i potenti mette il culo in una fionda”.
È il segnale d’inizio del nostro consueto, rapido match a colpi di citazioni.
“La città si è svuotata”, dico mentre sfrecciamo indisturbati, “I pochi rimasti si aggirano soli. E un uomo solo è sempre in cattiva compagnia”.