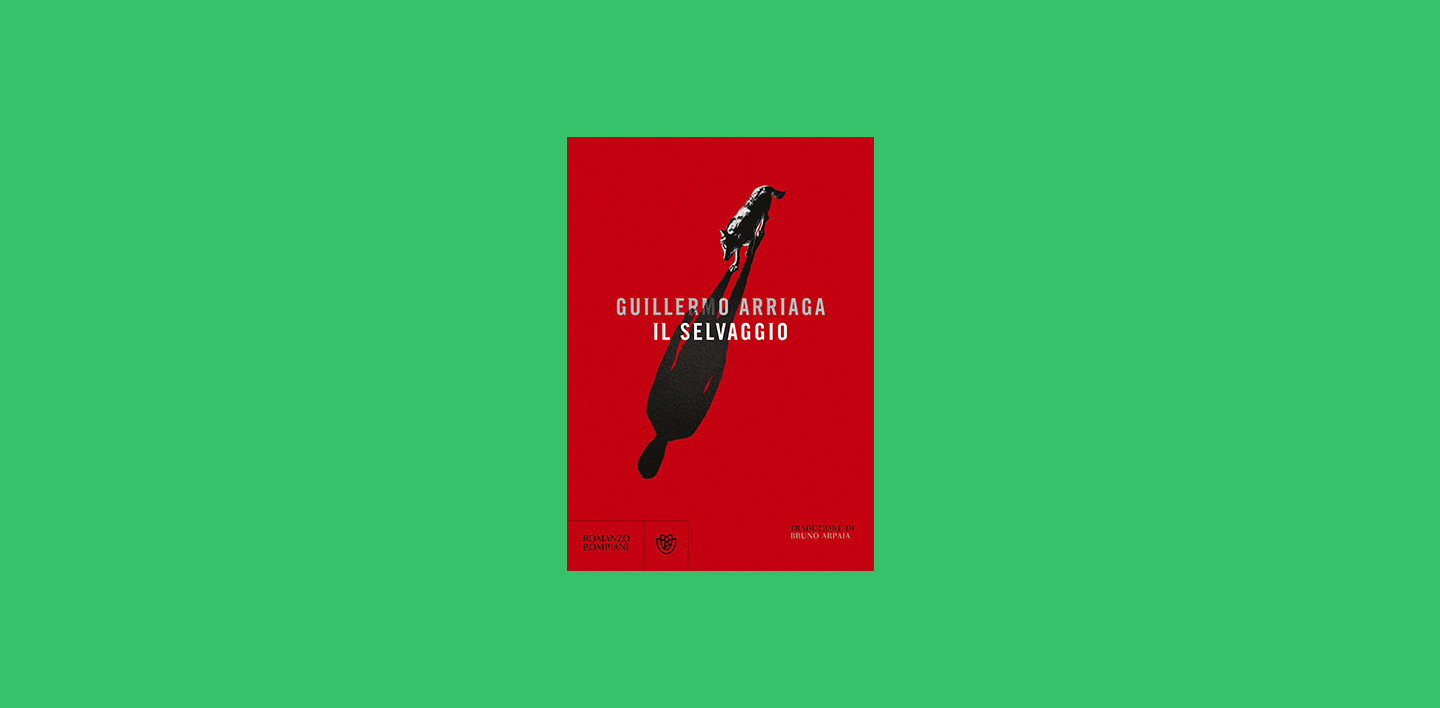
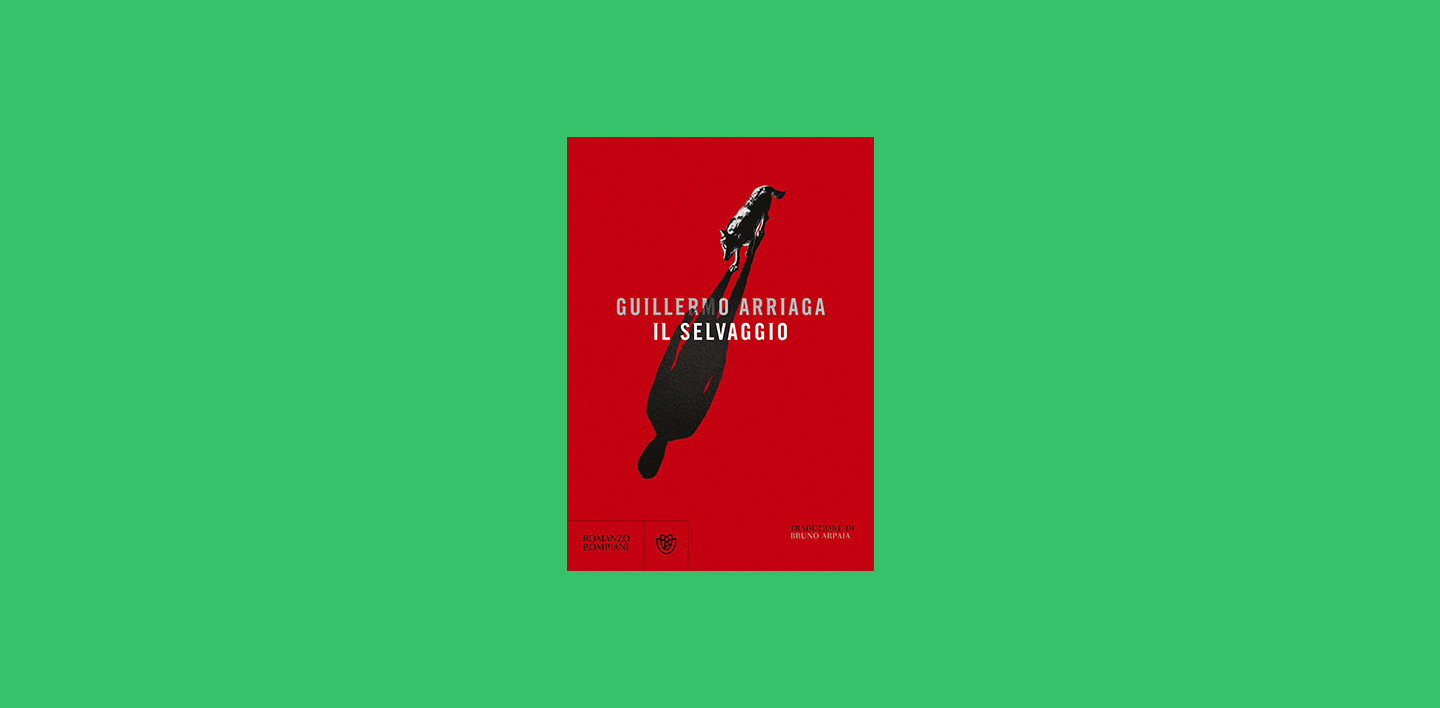
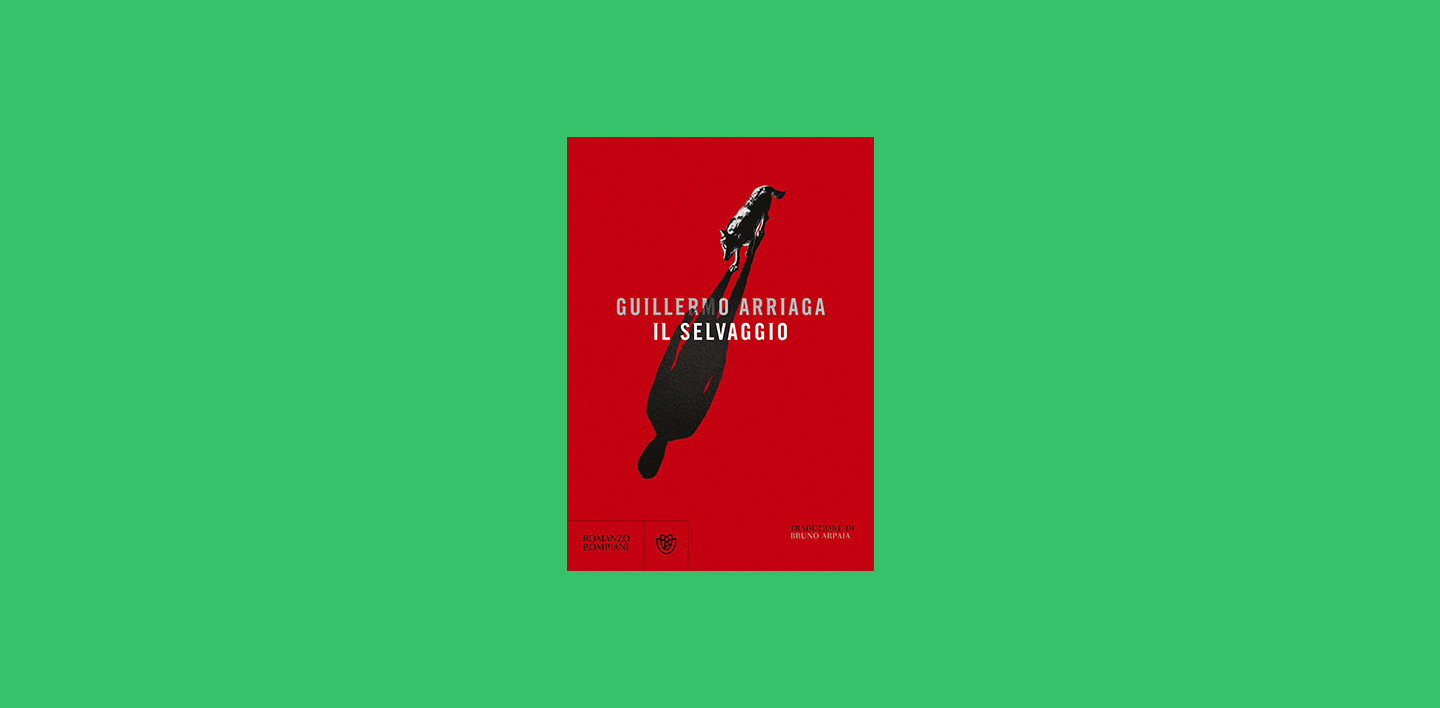
“E quitare, arcum tendere, veritatem dicere”. Potrebbe essere l’esergo ideale per Il selvaggio (Bompiani, 742 pagine, 22 euro), il nuovo romanzo di Guillermo Arriaga. La frase, che è di Erodoto, tradotto da Tacito, si trova in apertura di un altro libro, La mia africa di Karen Blixen, che con Il selvaggio condivide un’idea di giustizia e di vendetta molto diversa dagli standard europei. Anche nel mastodontico e ambiziosissimo romanzo dello scrittore messicano il protagonista – che si chiama Juan Guillermo e con l’autore condivide alcune caratteristiche oltre il nome – è alle prese con un desiderio di giustizia. Guillermo Arriaga, che su Twitter si definisce “bowhunter e writer” – “cacciatore con l’arco e scrittore” – ha colto la sfida di Erodoto, quella cioè di “tendere l’arco e dire la verità”, e dirla su alcune questioni molto importanti: il rapporto tra l’uomo e la natura, i legami di sangue, la fratellanza, la vendetta, l’amore e infine la morte.
Arriaga ha dalla sua un background unico: è cresciuto a Città del Messico negli anni Sessanta in un “retorno” malfamato, nonostante la sua famiglia fosse relativamente colta e lui e il fratello abbiano frequentato, come i due fratelli del libro, una costosa scuola privata, dove erano costretti a parlare in inglese. Da questo mix di alto e basso, delinquenza e letture epiche, ferocia e eleganza stilistica, sono venute fuori le sceneggiature di alcuni film che hanno fatto la storia, in particolare la Trilogia della morte (Amores Perros, 21 grammi, Babel), nata dall’incontro con il regista Alejandro Inarritu. Tuttavia il talento di Arriaga non è solo quello di aver raccontato un milieu fuori dal comune. È un talento granitico e molto hemingwayano, un talento della costruzione, dell’architettura – che sia di un film o di un libro (del resto lui i suoi film li chiama “romanzi per immagini”) – la capacità di mescolare piani geografici o temporali lontanissimi fra loro.
Se è vero che un racconto è fatto di scrittura e un romanzo soprattutto di architettura, leggendo Il selvaggio viene da pensare a un’impalcatura piena di ripiani, tutti collegati e tutti mirabilmente in equilibrio. Qui, oltre alla storia “messicana” – quella di un ragazzo di diciassette anni che rimane orfano di tutta la sua famiglia e si mette in testa di vendicarsi – e quella “canadese” – la storia di Amaruq, un uomo il cui destino si lega indissolubilmente a un lupo nei boschi dello Yukon – Arriaga inserisce continue digressioni sui rituali, usanze, testi sacri, di antropologia, di filosofia, una specie di compendio – ma sempre strettamente connesso all’azione – sulla vita, sul sesso, sulla morte. Se c’è un difetto in questo romanzo che è seducente in ogni sua parte, è semmai la prosa, soprattutto nella parte finale un po’ troppo descrittiva, una scrittura che spiega troppo, il difetto tipico di chi è abituato a scrivere per il cinema.
Qualche anno fa intervistai Guillermo Arriaga, in occasione dell’uscita italiana del suo unico film da regista (The Burning Plain- Il confine della solitudine) che fu sostanzialmente stroncato dalla critica. L’intervista, durante la quale era lui a fare domande a me (“Dimmi se conosci un altro scrittore che è diventato regista? A me non viene in mente nessuno”), non uscì mai, ma da allora attendo il romanzo di cui mi parlò su quel terrazzo romano. “È una storia nera, più nera e violenta di quello che ci si può immaginare, come Gomorra, parla della mafia di Città del Messico”. Del resto se eri fra quelli che avevano letto Il bufalo della notte (Fazi Editore), un noir teso e poetico, desideravi leggere di più. Arriaga all’epoca mi disse che gli piacevano “i personaggi che sono al confine di qualcosa, che vivono in una situazione estrema”.
Disse che era attratto dai “confini perché lì qualcosa inizia e qualcosa finisce. E anche le cicatrici: sono il confine metaforico tra vita e morte, che come l’idea di frontiera geografica è al centro del mio lavoro. Tra l’altro l’immigrazione sta cambiando completamente gli scenari. I confini stanno cambiando, il mondo sta cambiando”. Era il 2008. Da allora il mondo è cambiato davvero e Arriaga si è dedicato a scrivere il suo romanzo-mondo pieno zeppo di cicatrici e personaggi estremi. “Sono cresciuto in uno strano posto, nei sobborghi di una grande città, sì, eppure era una vita a contatto con la natura: c’erano questi enormi campi da calcio pieni polvere e bestie. Poi pioveva e diventava fango”. Come diceva il protagonista del Bufalo della notte: “Prima che esseri umani, siamo animali. E molto prima siamo demoni”. Se una frase del genere la scrivesse un altro scrittore contemporaneo, suonerebbe un po’ falsa, eppure a Guillermo Arriaga, cacciatore e scrittore, noi crediamo e sospendiamo senza sforzo l’incredulità quando il suo protagonista diciassettenne alterna la lettura dei classici alle flessioni e dialoga così con i mostri sacri della letteratura:
Faulkner scrive: “Fra il dolore e il nulla, preferisco il dolore.” Ah, sì, Faulkner? Preferisci il dolore? Vieni, stronzo, e sopporta il mio dolore. Caricati sulle spalle questa tonnellata di morti. Ti schiaccia. Vieni, Faulkner, esci dalla tomba, su. Ti aspetto seduto qui, signorino del Sud americano. Andiamo a tuffarci insieme nel pantano del dolore e poi ne parliamo.(…)
E tu, Shakespeare, con il tuo Amleto smidollato che esita a vendicarsi. “To be or not to be.” Essere o non essere. Leggi Spinoza, Shakespeare, ti farà bene, risponderà alla tua domanda. Leggi Borges, il tuo trisnipote cieco. Essere o non essere. Essere, caro Shakespeare. Sempre essere.
E tu, Rulfo, che ti vanti che i tuoi morti ti parlino. Certo che i morti parlano. Se notte dopo notte sento i miei mormorare. I loro sussurri rimbalzano sulle pareti. Non mi fanno dormire.
Dopo che ha terminato le sue letture, il ragazzo si mette a fare i piegamenti, carica il cane in braccio e sale e scende le scale sessanta volte. “Ho bisogno di forza. La vendetta attende là fuori”, dice. Perché è chiaro che Juan Guillermo, come anche Amaruq, tra il dolore e il nulla preferiscono il dolore, preferiscono permanere, lottare, liberare, in una parola, vivere. Il selvaggio non è altro che un grande libro sulla morte. Che finisce con la parola “vita”.
L’autore sarà in tournèe in Italia dal 2 al 12 maggio (Perugia, Ravenna, Roma, Milano, Torino).