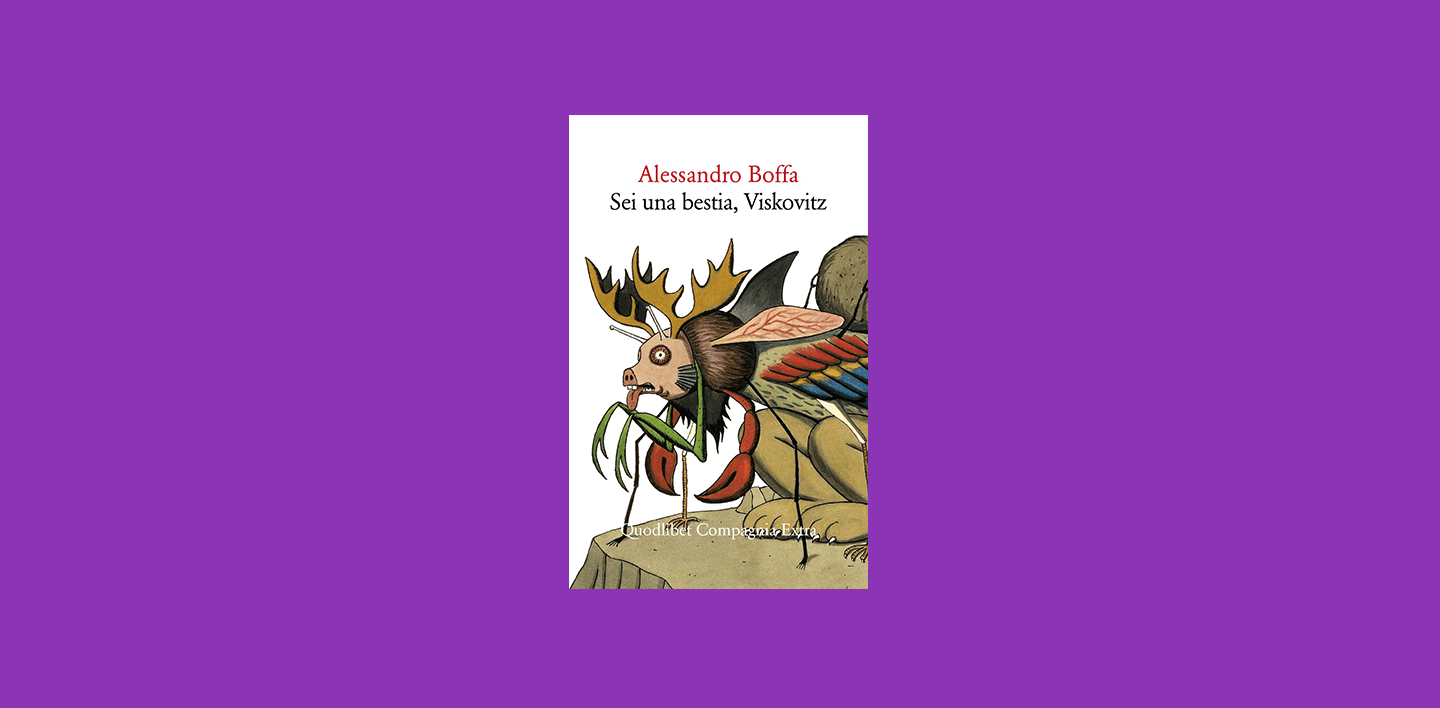
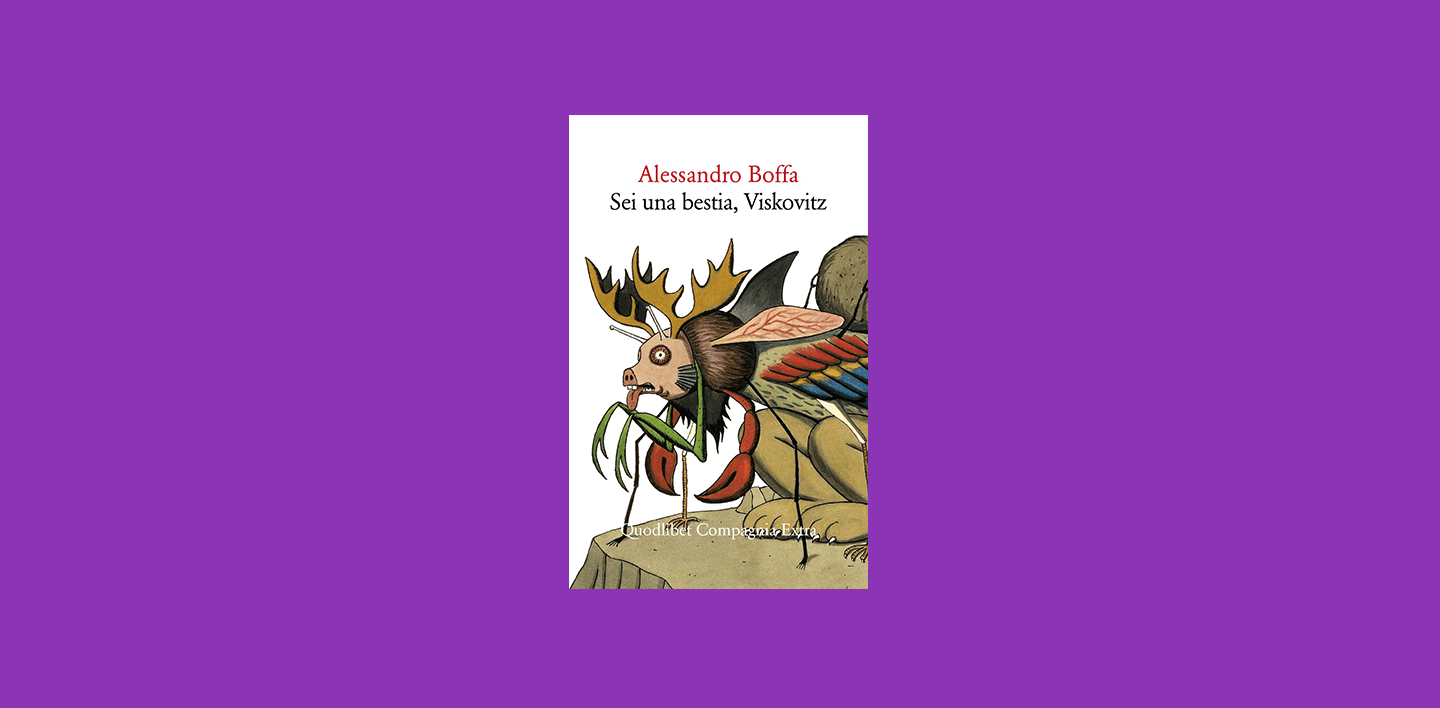
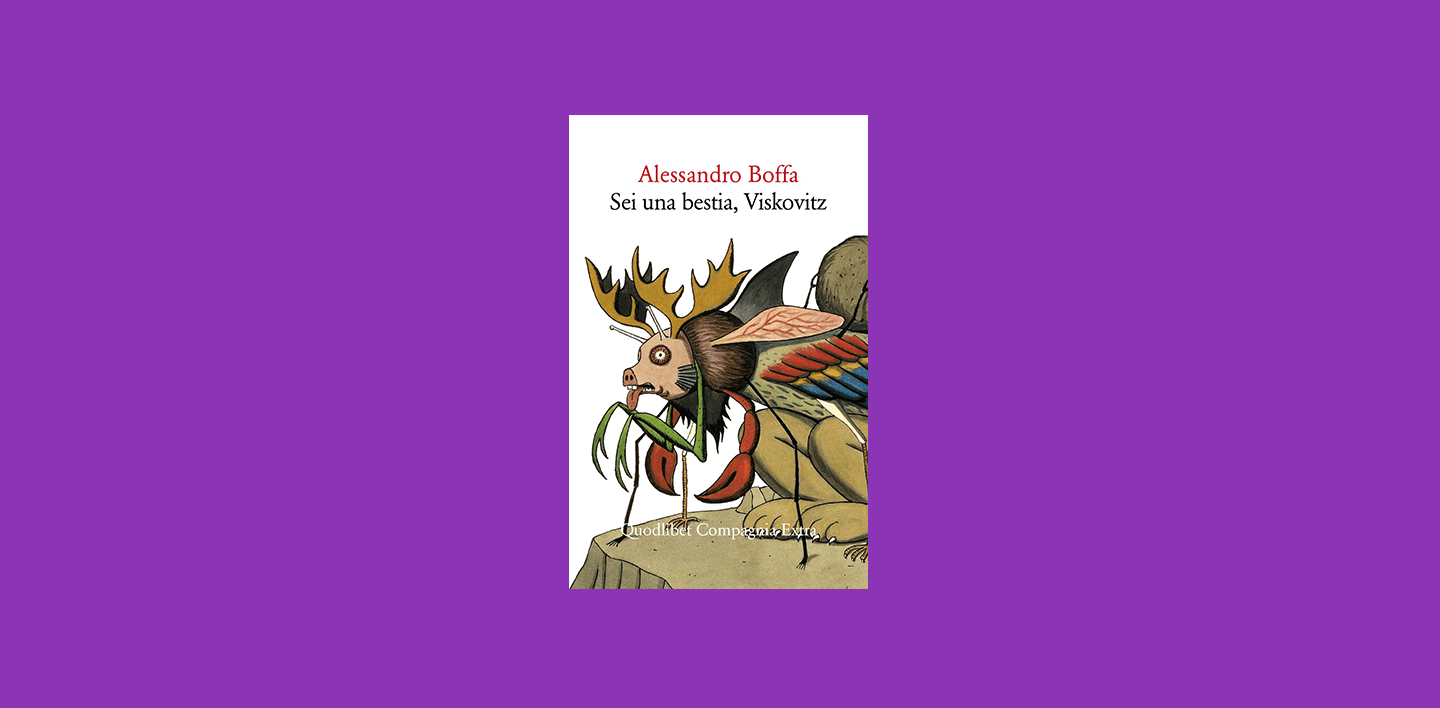
S ei una bestia, Viskovitz è uno strano caso letterario, strano ergo perfettamente a suo agio nella collana “Extra” diretta da Ermanno Cavazzoni per Quodlibet. Altrettanto peculiare mi sembra il profilo dell’autore, Alessandro Boffa, non foss’altro per la penuria di informazioni al suo riguardo reperibili in rete o nelle cerchie di addetti ai lavori. Eppure, il risvolto di copertina ci dice che il suo unico (credo) libro, pubblicato per la prima volta da Garzanti vent’anni fa, nel frattempo, prima di approdare alla nuova edizione della suddetta collana, è stato tradotto in una ventina di lingue. Vista la condizione così anomala e (almeno in Italia) poco esposta dello scrittore, e venuto a conoscenza, sempre dal risvolto, del suo essere tornato, dopo varie esperienza all’estero, in quel di Roma, avevo pensato potesse essere una buona idea intervistarlo. Poi ci ho ripensato: perchè strappare all’incognito una così bella eccezione agli imperativi della visibilità? D’altronde il poco che si trova in rete è più che sufficiente a tratteggiare l’immagine di un autore sfuggente, beatamente marginale.
Intanto una foto, una sola: un uomo sulla quarantina, espressione serena, corporatura robusta, seduto a terra mentre sembra giocare con un cammello in un bianco e nero leggermente sgranato. Quindi una nota di presentazione e d’intenti, redatta dallo stesso Boffa, pubblicata sul sito dell’editore americano Random House. Questo testo ci introduce agilmente alla sua prima (e unica?) opera. Scopriamo dunque che Boffa dopo avere lavorato in un laboratorio come biologo “titillando rane e ratti per raccogliere le loro uova e semi” è passato alla ricerca scientifica sul cervello umano con modelli matematici. “Pensare continuamente al pensiero”, tuttavia, lo stava rendendo matto, per cui ha cambiato nuovamente occupazione. Dopo avere fatto dei soldi in borsa – così scrive – si è dato alla macchia: dieci anni in Asia orientale. A Bangkok si è messo a studiare gemmologia e a trafficare in pietre preziose, poi ristoratore in una piccola isola tailandese. C’è anche un anno in California (e una nascita in Russia) di cui però non sappiamo nulla.
Sei una bestia, Viskovitz sembra unire felicemente i suoi passati interessi scientifico-naturalistici alla conoscenza dell’uomo che Boffa deve avere maturato nel corso della sua vita erratica. Il libro consiste in una raccolta di racconti i cui protagonisti sono tutti animali parlanti (e narranti), che interpretano gli stessi personaggi (almeno sul piano nominale): Viskovitz, protagonista e voce di ogni novella, Ljuba la femme fatale che Viskovitz incontra sotto diverse sembianze, qualche altro compagno di specie dai nomi slavi. I diversi animali in cui Viskovitz si incarna (ma Boffa credo contesterebbe la scarsa precisione del termine) compongono un’ampia palette che spazia dai micro organismi agli insetti, fino ai pesci e ai grandi mammiferi. Animato da uno spirito ludico e sperimentale, molto dell’interesse del libro dipende dal modo in cui dettagli etologici ed entomologici vengono usati per generare situazioni grottesche e paradossali. Il gioco si esprime anche in un certo gusto lessicale (“la voce che si levò dalle mie spinule”, “le carezzai i lobi dermici”) capace di toccare momenti di (coraggiosa?) demenzialità ma anche di raggiungere esiti di sbriciolamento percettivo o di estetica dell’informe, per così dire, che potrebbero non dispiacere agli antispecisti. Penso alle avventure della spugna o del microbo Viskovitz, pagine che mi hanno ricordato certe visionarie invenzioni calviniane (nelle Cosmicomiche), ma in una chiave allegramente cinica, decisamente poco calviniana.
Boffa usa le sue creature inumane per comporre quadretti misantropici e se, oltre a umanizzare gli animali, animalizza l’uomo, pare farlo nel senso meno lusinghiero del termine.
Ciò detto, il genere a cui Boffa sembra ispirarsi non credo abbia molto a che fare con quell’“animalizzazione” in cui il critico Debenedetti riconosceva un tratto importante della letteratura del novecento. Gli animali di Boffa non servono tanto a sbarazzarci della nostra limitata prospettiva umana. Boffa sembra piuttosto collocarsi nel filone moralista di animali parlanti che dalla favolistica antica arriva fino alla Fattoria di Orwell, pur non mancando di una sua originalità. L’operazione sembra consistere sostanzialmente nel prelevare, non senza una certa pignoleria naturalistica, aspetti “altri” o comunque “difformi” della vita animale (non a caso predomina l’entomologia con le sue bizzarrie biologiche) utilizzandoli per descrivere l’uomo, per lo più nei suoi lati nefandi e deteriori. L’effetto comico che scaturisce da questa lettura dipende dal fatto che nel discorso dei vari Viskovitz tutte quelle difformità risultano ovviamente normali, almeno ai narratori. Normale che la mantide femmina divori il maschio, o che lo squalo uccida con estrema disinvoltura, o che la lumaca abbia due organi sessuali. Boffa usa le sue creature inumane per comporre quadretti misantropici e se, oltre a umanizzare gli animali, animalizza l’uomo, pare farlo nel senso meno lusinghiero del termine. Perché le bestie, così pensa l’autore, poco hanno da invidiare agli uomini.
Una visione irrimediabilmente nera sottende questi racconti, che tuttavia fanno ridere, cosa nient’affatto comune, né facile, in letteratura. C’è un umorismo amaro e allo stesso tempo aperto, giocoso, gustoso, in ognuna di queste piccole parabole. Il catastrofismo delle povere vite animali è sempre stemperato da un’affranta ma inscalfibile vis comica e satirica. Le note umoristiche sono quasi sempre efficaci, intonate al resto del racconto, graffianti, non compiaciute. Se si aggiunge che molto del riso deriva da una visione a dir poco drammatica del sesso e dei rapporto tra i generi (Ljuba e la sua ipnotica bellezza, davanti a cui si agita inutilmente la smania erotica dei poveri maschi), l’insieme potrebbe far pensare a un Louis C.K. che si sia messo a narrare degli apologi esopiani.
Sempre nell’autopresentazione per Random House, Boffa dichiara di aver colto nella scrittura un tratto simile alla struttura di certe lingue asiatiche che consentono di parlare di sé in terza persona, cioè di smarcarsi, in certo senso, dalla propria esperienza: “La differenza tra il tragico e il comico è il punto di vista: i tuoi tormenti sono tragici, quelli di un altro comici”. Gli animali di Boffa sono un modo di tradurre in terza persona, e quindi rendere comica, una visione catastrofica della vita:
Ridere diventa una sorta di esercizio spirituale. Credo che ogni storia tragica abbia una “traduzione” comica. Per me, la buona commedia, la risata che supera la tragedia, è la più alta forma d’arte, e i buoni comici sono dei santi.
Ignoro quanta santità Boffa sia disposto ad attribuire a se stesso. Non credo molta però: dopo avere ribadito che in fondo tra uomini e animali la differenza non è così netta, poiché: “come mostra il nostro album di famiglia, poco tempo fa i nostri nonni sembravano scimpanzé, 70 milioni di anni fa topi e 500 milioni di anni fa pesci. Tutti quei tratti sono ancora presenti nella famiglia. Piaccia o no, il nostro DNA non è così diverso da quello di un pollo. E il DNA ci ritrae abbastanza bene”; dopo averci rammentato le nostre origini evolutive, lo scrittore conclude, non senza coerenza, che “questa è probabilmente la ragione per cui sto iniziando a odiare gli animali tanto quanto gli umani, e credo che il mio prossimo libro riguarderà i robot.” Ho il sospetto che Boffa, nel frattempo, si sia accorto che i robot possono risultare altrettanto odiosi degli umani.