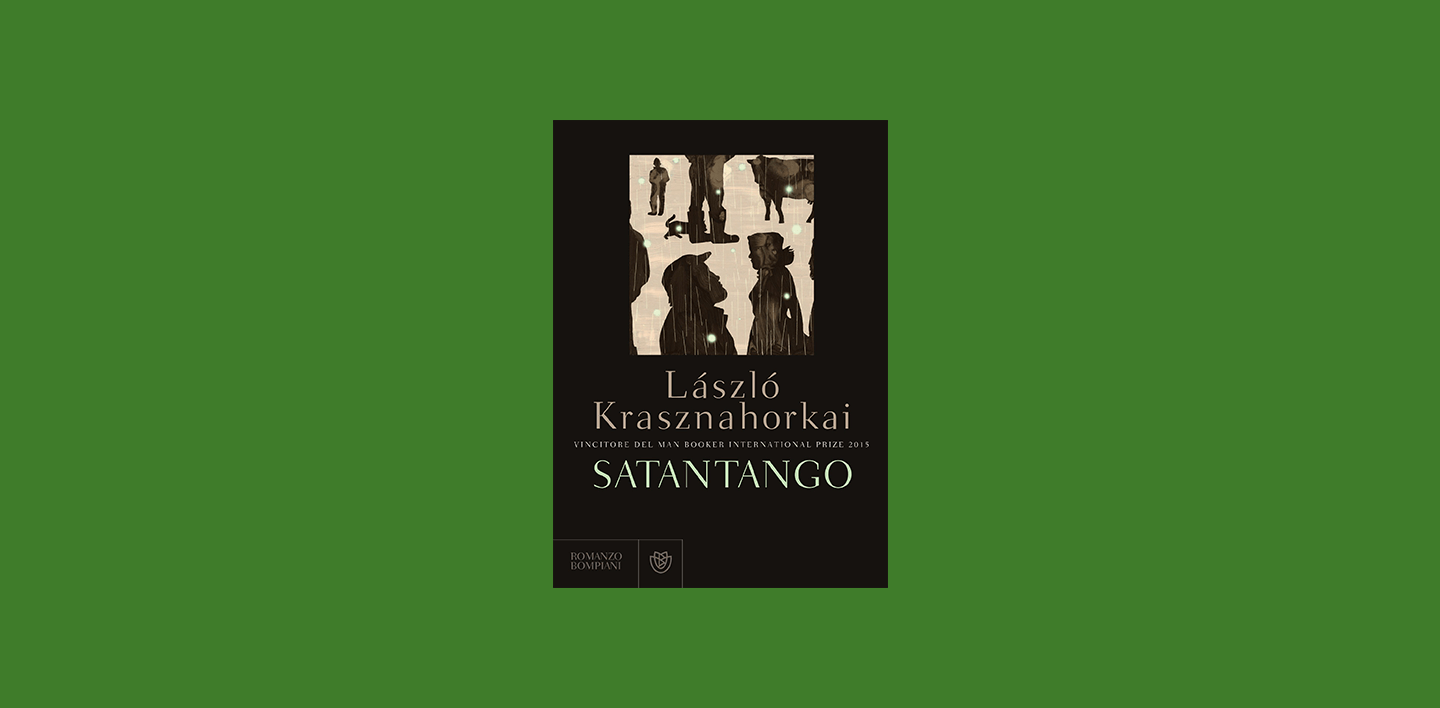
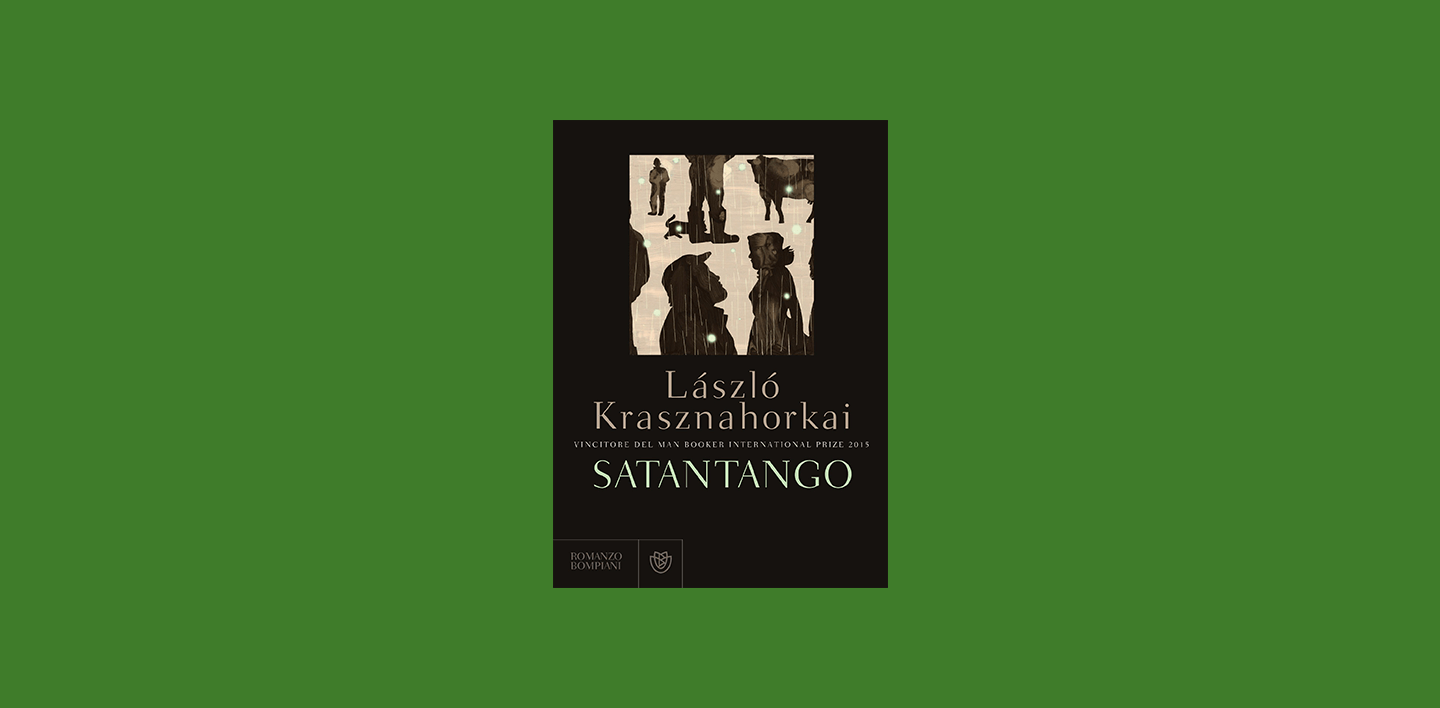
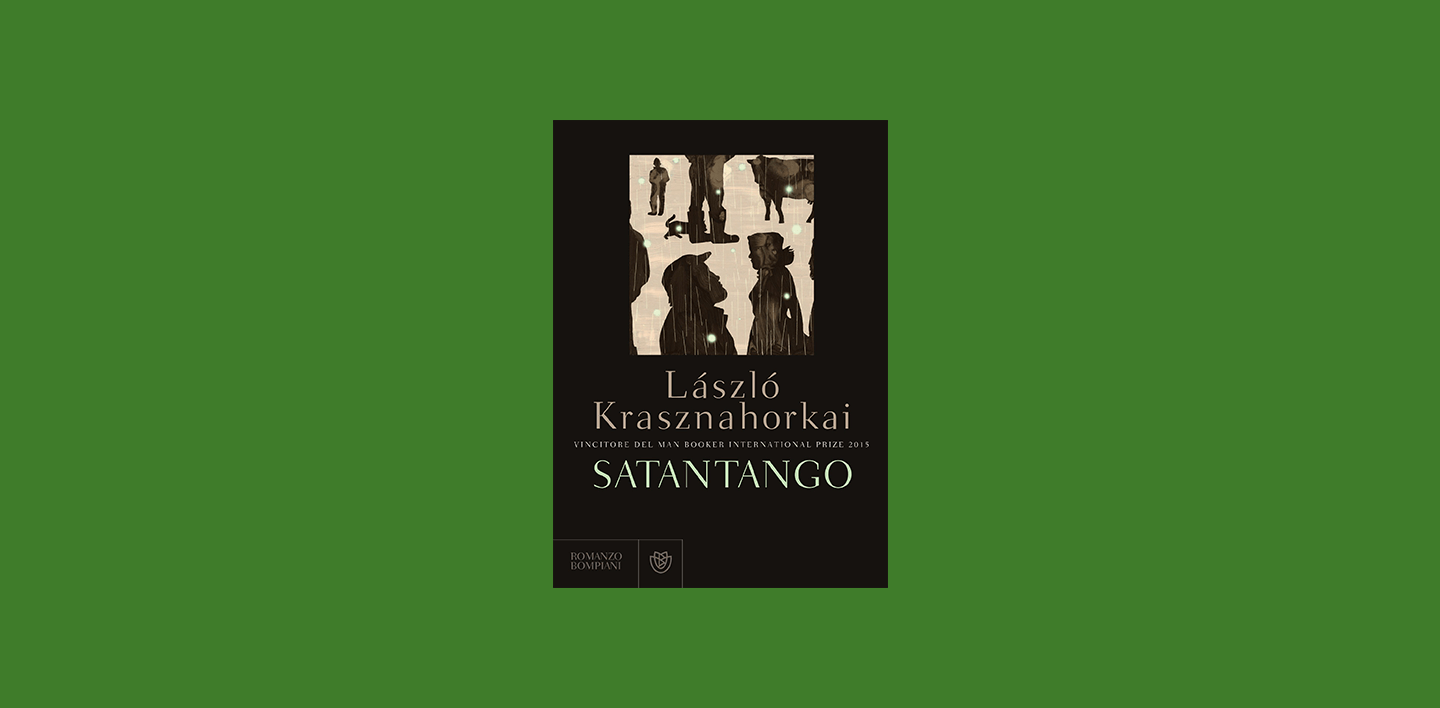
L e logiche dell’editoria sono un mistero insondabile, perché è davvero difficile capire come uno dei libri fondativi della letteratura ungherese del secondo Novecento abbia percorso un così tortuoso cammino prima di poter vedere la luce fuori dai confini del proprio paese. È stato impossibile infatti leggere Satantango, l’esordio letterario dell’autore magiaro László Krasznahorkai – se non nella sua versione originale ungherese – fino al 2012, grazie alla traduzione in inglese premiata con il Man Booker International Prize, che ha favorito la pubblicazione italiana del libro da parte di Bompiani solo a fine 2016.
Questo vuoto editoriale di trentun anni è stato colmato in parte dal riadattamento cinematografico del 1994, sceneggiato dallo stesso Krasznahorkai e diretto dal connazionale Béla Tarr, che ha trasformato l’oggetto filmico Satantango in un’opera di culto. Un monstrum dalla durata di 432 minuti (sette ore) che rappresenta forse l’unico esempio di trasposizione cinematografica più difficile da affrontare rispetto alla sua controparte cartacea. Rivisti oggi, i suoi interminabili piani sequenza al limite della staticità, risultano una perfetta resa audiovisiva della densa struttura ipotattica che irradia il romanzo di Krasznahorkai. Una “lenta colata di lava narrativa” come l’ha saggiamente definita l’autore della celebrata traduzione inglese George Szirtes, in un’intervista che mette in luce il rapporto di reciproca fiducia tra lo scrittore ungherese e il suo traduttore (una sinergia per certi versi affine a quella tra Italo Calvino e William Weaver).
In maniera simile al film di Tarr, l’opera di Krasznahorkai prende le mosse da un’indagine-rappresentazione metafisica del tempo che tesse la sua ragnatela sull’intera superficie del romanzo, muovendo i fili di ogni suo personaggio. Tutto si risolve in un vortice di ricorsività all’interno di un gioco di scatole cinesi che nasconde alla vista il concetto di “tempo”, ponendolo contemporaneamente al centro della sua riflessione. D’altronde in un indovinello che ha come oggetto gli scacchi – scriveva lo scrittore argentino Jorge Luis Borges – difficilmente leggeremo la parola “scacchi”. Questo è fondamentalmente Satantango, un grande indovinello, o parabola, sul tempo: in una dimensione atemporale dominata da una pioggia incessante, attorno al non luogo dello “stabilimento” (una fattoria collettiva ormai in disuso nel cuore della grigia campagna ungherese), gravitano gli inetti burattini di Krasznahorkai, un “esercito disperato, disperso e sconfitto” in perenne attesa di un miracolo.
Quelli stanno seduti nello stesso identico posto, sullo stesso identico sgabello appiccicoso, si strafogano di patate alla paprika tutte le sere e non riescono a capire cosa possa esser successo. Si osservano sospettosi gli uni gli altri, ruttano forte nel silenzio e aspettano. Aspettano ostinati, tenaci, costanti, pensando di essere stati semplicemente raggirati. Aspettano acquattati, come i gatti durante la concia del maiale, nella speranza che gli tocchi qualche osso. Questa gente è uguale ai servi dei castelli di una volta: il signore tutto a un tratto si sparava, e loro rimanevano lì, aggirandosi smarriti intorno al cadavere…
Lo scrittore si dilunga in descrizioni di disfacimento generale, e proprio su questo riflette il dottore, personaggio chiave del romanzo dietro cui si cela lo stesso Krasznahorkai:
Da quel giorno aveva capito di essere troppo debole per poter fermare da solo l’avanzata trionfale della rovina, per quanto avesse potuto dimenarsi e affaccendarsi non sarebbe stato in grado di contrastare quella forza che stava demolendo e imputridendo tutto: le case, i muri, gli alberi e la terra, gli uccelli che planavano dall’alto e le bestie che strisciavano sul suolo, i corpi umani, i desideri e le speranze; non poteva opporsi, e se anche ci avesse provato non ne sarebbe stato capace, non era possibile fermare quel subdolo attacco alla creazione umana.
Finché un giorno il tanto vagheggiato Godot compare finalmente sulla scena, introdotto da uno spettrale scampanio dall’origine ignota. Gli ex compagni Irimiás e Petrina, creduti morti da tutti, sono finalmente ritornati a casa. Questa coppia subdola e scalcinata, a metà strada tra il Gatto e la Volpe collodiani e il truffaldino Čičikov de Le anime morte di Gogol’, è venerata come una figura messianica (in particolar modo il più scaltro Irimiás) dagli abitanti dello stabilimento, che dopo il loro arrivo affidano fideisticamente nelle mani dei due imbonitori il destino dell’intero villaggio. Irimiás e Petrina sono in realtà anch’essi dei vinti, un piccolo ingranaggio all’interno di una misteriosa macchina burocratica che muove in loop le esistenze soggiogate di quella grottesca umanità.
Con il movimento circolare del suo romanzo Krasznahorhai sembra ripercorrere quelle ipotesi di “romanzo infinito” che quarant’anni prima avevano suggestionato proprio Jorge Luis Borges. Lo scrittore argentino in uno dei suoi racconti più famosi, Il giardino dei sentieri che si biforcano, pubblicato all’interno di Finzioni (1944), rifletteva, giocando come al suo solito in maniera erudita con il genere policial, sul “mistero diafano” celato nell’insensato libro dello scrittore Ts’ui Pên. Il romanzo inventato da Borges, ispirato dalle teorie della meccanica quantistica, era un libro labirintico che biforcava simultaneamente tutti i piani temporali delle diverse alternative in cui si imbatteva il protagonista, una proliferazione pressoché infinita di futuri che rendeva il libro inestricabile e apparentemente contradditorio. Questa scoperta era il risultato di un lungo tentativo di esegesi mosso dall’intuizione che l’opera avesse a che fare con l’idea di infinito:
M’ero chiesto in che modo un libro potesse essere infinito. Non potei pensare che ad un volume ciclico, circolare: un volume la cui ultima pagina fosse identica alla prima, con la possibilità di continuare indefinitamente. Mi rammentai anche della notte centrale delle “Mille e una notte”, dove la regina Shahrazàd (per una magica distrazione del copista) si mette a raccontare testualmente la storia delle “Mille e una notte”, a rischio di tornare un’altra volta alla notte in cui la racconta, e così all’infinito.
Proprio da questa prima ipotesi circolare e “sharazadiana” de Il giardino dei sentieri che si biforcano sembra partire l’autore ungherese per la costruzione dell’infinito Satantango. L’apocalittica atemporalità del libro di Kraszmahorkai dà vita a un universo in cui le “magnifiche sorti e progressive” si annullano nella chiusura circolare del tempo, e dove non è difficile intravedere chiari riferimenti al contesto sociale del regime tardo sovietico prossimo alla dissoluzione. Quella del socialismo reale è una visione di matrice antistorica, incapace di produrre vere modifiche nel tessuto immobile dell’esistenza, il cui unico orizzonte possibile è l’”eterno ritorno” zarathustriano.
“I due orologi,” il più alto dei due uomini tranquillizza il compagno, “misurano in realtà due tempi diversi, sebbene entrambi con una buona dose di inesattezza. Questo qui” e punta l’indice lungo, magro e affusolato verso l’alto, “è decisamente indietro, mentre quell’altro laggiù… non segna nemmeno il tempo, bensì misura l’eternità dell’assoggettamento, e ci riguarda né più né meno di quanto la pioggia riguardi un ramoscello: siamo impotenti nei suoi confronti.”
Futaki è l’unico tra i personaggi del libro ad avvertire il senso di predeterminazione che avvolge “la placida, in quanto ripetitiva, quotidianità” degli esseri viventi, ma non può fare nulla, si limita caparbiamente “a scrutare il cielo sopra di sé” cercandone una fine, “seppure in un punto lontanissimo”. Futaki percepisce come in un sogno l’assurdità dell’andamento rettilineo della Storia, senza riuscire però a sviluppare quell’”amor fati” che gli permetterebbe di accettare serenamente la condizione farsesca della vita all’interno di un percorso ciclico. Proprio come tutti i personaggi del libro, e come il surreale K. de Il castello di Kafka (opera amatissima da Krasznahorkai tanto da essere citata proprio in esergo a Satantango), Futaki è solo, alienato e schiacciato da una realtà sfuggente.
Guardò tristemente il cielo funesto, i residui riarsi dell’estate segnata dall’invasione di cavallette, e d’improvviso su un unico ramoscello d’acacia vide passare la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno, e gli sembrò di percepire la totalità del tempo come un inganno farsesco nella sfera immobile dell’eternità, che attraversa la discontinuità del caos creando la satanica finzione di un percorso rettilineo, spacciando tramite una falsa prospettiva l’assurdo per necessità. […] Aveva sempre giocato con bari contro cui non era possibile vincere, essendo tutte le carte del gioco predeterminate: si trattava di una partita truccata alla fine della quale sarebbe stato privato anche dell’ultima sua arma, la speranza.
In un quadro esistenziale del genere non può esserci alcuna prospettiva escatologica né un ripiegamento intimo e consolatorio nella religiosità. Satantango, ancora più di Stalker, la rilettura cinematografica di Andrei Tarkovskij dell’opera fantascientifica Picnic sul ciglio della strada (1972) dei fratelli Strugackij, è un mondo che non contempla neanche la possibilità di Dio. L’universo distopico creato dal regista russo aveva almeno nella Zona l’unico spazio di ricerca trascendentale, osteggiata all’esterno dal regime e dalla sua intellighenzia senz’anima.
Questo non esula comunque la prosa di Krasznahorkai dal muoversi sul confine tra reale e surreale (soprattutto nella sua dimensione onirica) con pennellate di realismo magico di scuola sudamericana. Ecco allora l’apparizione fantasmatica della piccola Estike, le ragnatele che si moltiplicano fino a ricoprire tutta la “kocsma”, le sinistre melodie che accompagnano le camminate notturne dei personaggi, o le già citate campane misteriose. Più che una timida apertura verso il trascendente, quella di Krasznahorkai risulta invece una vivace e terrena esaltazione dell’infinita forza creatrice del racconto.
Intorno al corpo si alzò il vento, e in perfetto silenzio il cadavere bianco accecante iniziò a levitare vibrando sopra il terreno… si alzò fino a raggiungere l’altezza delle più alte fronde delle querce, poi oscillò, si abbassò con gli spasmi e si posò a terra al centro della radura. Le voci incorporee divennero più forti, e iniziarono un lamento irato come un coro insoddisfatto che senza propria colpa ha fallito. Petrina ansimava. “Tu ci credi a questa cosa?” “Cerco di crederci,” rispose Irimiás, bianco come il muro. “Quella bambina è morta da quasi due giorni.” Tutto a un tratto calò di nuovo il silenzio. Solo il ronzio divenne un poco più forte. Il cadavere iniziò ancora una volta a levitare, a circa due metri sopra la radura oscillò, poi con una velocità incredibile volò in alto e ben presto scomparve in mezzo alle nuvole cupe e immobili.
Questa “vis” si manifesta superficialmente nel flusso narrativo continuo costruito su una struttura frasale ricca di subordinate e incidentali (dove il narratore puntella il testo con la sua sottile ironia), presenti già in abbondanza nell’ungherese in quanto lingua agglutinante, e qui estremizzate dallo scrittore magiaro – e dalla buona traduzione in italiano di Dóra Várnai – fino alla distruzione morfosintattica nell’episodio del sogno collettivo: “erasedutonellafinestradellasalamacchine e nonsapevaseera iltramontoo lalba e lacosanonvolevafini reinessunmodo luistavasedutoenonsapeva cosastavasuccedendofuori noncambiavanullanondiventavanémattina nénottemacontinuava incontinuazioneaessereoiltramonto olalba”.
Il lettore in questo modo è ritmicamente incalzato come davanti a una partitura musicale che nel testo prende la forma della danza circolare che dà il titolo al libro. Collocato al centro esatto dell’opera, il tango dionisiaco che si impossessa degli abitanti del villaggio durante la lunga attesa per il ritorno di Irimiás e Petrina, è allegoria dei continui movimenti narrativi in avanti e indietro; e riflette in un contrappunto di specchi sia la suddivisione dei capitoli (numerati da 1 a 6 nella prima parte de libro, e da 6 a 1 e nella seconda) sia l’intreccio del romanzo, che non può non risolversi in una ripetizione letterale delle prime pagine. È una sorta di evoluzione del classico espediente della “mise en abyme” (l’opera dentro l’opera, come nella rappresentazione teatrale nell’Amleto di Shakespeare), che permette alle parole di esondare dai margini del racconto per riproporre senza soluzione di continuità il momento di fruizione dell’opera. E così all’infinito.