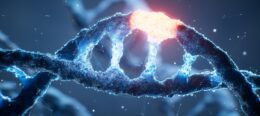L’
opera di Benjamin trasmette in più luoghi la considerazione che il ruolo del narratore attraversi una fase di declino, in primo luogo a causa di uno smarrimento dell’esperienza dell’oralità. In un passaggio del celebre saggio dedicato all’opera di Leskov, Benjamin scrive infatti che “l’esperienza che passa di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto tutti i narratori” ma, nel momento in cui l’influenza della trasmissione della parola vive una forte crisi, è evidente come si smarriscano i presupposti per continuare a farla prosperare: due allora le strade, o lasciare che questo patrimonio finisca di esaurirsi oppure operare una resistenza.
È verso questa seconda possibilità che si spende lo scrittore tedesco e lo fa concretamente scrivendo dei racconti nella prima metà degli anni Trenta, delle piccole novelle, delle favole dal sapore vagamente apologetico, brevi perché immaginate per essere pubblicate su giornali e riviste: si tratta di una resistenza significativa, ancor più se si pensa a ciò che accade in Europa, e attorno a Benjamin, negli anni Trenta. La casa editrice Einaudi ha adesso deciso di pubblicare tutte queste prose in un unico volume, intitolato appunto Racconti, una scelta preziosa perché questi erano dispersi nei vari volumi dell’opera omnia dello scrittore e dunque di consultazione non proprio immediata.
Il lettore o il conoscitore dell’imponente opera benjaminiana (e non solo di quella più speculativa, ma anche quel mondo narrativo che afferisce a Immagini di città, Sull’hashish o Infanzia berlinese) troverà qui dei luoghi che ha già frequentato, resi familiari dallo sguardo acuto e profondo di Benjamin: nei vari racconti si susseguono infatti personaggi strampalati, paesaggi marini sempre a lui cari, flâneur cittadini dall’indubitabile richiamo autobiografico e le città che hanno costellato la sua esistenza. Ma questa serie di racconti serve anche a dare spazio alla sfaccettatura dell’immaginario benjaminiano di cui si dava conto poco sopra, poiché nascono proprio dalla considerazione di un declino dell’oralità e dell’arte di raccontare storie. C’è un racconto in particolare proprio su questo tema. Si intitola “Il fazzoletto” e si apre proprio con un’interrogazione del narratore, che passeggia sul ponte di una nave in procinto di salpare da Barcellona mentre scruta la terraferma con un binocolo, una domanda che ricorda assai da vicino gli interrogativi di Benjamin:
Perché l’arte del narrare storie si stia estinguendo è una domanda che mi ero già posto spesso, per esempio le sere in cui, seduto con altri invitati attorno a un tavolo, mi annoiavo.
Compare allora in lontananza un personaggio misterioso, il capitano O… , una delle poche facce conosciute al narratore (e molto bella, nonché probabilmente ancora autobiografica, la sensazione di solitudine dettata dalle partenze provata dal narratore: “chi è abituato alle solitarie partenze da città straniere, sa o saprà capire cosa significa la comparsa di una faccia nota, in quei momenti […] mette anche a disposizione un cappello, una mano, un fazzoletto su cui lo sguardo smarrito si possa posare prima di spaziare sulla superficie del mare”): il capitano è proprio un narratore, uno dei maestri di quell’arte che si sta estinguendo, ed è attraverso la sua esperienza che il narratore capisce dove sta uno dei nodi principali del narrare storie, nel contrasto alla noia “che [però] non ha più posto fra le cose che facciamo” e dunque porta alla morte anche le attività ad essa collegate come, appunto, l’inventare storie: in vite votate al continuo impegno la gioia e il tempo per il racconto non esistono più. Una situazione similmente metanarrativa è rintracciabile anche in una delle prose più belle della raccolta, Rastelli racconta…, dove il narratore ancora una volta narra una storia che gli è stata raccontata, una storia che questa volta ha a che fare con un sovrano turco, un gran giocoliere che suona un flauto dall’apparenza magica e un nano suo compagno, il tutto immerso in un’atmosfera leggera, giocosa ed evocativa da Mille e una notte.
C’è poi nei vari racconti quell’attenzione agli oggetti quotidiani e di antiquariato che ha attraversato tutta l’esistenza di Benjamin: la pipa del Capitano O…, “il talismano del narratore” sempre in Il fazzoletto, “il bastone di mogano dall’impugnatura d’argento” in Tracciato sulla mobile polvere, oppure i fichi d’India del racconto La siepe di fichi d’India: tutti questi oggetti quotidiani rappresentano spie di un interesse per figure, come sottolinea Antonio Prete nella sua esaustiva introduzione, capace di inserire compiutamente questi racconti nell’opera di Benjamin, “prossime ad animarsi e prendere il campo che è dei viventi”.
In un suo recente e importante libro, Cose. Per una filosofia del reale (Bollati Boringhieri), Felice Cimatti si è interrogato proprio sulla natura filosofica dell’oggetto, partendo dal presupposto, ovvio, che l’essere umano è in grado di narrare e raccontarsi delle storie, cosa che invece è chiaramente impossibile per gli oggetti che del “linguaggio non sanno cosa farsene” e che entrano nel mondo della parola solo attraverso l’ausilio degli uomini: lì Cimatti cercava di “dare la parola alle cose”, Benjamin attraverso i suoi racconti, e la sua opera più generale, procede in una ricerca che, andando a scavare il vero nome degli oggetti della realtà, sottintende la ricerca di un completo possesso del linguaggio che faccia spazio anche all’oggetto come un essere vivente, come un possibile incubatore di storie a cui al narratore non resta che aprire le porte.
Emerge da questo punto di vista un’altra questione fondamentale che attraversa questi racconti e l’opera di Benjamin, su cui Prete giustamente pone la sua attenzione nella prefazione, e cioè la fascinazione del nome che agisce in Benjamin: “Dal nome scaturisce la vicenda, il nome è sorgente di immagini, e la realtà stessa talvolta può apparire come una resurrezione visiva, materica, luminosa, del nome. Nomi generano l’argomento stesso del narrare” scrive Prete. In questo senso vanno allora anche intesi i nomi di oggetti che popolano questi racconti, nomi di navi e di barche (la Mascotte del racconto “Il viaggio della Mascotte”), di città (numerose sono quelle che si intrecciano nei vari racconti che non hanno confini geografici), di persone, tutto un miscuglio materico che mira ad arrivare al fondo del linguaggio umano dando testimonianza, facendo riferimento ad alcune parole di “Immagini di città”, della “tensione tra nome e realtà”, che si trova all’origine della poesia. Ma dello stesso tenore sono anche le parole del saggio Sulla facoltà mimetica, dove Benjamin scrive che il linguaggio “è un medio in cui emigrarono le più antiche forze di produzione e ricezione mimetica, fino a liquidare quelle della magia”.
Chiudono infine il volume due appendici, una prima dedicata a un pugno di racconti giovanili e un’altra in cui invece sono raccolti alcuni sogni di Benjamin. Quest’ultima sezione in particolare merita attenzione, perché queste pagine costituiscono un’ulteriore prova di quel tipo di scrittura ibrida che è quella dei sogni, affiancandosi così a casi certo più organici e complessi come quello per esempio di Perec o di Tabucchi. Leggendo queste breve annotazioni di Benjamin sul suo mondo onirico continuano a riaffacciarsi i temi dei suoi racconti, come se gli uni e gli altri vivessero di questa struttura continua, come in un certo sogno ambientato a Parigi che ripropone la questione del nome e delle cose. In questo sogno Benjamin è talmente vicino a Notre-Dame da non riconoscerla e quindi provare nostalgia per l’immagine di Parigi gli è familiare: si tratta di una nostalgia “beata”, che nasce non dalla lontananza dall’oggetto, ma che invece ha già
varcato la soglia dell’immagine e del possesso e che conosce solo la forza del nome, del quale vive, muta, invecchia, ringiovanisce quel che amiamo e quel che è, senza immagine, il rifugio di tutte le immagini.
In una pagina dei Passages, Benjamin dà allo spazio liminare della soglia un ulteriore significato, esulando dal classico luogo di passaggio e designando invece un posto abitabile in cui è possibile soggiornare e trasformarsi, un posto in cui il dentro e il fuori finiscono per unirsi e diventare indistinguibili: leggendo questa raccolta l’impressione è proprio questa. Walter Benjamin decide di abitare una zona di passaggio che è tale per svariati motivi, dal fatto di costituirsi come prosa narrativa che sfiora la saggistica, al fatto di immergere la materia in uno stato di rêverie fatto tanto di sogno quanto di realtà, ma che è, soprattutto, un’ulteriore prova della limpidezza del suo ingegno e del suo sguardo: tra quelli raccolti c’è un sogno che ha per protagonisti lo stesso Benjamin e il profeta ebraico Daniele: quando i due si incontrano, Benjamin diventa cieco, ma questo non gli impedirà di scendere dal cielo al fianco del profeta verso una città, mantenendo comunque il controllo della rotta. Lì, come nelle pagine di questi racconti, emerge ancora la natura profonda della seconda vista benjaminiana, un occhio in grado di perscrutare ciò che neanche si vede.