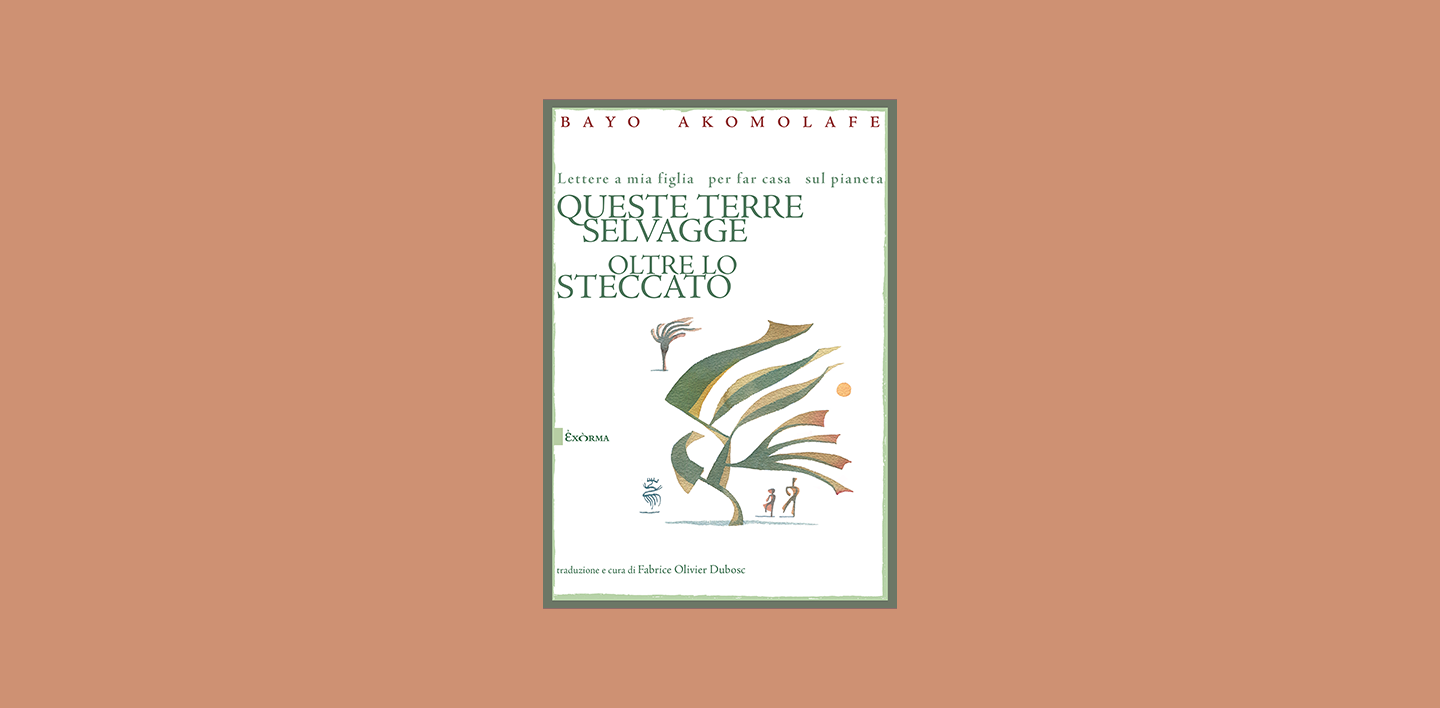
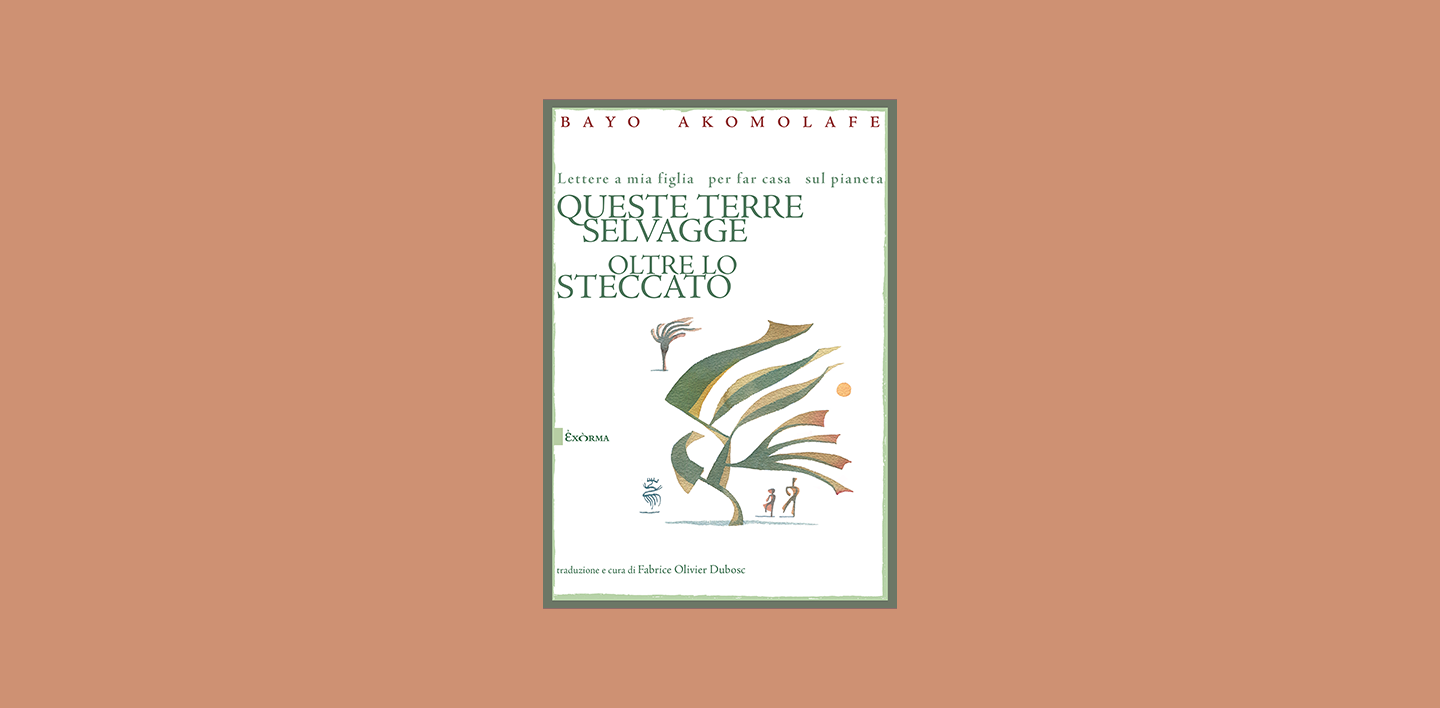
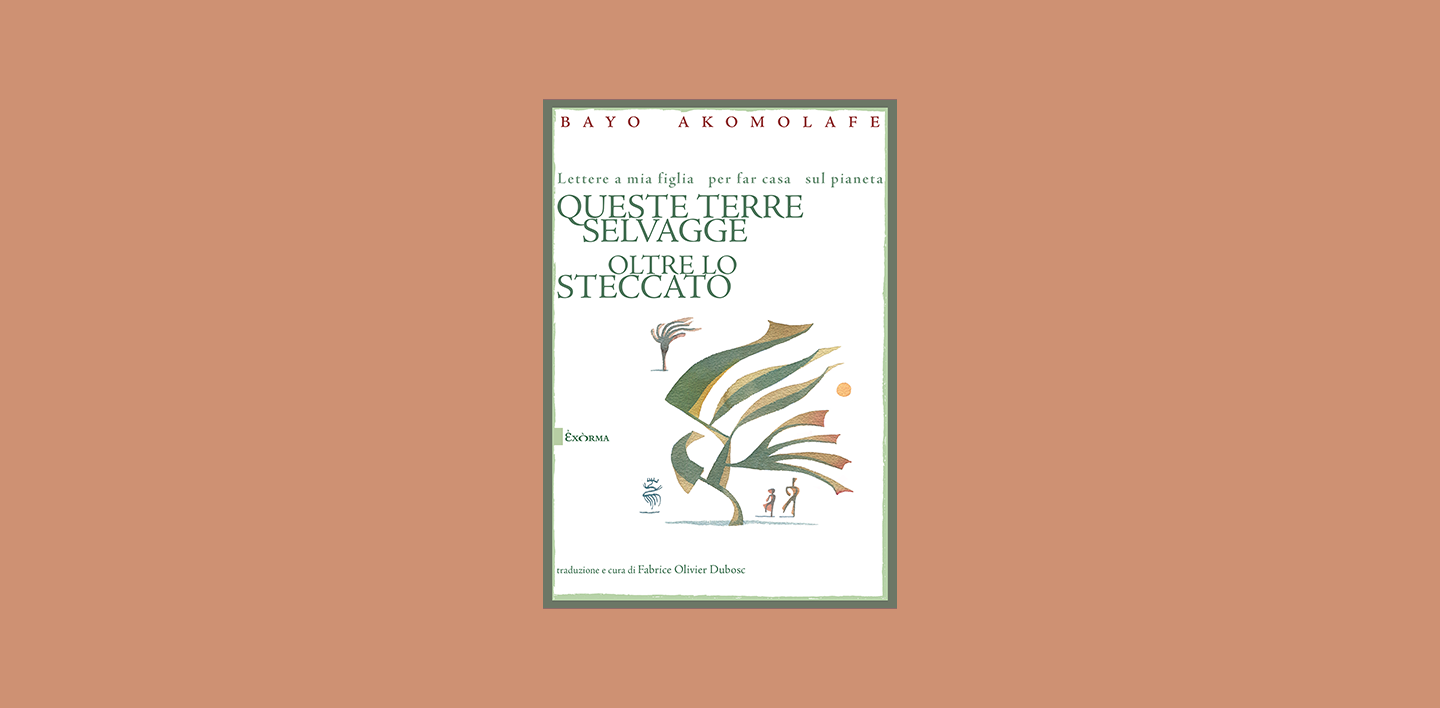
U n giorno imparerai a vivere in un mondo dove le cose si allineano con implacabile coerenza. Un mondo che ci chiede costantemente di svegliarci, di attivare nuovi sensi. Inimmaginabili.” Il passo è contenuto in una delle sette lettere che compongono Queste terre selvagge oltre lo steccato, opera prima del filosofo Bayo Akomolafe (Exórma Edizioni, traduzione e cura di Fabrice Olivier Dubosc). Sette componimenti, tutti rivolti alla figlia Alethea, una bambina “non venuta al mondo ma dal mondo”, nel tentativo di trasmetterle un bagaglio di saggezza che può servirle per i tempi a venire.
Dietro la scelta dell’autore di parlare al lettore rivolgendosi a lei c’è un senso di urgenza che trapela dappertutto nel libro. Del resto la vita di Akomolafe, che ha passato da poco i quarant’anni, sembra essersi svolta all’inseguimento di un punto di fuga. Nato a Lagos in una famiglia benestante di fede cristiana, da bambino ha seguito il padre che lavorava come diplomatico in Germania, per poi dover convivere con la realtà della sua morte. Il suo ritorno in Nigeria segna l’inizio della sua vita da adulto. Qui riabbraccia la cultura yoruba alla ricerca delle risposte ai dilemmi fondamentali che lo tormentano e segneranno la sua formazione di filosofo e di poeta.
È un’impellenza di testimoniare senza arrovellarsi troppo sui concetti, e anche la ragione per cui noi, come lettori, cercando di orientarci ci imbattiamo subito in un territorio frastagliato, una geografia decisa da forze primordiali. È un libro policentrico, ma ciò non toglie che la linea di impegno civile e di critica al progresso e alla modernità che Akomolafe porta avanti (in passato l’autore è stato il curatore di libri su diverse questioni sociali legate al colonialismo) risulti ben delineata: capacità che è frutto della conoscenza di quell’Occidente con cui è entrato in contatto grazie all’attività di speaker in diversi centri di produzione culturale e soprattutto avvicinandosi al femminismo di Karen Barad e all’ecologia politica di Bruno Latour e Donna Haraway (si veda l’articolo di Valeria Marzano qui sul Tascabile).
Akomolafe riesce a coniugare registri e piani speculativi diversi, spostando continuamente i piani del discorso, aspirando non tanto a produrre una sintesi, quanto un concerto. Qui la riflessione teorica viene accompagnata da memoir familiare, racconto e lirismo poetico. Basta vedere come l’autore sviluppa una delle idee germinali alla base del libro quando si addentra nel tentativo di aggiornare la teoria antropocenica dei suoi colleghi-maestri.
Akomolafe riesce a coniugare registri e piani speculativi diversi, aspirando non tanto a produrre una sintesi, quanto un concerto.
Lo stato di crisi permanente dell’Antropocene, o del Capitalocene, può essere superato attraverso una forma di riorganizzazione del vivente. Gli stimoli dati dall’incontro della saggezza e della vitalità propri delle civiltà africane possono farsi carico di traghettare l’umanità verso un’epoca che Akomolafe, non a caso, chiama Afrocene.
L’Afrocene va inteso come un cambio di ritmo e delle attitudini verso i fatti del presente. È l’inizio di un allargamento del nostro essere ad abbracciare altre forme di vita e una presa di coscienza delle interconnessioni che abbiamo con il mondo. Quanto alle crisi sistemiche in corso, non si tratta di contrastarle, né di passare indenni attraverso di esse. È necessario usarle come delle occasioni di trasformazione. Rivolgendosi alla figlia nel lessico danzante proprio dell’Afrocene: Stiamo gradualmente iniziando a capire che le cose che chiamiamo intoppi sono inviti a mutar forma. (…) Il mondo ha bisogno del tuo volo per depositare polline in campi vergini; ho bisogno che tu molli quell’ambiziosa carriera che tutti ritengono così importante e ti conceda il tempo per ascoltare le palpitanti melodie del cuore; che tu possa guardare il sorgere del sole come se fosse la prima volta; sperimentare una paura sfrenata sul baratro della vita capendo che sei stata benedetta.
L’idea della rimodulazione, di prepararsi al mondo che viene a partire dal rapporto con la diversità, è un’idea che Akomolafe mutua soprattutto da Haraway e Barad, con quest’ultima in modo più esplicito. L’autore ci racconta di una sua visita a Berkley, motivato dalla stima che nutre per la filosofa. Di lei dice: “Il suo lavoro è l’equivalente strutturale di una fessura in un muro d’acciaio. [È] un toccar terra. Un lasciarsi alle spalle la certezza oracolare. Un farsi bastare questo mondo di parziale guarigione – un riadattarsi alla polvere.”
Il messaggio per la piccola Alethea, anche se può essere formato dall’insieme complesso di molte teorie, è piuttosto semplice nel suo insieme: i problemi che incontriamo, i momenti critici della nostra storia sono fondamentali perché ci impongono di fermarci ad affrontarli. È una visione che ricorda da una parte la teoria del pensiero produttivo di Max Wertheimer, dove si afferma che il successo nella risoluzione di un problema non può avvenire solamente mettendo in atto risposte già apprese, ma attraverso processi inediti e creativi; dall’altra il suggerimento buddhista di farsi tutt’uno con lo storcersi del mondo e di accettare di percorrere il proprio cammino.
I problemi che incontriamo, i momenti critici della nostra storia sono fondamentali perché ci impongono di fermarci ad affrontarli.
Questo richiamo a un lato negativo del reale è un filo rosso che segue tutta l’opera. Diventa chiaro già dopo le prime due lettere, dove Akomolafe ci mette in guardia sull’esistenza di “colori che non vediamo” e dimensioni sovraumane che ci sovrastano: e poi soprattutto il consiglio dato ad Alethea di “abbracciare i mostri” invece che aver paura di loro. Qui il discorso si mescola per la prima volta a un motivo metafisico, quello del buio e dell’abisso, che sono i termini che l’autore usa per circoscrivere quella parte imprevedibile (e non eliminabile) della realtà che pure dobbiamo fare nostra.
Sto imparando che un vicolo cieco è un posto fantastico, anche perché ci sono finito molte volte prima di iniziare queste lettere, così come nel corso della loro stesura. I vicoli ciechi sono opportunità per riconfigurare le nostre idee di continuità.
I mostri di cui parla Akomolafe sono ovviamente un riferimento alla creatura già teorizzata da Donna Haraway nel suo The promises of the monster: abbracciarli vuol dire non vedere il problema come qualcosa di esterno, ma come nostra parte costitutiva. Significa avere intrapreso la metamorfosi che ci porterà a considerarci già diversi, già altrove. C’è un passo fondamentale all’interno del saggio in cui Akomolafe, passando per la teoria degli archetipi di Carl Jung e quella sui rapporti modernità-violenza di Stanton Marlan, parla di un ritorno al bosco, momento successivo all’aver girato a lungo per il mondo luminoso, il mondo che sembra già scritto e che, a volersi intestardire, sembra fornire delle conferme alle nostre convinzioni in ogni suo angolo: Le parole del guaritore yoruba mi tornano in mente: ‘Avete allontanato il buio con il vostro grande sviluppo e le vostre pillole, e ora dovete ritrovarlo. E bisogna andare nella foresta per trovarlo’.
Chi scrive è l’uomo che ha cercato casa per il mondo, trovandola lontana da dove era partito: qui, come altrove, Akomolafe fa passare la narrazione attraverso le maglie della sua storia personale, ed è chiaro che si tratta di un modo di operare necessario ancora prima che volontario. Solo la sua presenza fisica, la sua passione, può trasformare il racconto in testimonianza.
Chi scrive è l’uomo che ha cercato casa per il mondo, trovandola lontana da dove era partito.
Sarebbe del resto impensabile affrontare un discorso sulla riconfigurazione dell’essere dimenticandosi della propria identità. Per spiegare il mondo a sua figlia, il padre ha bisogno che nessun tassello vada perso, l’appartenenza al gruppo yoruba e ancora prima le ferite del colonialismo europeo, il razzismo vissuto in prima persona, le questioni del vivere in un paese straniero (Akomolafe vive con la sua famiglia a Chennai, in India) e non ultimo considerarsi membro della grande famiglia biologica di cui l’umanità è solo una piccola parte.
I temi sono iperconnessi, l’azione politica non può scollegarsi dalla riflessione sul corpo che a sua volta vive dentro una storia personale: “Certo, corriamo tutti verso il Futuro. Ma avere la pelle nera significa essere già in ritardo. […] E tu figlia mia, come me e come il padre che spettralmente mi abita, sei in ritardo anche tu.”
Sapendo ciò, superata la questione di comprendere (o almeno intuire) quanto arduo sia il compito di vivere il mondo moderno, si può andare avanti. Sempre con il nostro corpo diventiamo parte di un processo di attivazione a cui Akomolafe dedica la parte forse più originale del libro. Grazie a una rinnovata sensibilità, si osservano dettagli che prima non si erano notati. Così ci si accorge che la realtà, lontana dall’essere una dimensione già assodata e scritta, assomiglia piuttosto a un mosaico animistico pieno di riverberi e di fate morgane, dove la natura (più volte inutilmente definita) svanisce e al suo posto fenomeni bizzarri vengono continuamente alla luce. Mi piace immaginare che quando un seme cade a terra possa esprimere dolore, e che questo dolore venga accolto dalla femminilità argillosa del suolo. (…) Forse è questa la prossima frontiera: non lo spazio esterno e quello interno, ma gli spazi del mezzo.
La teoria dell’Afrocene, che adesso aggrega costrutti tecnici come quello dell’intra-azione avanzato da Barad, ci spinge su una terza via, mettendoci di fronte a questo “mezzo” che più di un invisibile rapporto causa-effetto esiste come zona di separazione e di raccordo del tutto. L’autore usa diverse immagini per esemplificare il concetto, come l’orma (che testimonia l’esistenza di un contatto tra un piede e il terreno) o in modo più astratto quello della “fessura”, una rottura che si può aprire nei modi più disparati sulla superficie apparentemente omogenea della realtà.
La realtà assomiglia a un mosaico animistico dove la natura svanisce e al suo posto fenomeni bizzarri vengono continuamente alla luce.
Ma “di mezzo”, dice Akomolafe, è anche e soprattutto la scelta di chi continua a spostarsi, non accettando né di approdare per sempre a un altrove, né di rinunciare al viaggio. Un punto chiave del libro è l’idea del dover ripartire sempre da capo, riannodando ogni volta in un modo nuovo i fili del ragionamento. Ancora parlando di Karen Barad, il filosofo si mostra affascinato dai suoi modi di viaggiatrice che non si considera mai arrivata, che “sfida la pigrizia concettuale” dell’approdo e del traguardo.
Sono viaggi interminabili le peregrinazioni che dobbiamo affrontare per ricostruire il nostro ruolo: come recita il sottotitolo del libro, “per fare casa sul pianeta”. Allora, se c’è un modo per rendere abitabile l’abisso in cui probabilmente finiremo, sarà non smettere mai di considerarci al riparo in un luogo in cui l’alterità sia stata abolita (qui le affinità con le idee di Donna Haraway sono evidenti, soprattutto dove l’autrice illustra il suo Chthulucene).
È evidente che la fiducia moderna nell’idea di progresso abbia mostrato da tempo i suoi limiti: possiamo continuare a credere che i problemi che incontriamo nel corso della Storia (che si conclamano in modo sempre più frequente) siano una serie casuale di spiacevoli incidenti, fino al giorno in cui ci rendiamo conto che è la nostra rappresentazione a esserne la causa. La caduta è la condizione di base del nostro mondo. La sua tragedia continua a mostrarsi con il volto delle crisi e delle nostre reazioni per recintare il danno e renderlo innocuo. E questo, ricorda Akomolafe, rinnova i presupposti perché la crisi avvenga di nuovo. La sicurezza è talmente instabile che ha poco senso chiamarla in quel modo.
L’immagine presa in prestito nel libro è il kintsugi, l’antica arte giapponese di riassemblare gli oggetti rotti, impreziosendoli con il dettaglio ricamato dei loro punti di rottura: Dobbiamo imparare a vivere nella Caduta, proprio qui, nel mezzo delle cose. L’assoluto scheggiarsi in cocci della contingenza – qui, in questa stessa incerta terra di mezzo – è la lacca di polvere d’oro che abbraccia i frammenti nella vasta rete di molte forme del divenire.
Tanto vale prenderne atto e capire da dove ricominciare a stabilire valori più vitali e inclusivi. Con Alethea possiamo imparare che un oggetto rotto e riassemblato con cura e dedizione può valere molto più di quello integro, che integro non è.