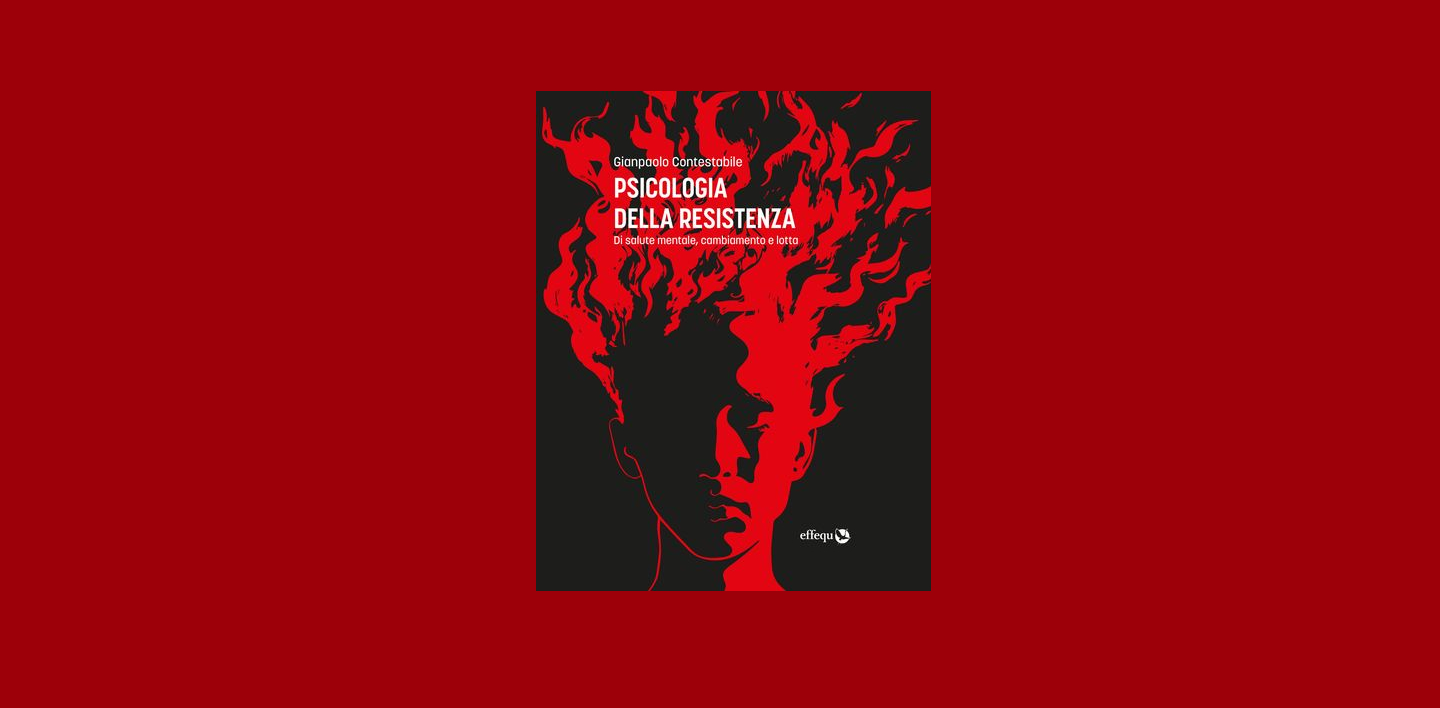
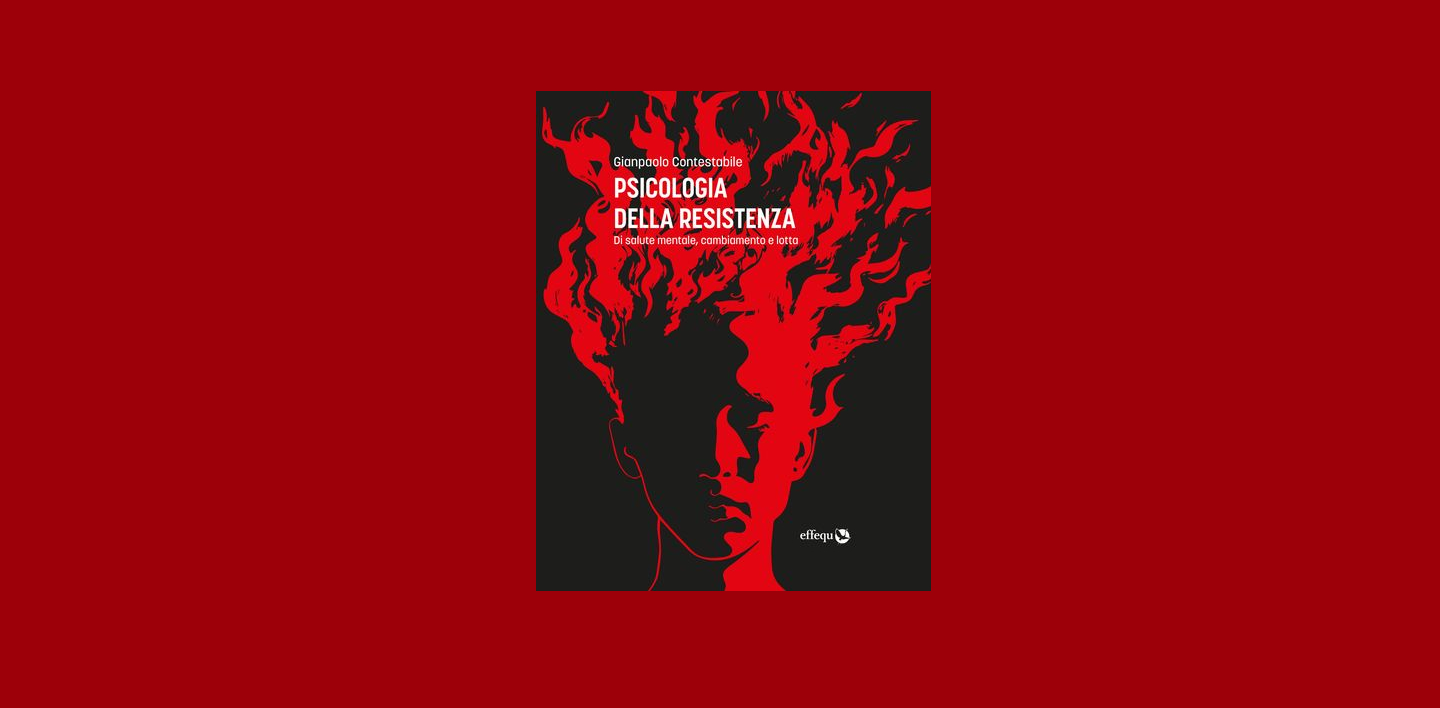
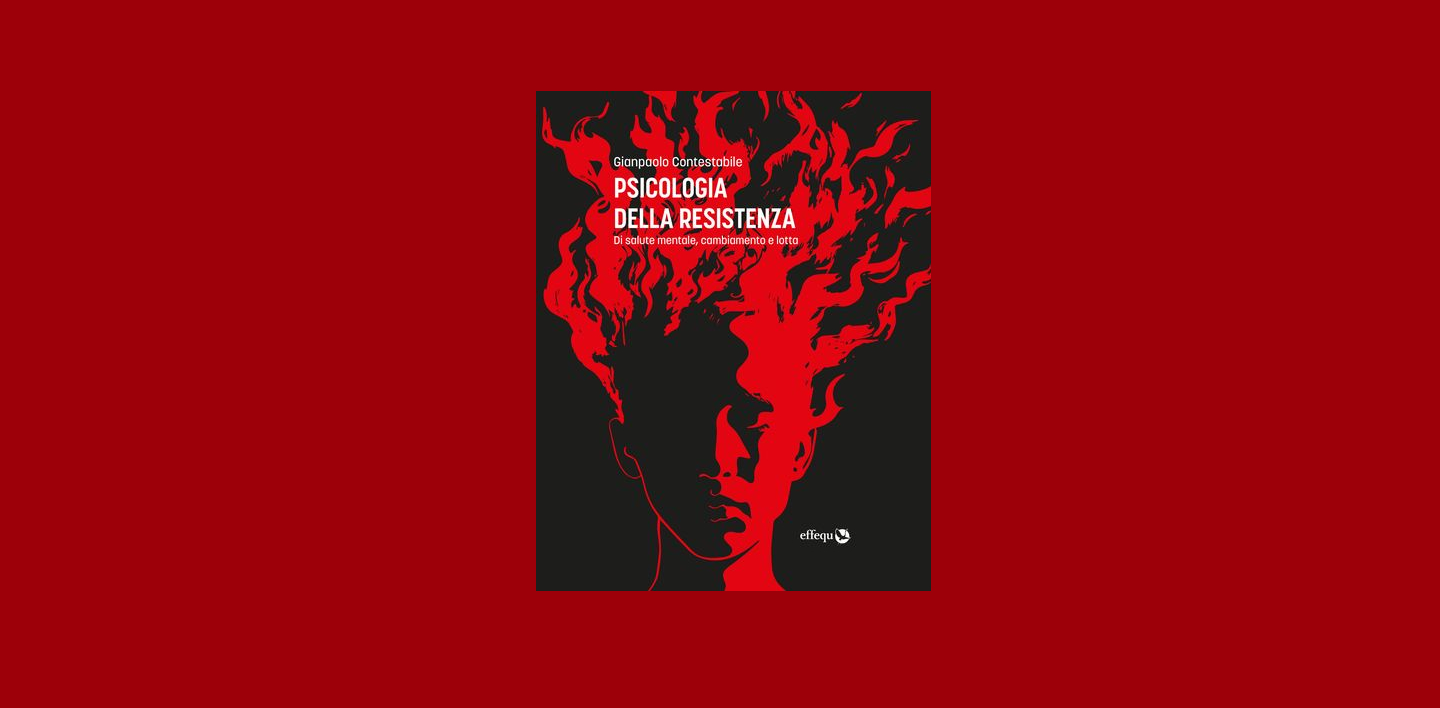
Q ualche anno fa ho scoperto che il mio bisnonno morì dopo un lungo ricovero, o meglio dopo una lunghissima reclusione, presso l’istituto psichiatrico di Cogoleto, all’epoca (gli anni Quaranta del secolo scorso) ancora manicomio sotto il diretto controllo del ministero degli Interni e non della Sanità. Questa storia mi ha ossessionato talmente tanto da avermi fatto entrare in possesso della sua cartella clinica vecchia di più di ottant’anni nella quale sono contenute tutte le informazioni sul suo ricovero, le lettere della moglie, quelle di un suo caro amico, tanta burocrazia (eravamo in pieno regime fascista), appunti medici oggi privi di ogni logica, considerazioni del direttore dell’istituto, infine il telegramma con cui, dopo anni di internamento, ne comunicavano il decesso in modo freddo e sbrigativo.
Rimettendo assieme i pezzi di quel puzzle ho scoperto che si trattò di una storia di immigrazione finita male, come ne sono accadute tante, come ne accadono anche oggi. Era andato a lavorare a Genova lasciando moglie e tre figli piccoli a cinquecento chilometri di distanza, ebbe un grave incidente sul lavoro e non venne mai pagato per l’infortunio né tanto meno per il lavoro svolto fino a quel momento, decise di restare a Genova pur nell’indigenza per la paura di non ricevere il dovuto, tutto ciò recandosi a protestare più e più volte al cantiere fino a quando, non potendolo arrestare, lo fecero internare in manicomio. Una volta lì, tra contenzione, botte, continue privazioni durate anni probabilmente un po’ “matto” lo divenne davvero.
Dagli anni Quaranta del Novecento ai Venti del nostro secolo, le cose non sono cambiate tanto. Il 28 novembre 2021 Wissem Abdel Latif, un ragazzo tunisino di ventisei anni, muore a Roma nel corridoio dell’ospedale San Camillo dopo essere stato lasciato per più di novanta ore legato a un letto, imbottito di psicofarmaci e senza alcuna assistenza. Era in Italia da meno di un mese e questo non era ciò che si aspettava di trovarci.
Quella di Wissem è una delle storie che Gianpaolo Contestabile ci racconta nel suo Psicologia della resistenza. Di salute mentale, cambiamento e lotta (2024) e lo fa ricostruendola nei minimi dettagli e passaggi, descrivendo quella che lui stesso definisce come normalità: “la violenza estrema che ha subito Wissem non è un errore, non è un incidente né un caso isolato ma è la normalità di un sistema concentrazionario, razzista e autoritario nato con lo scopo di annullare i diritti e la vita stessa delle persone in viaggio dai paesi più poveri.” Come lo stesso autore ci dice, questa storia è esemplare perché presenta tutta la catena delle istituzioni oppressive: dal ministero dell’Interno ai Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, dalla guardia costiera agli psicologi dei CPR (Centri di Permanenza e Rimpatrio).
La storia di Wissem Abdel Latif presenta tutta la catena delle istituzioni oppressive: dal ministero dell’Interno ai Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, dalla guardia costiera agli psicologi dei CPR.
È una benzodiazepina ma, nonostante questo accada con tante altre molecole della stessa classe farmaceutica, è inusuale e non indicato per trattare problemi psichiatrici e disturbi legati all’ansia. Il suo utilizzo medico è autorizzato per il trattamento e la prevenzione di crisi epilettiche, da solo o in associazione con altri farmaci qualora non bastasse e un altro suo utilizzo off-label sfrutta le forti capacità miorilassanti (quasi al limite della controindicazione) per patologie muscoloscheletriche gravi che non rispondono ad altri trattamenti.
I miei incontri con i blister vuoti di Rivotril che trovo a terra aumentano di intensità ogni volta che mi avvicino a zone in cui ci sono persone indigenti, spesso extracomunitarie, costrette a vivere in strada. Mi sono chiesto quando una molecola prima così poco nota nel mercato nero delle sostanze sia diventata tanto conosciuta (a volte accade per coincidenza, altre per moda, a volte perché citata in una canzone), ma in questo caso particolare la vedo ben presente e diffusa solo in una certa fascia di popolazione. Leggendo il libro di Contestabile ho trovato una risposta a questa mia domanda, venendo a conoscenza del suo utilizzo, fatto con molta leggerezza e facilità di prescrizione, nei CPR per ammansire fino a rendere quasi zombie privi di volontà le persone che vi vengono recluse; la stessa facilità e le stesse ragioni con cui questa molecola viene utilizzata anche nelle carceri italiane. È in questi luoghi di detenzione e punizione che una certa fascia della popolazione è entrata in contatto con il Rivotril e ha imparato a usarlo per non percepire più la propria insopportabile esistenza.
Contestabile struttura il suo saggio in quattro blocchi suddivisi in capitoli: il primo blocco è Della salute, il secondo Dello sfruttamento, il terzo Della catastrofe, il quarto Della resistenza. Poi ci sono altri due grandi blocchi contrapposti diffusi lungo tutto il testo: leggendolo andremo a ripercorrere la storia e le storie che hanno fatto la psicanalisi occidentale – con degli affondi molto belli sulla natura borghese della pratica psicoanalitica, sia parlandoci di chi può permettersi di accedere a un percorso terapeutico, sia con il racconto, spesso poco trattato, di un percorso di studi e di formazione che non tutti possono permettersi, essendo molto lungo, dispendioso, costellato di tirocini non retribuiti e di scuole private care e quasi sempre localizzate in grandi città, con tutte le spese che comporta il viverci tra affitti alti e il maggiore costo della vita rispetto alla provincia.
Contestabile si augura una riconciliazione della frattura tra Freud e Marx e la sua ricetta per farlo passa dal riconoscimento del processo dialettico tra il nostro inconscio e la cultura.
Ma non è un libro di storia della psicoanalisi, è una riflessione molto attenta e puntuale sulle politiche della salute mentale, su come la psicoanalisi presti il fianco al capitalismo e su come noi, e per noi qui si intende la comunità non il singolo, possiamo (e dobbiamo) riappropriarcene per il benessere collettivo. È un libro che ci parla di cura collettiva, delle varie pratiche di resistenza sviluppatesi in contesti diversi, in cui il comune denominatore è sempre l’oppressione esercitata dal sistema capitalista, dei paradossi che si generano anche quando ci sono buone intenzioni (la grande ondata del rinascimento psichedelico con la messa in pericolo delle piante maestre nei loro habitat originali per esempio).
E qui apprendiamo che la salute mentale non può essere attribuita alle scelte del singolo, non può passare dal tè verde biologico che beviamo al mattino, dallo yoga fatto nel salotto di casa (se ne abbiamo uno), dalle pratiche di meditazione: non può essere demandata all’individuo. Veniamo messi in guardia dal pericolo di far diventare i disastri globali dei problemi personali da affrontare in solitudine o peggio ancora da curare con la reclusione e i farmaci.
Ci presenta il pensiero di menti illuminate nel campo: Ignacio Martín-Baró, padre della psicologia della liberazione (quanto è bella l’idea della teologia della liberazione per cui il regno dei cieli non deve essere una ricompensa nell’aldilà ma va preteso ora?), Franco Basaglia, colui che fece la più importante rivoluzione sociale mai avvenuta nel nostro Paese; ricostruisce la storia personale di Che Guevara per introdurci alla rivoluzione e al bene collettivo, ci fa conoscere la potenza del pensiero di Frantz Fanon per l’autodeterminazione dei popoli oppressi, Mark Fisher e il realismo capitalista.
È un libro che ci parla di pratiche di resistenza sviluppatesi in contesti diversi in cui il comune denominatore è sempre l’oppressione esercitata dal sistema capitalista, e dei paradossi che si generano anche quando ci sono buone intenzioni.
Avrà anche dei difetti questo volume? Sì, quello che spesso hanno i testi che trattano certi temi: sono libri che parlano a persone che hanno già una certa idea di società e questo è un peccato perché così si depotenzia il loro effetto sulla realtà. È difficile che qualcuno entri in libreria e acquisti questo libro se non ha già la stessa visione dell’autore: la copertina con un’immagine che tanto ricorda l’estetica usata spesso anche nella comunicazione delle manifestazioni e i colori rosso/nero dell’anarchia, tutto chiama a sé un certo tipo di lettore, lasciando fuori dal dibattito coloro sui quali potrebbe e dovrebbe essere davvero illuminante. Il mio augurio è che venga adottato come libro di testo in qualche corso universitario, o perché no, anche consigliato da qualche bravo professore a scuola.
In chiusura l’autore tesse una proposta ricongiungendo tutti i fili dei discorsi fatti nei capitoli precedenti e tutto ritorna perfettamente, tutto ci porta a una conclusione indiscutibile: “La resistenza è terapeutica”.