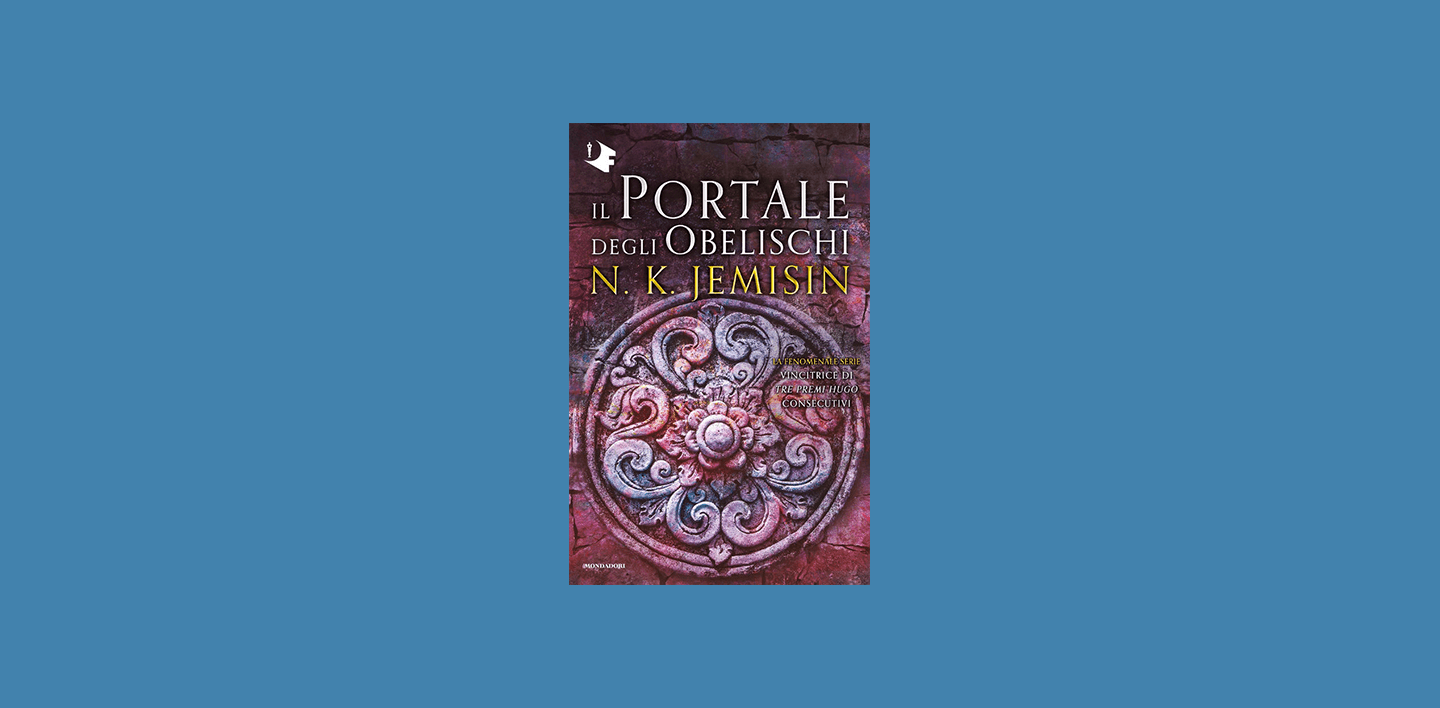I
l portale degli obelischi è il secondo volume della Terra Spezzata, la trilogia di Nora Jemisin (in Italia per Mondadori, con traduzione di Alba Mantovani) che è riuscita a vincere per tre anni consecutivi il premio Hugo. La storia è ambientata su un grande continente solitario chiamato l’Immoto. Siamo sulla Terra, in un futuro lontanissimo, e il continente è sconquassato da catastrofi ricorrenti chiamate Quinte Stagioni: che sia una serie di terremoti, un maremoto, una nube di gas tossico o un cambiamento climatico improvviso, ciascuna Stagione è un evento che può mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’umanità.
Per questo donne e uomini si sono riorganizzati in piccole comunità pronte a chiudersi in loro stesse alla prima avvisaglia di cataclisma. Religione e survivalismo hanno finito per confluire nella disciplina chiamata Litodottrina, che regola ogni cosa: dalla conservazione delle razioni d’emergenza alla scelta di quali membri della comunità sacrificare per primi. “Damaya conosce la litodottrina che insegnano a tutti i bambini perfino in un luogo isolato come Palela. Prima proteggere i cancelli. Tenere le scorte pulite e asciutte. Ubbidire alla dottrina, fare le scelte difficili, e forse alla fine della Stagione ci sarà gente che ricorderà come dovrebbe essere la civiltà”.
Stralci di litodottrina sono sparsi per tutti e tre i libri della trilogia, mescolati ad altri documenti storici: “Metti una trave centrale flessibile nel cuore di tutte le strutture. Fidati del legno, fidati della pietra, ma il metallo arrugginisce. TAVOLA TRE, Strutture, primo verso”, come anche: “Non respirare la pioggia di cenere sottile. Non bere l’acqua rossa. Non camminare a lungo sul terreno caldo. TAVOLA UNO, Sulla sopravvivenza, verso sette”. “La Stagione tornerà sempre. TAVOLA DUE, La verità incompleta, verso uno.”
Su questa Terra intenta a disfarsi periodicamente, si aggirano donne e uomini in grado di percepire e controllare le vibrazioni sismiche: gli orogeni. Come spesso capita quando si parla di superpoteri, gli orogeni sono odiati per la loro intrinseca pericolosità, ma sono anche sfruttati per tenere a bada i terremoti. Quando la storia comincia, un impero occupa la fascia centrale del continente, e lo fa da ventisette secoli proprio grazie alla brutale oppressione degli orogeni, gli unici in grado di smorzare i terremoti e così prevenire i cataclismi.
Jemisin utilizza una lingua che di solito non si sposa con il world-building di un romanzo fantasy o di fantascienza.
“La nostra posizione” recita la Dichiarazione del secondo consiglio dottrinale di Yumenes sui diritti degli affetti da orogenia, “è interamente legata all’integrità fisica dell’Immoto, per ovvie ragioni di sopravvivenza a lungo termine. La conservazione di questa terra dipende in modo peculiare dall’equilibrio sismico che, per un’imperativa legge naturale, solo gli orogeni possono mantenere. Un colpo alla loro schiavitù è un colpo al pianeta stesso.” Gli orogeni sono condannati all’inferiorità perché sono gli unici in grado di garantire la sicurezza, e alla schiavitù perché se non venissero addestrati costituirebbero un pericolo.
“Yumenes è unica perché soltanto qui gli esseri umani hanno osato costruire non per la sicurezza, non per le comodità, e nemmeno per la bellezza, bensì per audacia”, scrive Jemisin all’inizio de La Quinta Stagione. Solo a Yumenes potete ammirare “strutture architettoniche chiamate balconi, così semplici e al tempo stesso così ardite e mozzafiato che, a quanto risulta dalla storia scritta, nessuno le aveva mai costruite prima.” Su questo sfondo la storia prende il via da due catastrofi: una globale, ovvero l’apertura di una faglia che inghiotte Yumenes; una personale, che spazza via la famiglia della protagonista, quando il marito scopre che il figlio è un orogeno e lo uccide – avendone per giunta il diritto. È l’inesorabile litodottrina: “Scova l’orogeno nella culla. Fa’ attenzione al centro del cerchio. Lì troverai [indecifrabile] TAVOLA DUE, La verità incompleta, verso cinque”.
Il mondo costruito da Jemisin è ricco di cultura, di linguaggio, di pratiche, di relazioni, e non potrebbe essere altrimenti: ogni cosa merita di essere esplorata perché ogni cosa nell’Immoto è significativa. Ogni struttura, architettonica o sociale, è determinata dallo stato di allerta permanente in cui i suoi abitanti vivono. Ogni persona ha sempre pronto un runny sack (in italiano “sacco fuga”) con dei beni essenziali da portare con sé in caso di fuga precipitosa, proprio come fanno i prepper. Perfino le identità sono “in caso d’emergenza”: il cognome di un individuo è sostituito dal nome della comunità d’appartenenza e dal nome della casta d’uso (ovvero da chi sarà accolta la persona e che ruolo avrà durante una Quinta Stagione).
Non è certo la prima volta che un’autrice o un autore di fantascienza si cimenta con un così ambizioso world-building di un “mondo secondario”, ovvero che non ha legami con il nostro. Jemisin lo fa in modo molto consapevole, come spiega in un’intervista a Electric Lit:
I lettori si aspettano ed esigono quel livello di dettaglio. È una dinamica molto utile, perché ti obbliga a scavare in cerca di un livello di verosimiglianza che molti preferiscono ignorare. Se lo fai bene, puoi ottenere un mondo che sembra davvero vissuto.
Per arrivare a questo risultato, Jemisin utilizza anche una lingua che di solito non si sposa con il world-building di un romanzo fantasy o di fantascienza: una lingua molto ruvida e sincopata che aderisce da vicino al carattere spigoloso della protagonista, in particolare nei capitoli in seconda persona, di cui Jemisin fa un uso spregiudicato. La seconda persona crea un’interpellazione continua rivolta al lettore o alla protagonista che può apparire leziosa ma che acquista senso e forza nel corso dei volumi. È una forma ingombrante e aggressiva; così finisce il prologo de La Quinta Stagione:
Ciò che devi ricordare è questo: la fine di una storia è solo l’inizio di un’altra. È già accaduto, dopo tutto. La gente muore. I vecchi ordini passano. Nascono nuove società. Quando diciamo: ‘È la fine del mondo’, di solito è una bugia, perché in realtà
il pianeta sta bene. Ma è così che finisce il mondo. È così che finisce il mondo. È così che finisce il mondo. Per l’ultima volta.
E così inizia il primo capitolo:
Tu sei lei. Lei è te. Ricordi? La donna cui è morto il figlio. Sei un’orogena che vive nell’insignificante cittadina di Tirimo da dieci anni. Solo tre persone sanno che cosa sei e due di loro le hai messe al mondo tu. Bene. Ne rimane una sola che sa, ora.
Con questa voce enfatica Jemisin strattona l’attenzione del lettore: non è lo stile che si usa solitamente per raccontare un mondo secondario così complesso e diverso dal nostro, non è una strategia narrativa utile per costruire quadri nitidi e particolareggiati – e non a caso le architetture e i paesaggi di questo libro sono la cosa che resta meno impressa. La lingua scelta da Jemisin non è fatta per costruire immagini, insomma, ma forse proprio per questo è la lingua giusta per raccontare un continente in continuo disfacimento.
L’attrito tra l’esigenza di costruire un mondo e quella di descrivere gli avvenimenti che portano alla sua distruzione è una peculiarità che fa brillare la trilogia. Jemisin fa piazza pulita della moda del post-apocalittico con una storia che prova a reinventare il genere: la fantascienza degli ultimi anni si è adagiata nelle descrizioni da fine del mondo, cavalcandone l’indubbia potenza evocativa ma finendo spesso con il disinnescare la metafora ambientalista che volevano portare avanti. Da Maze Runner a Death Stranding, da La strada a The 100 (per citare media ed esiti diversi), il dopo apocalisse è ovunque e da nessuna parte, piegato alle più diverse esigenze.
Con la Terra Spezzata, Nora Jemisin lo riavvolge su se stesso, offrendo un post-apocalittico che è anche pre- e trans- e meta-, nella misura in cui viene dall’apocalisse e va verso essa passandoci attraverso e descrivendola. Nell’Immoto i sopravvissuti non si raccolgono intorno a un carismatico signore della guerra, o a un messia che promette di portarli in un posto migliore, ma intorno alla religione stessa dell’apocalisse: la dottrina che spiega come sopravvivere al prossimo cataclisma, o come preparare i propri figli se si avrà la fortuna di completare un arco di vita senza vedere la Stagione successiva. La catastrofe non è un evento del passato da cui risollevarsi e non è un minaccia nel futuro da sventare. È semplicemente parte del ciclo, una condizione naturale.
Jemisin colloca la catastrofe come assordante rumore di fondo di una società assuefatta all’emergenza che ha plasmato l’esistenza delle persone. L’emergenza permanente giustifica ogni deroga alla morale nella logica della sopravvivenza, a partire dall’oppressione sistematica e brutale degli orogeni, sfruttati per tenere a bada i terremoti, fino ad arrivare al cataclisma personale che devasta la vita della protagonista quando il marito scopre che il figlio di quasi tre anni è un orogeno e lo uccide a mani nude. È un monito: l’emergenza è l’assoluto che inghiotte ogni discorso di solidarietà, o anche solo di pietà o di amore. Quando la protagonista capisce ciò che è successo al figlio capisce che
i tuoi figli sono come te. È la prima volta che dai forma completa a questo pensiero. Lerna chiude gli occhi, emette un lungo respiro. «È questo, dunque.» Non lo è. Non avrebbe mai dovuto indurre un padre a uccidere il proprio bambino. Niente dovrebbe farlo.
Gli abitanti dell’Immoto imputano le Stagioni all’intenzione malevola di una Terra esasperata che ha deciso di difendersi impedendo all’umanità di prosperare, o anche solo di rialzare troppo la testa. Evil Earth viene chiamata dai personaggi, spesso come imprecazione (in italiano, felicemente, Terra Infame). La Terra assume il ruolo che nel fantasy viene riservato al Nemico, al dark lord.
Nel corso della trilogia scopriremo anche quale terribile gesto di hubris di una civiltà scomparsa è responsabile di una rabbia così inesauribile: non è il gesto compiuto dalla nostra società ma gli somiglia. Un assalto al cuore del pianeta-padre che l’umanità ha deciso di sferrare pur comprendendone i rischi. Jemisin mette in scena la metafora ecologista più classica, sopita dopo decenni di uso smodato dello scenario post-apocalittico, e la fa riemergere con la forza di un’eruzione.
C’è stato un tempo, prima delle Stagioni, quando la vita e Terra, suo padre, prosperavano insieme. […] Poi ci rivoltammo contro di Lui e da allora Lui arde di odio per noi.