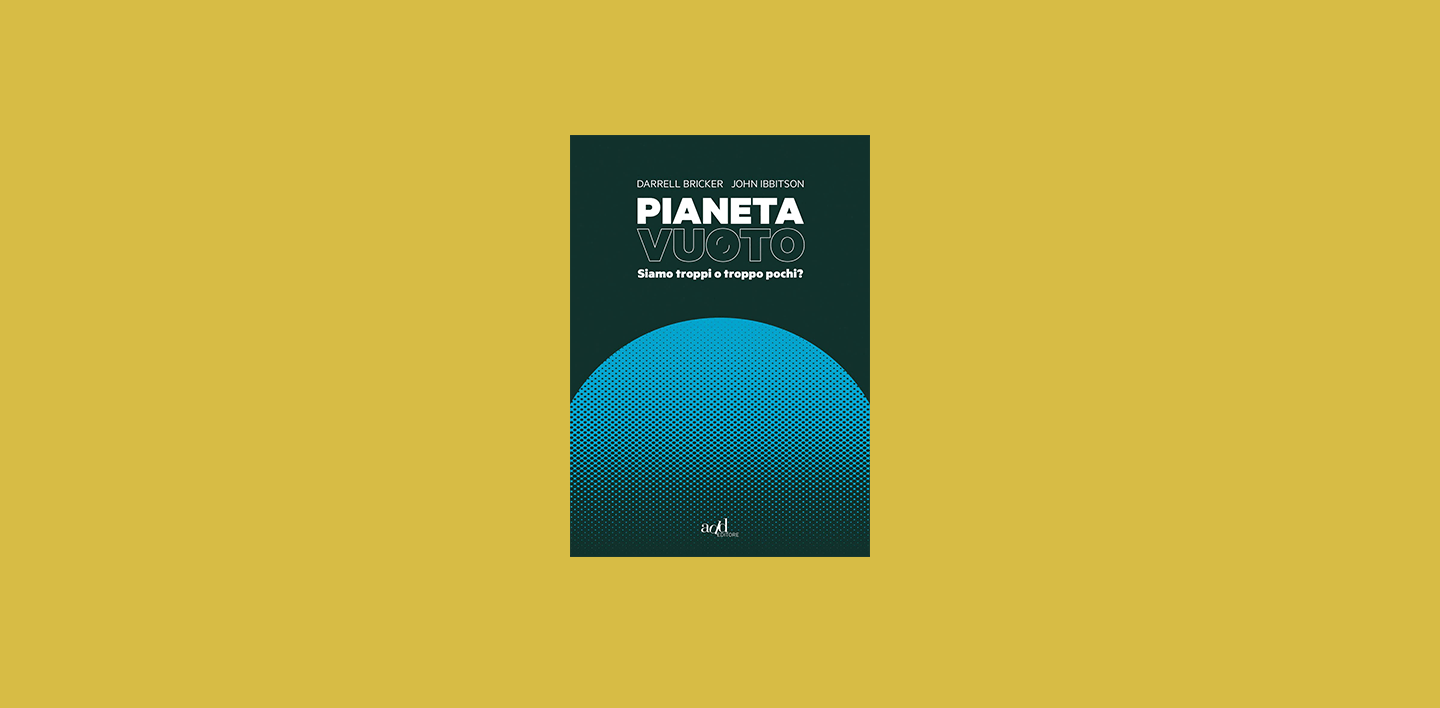
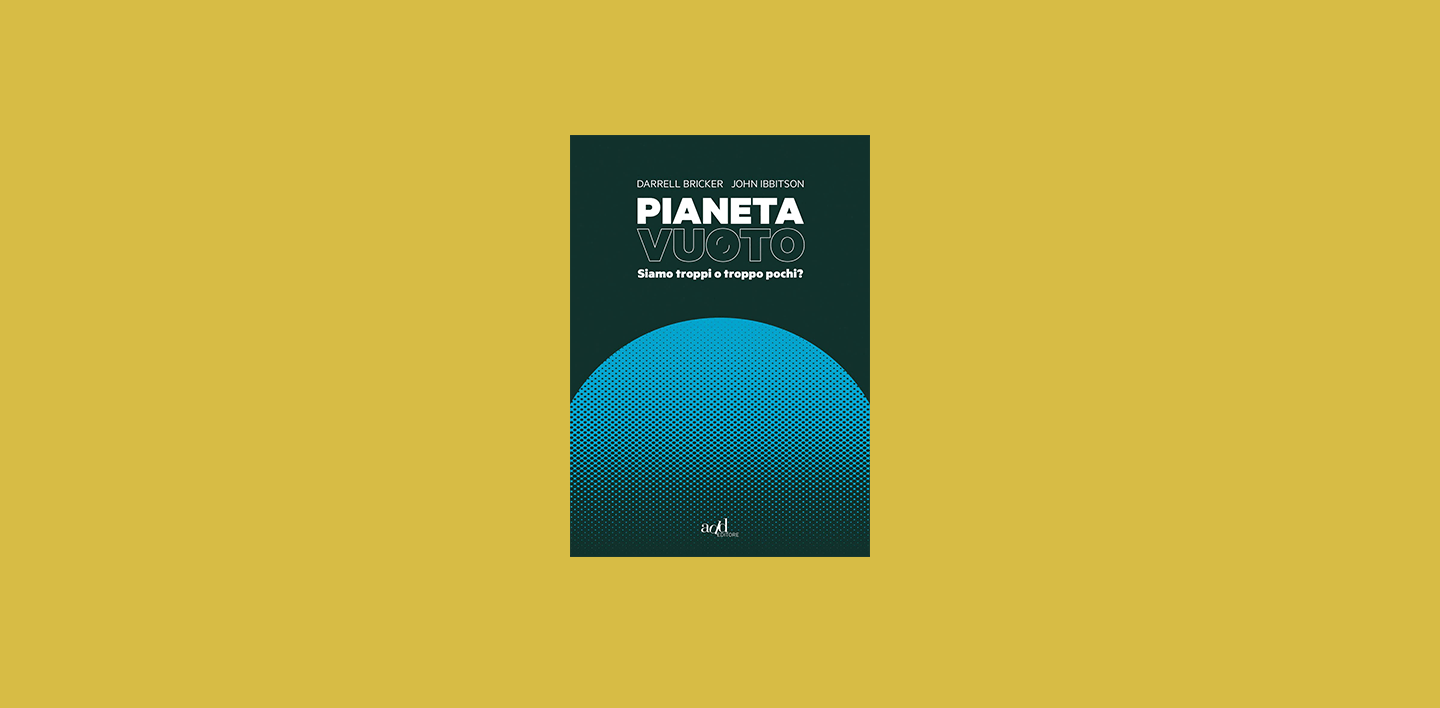
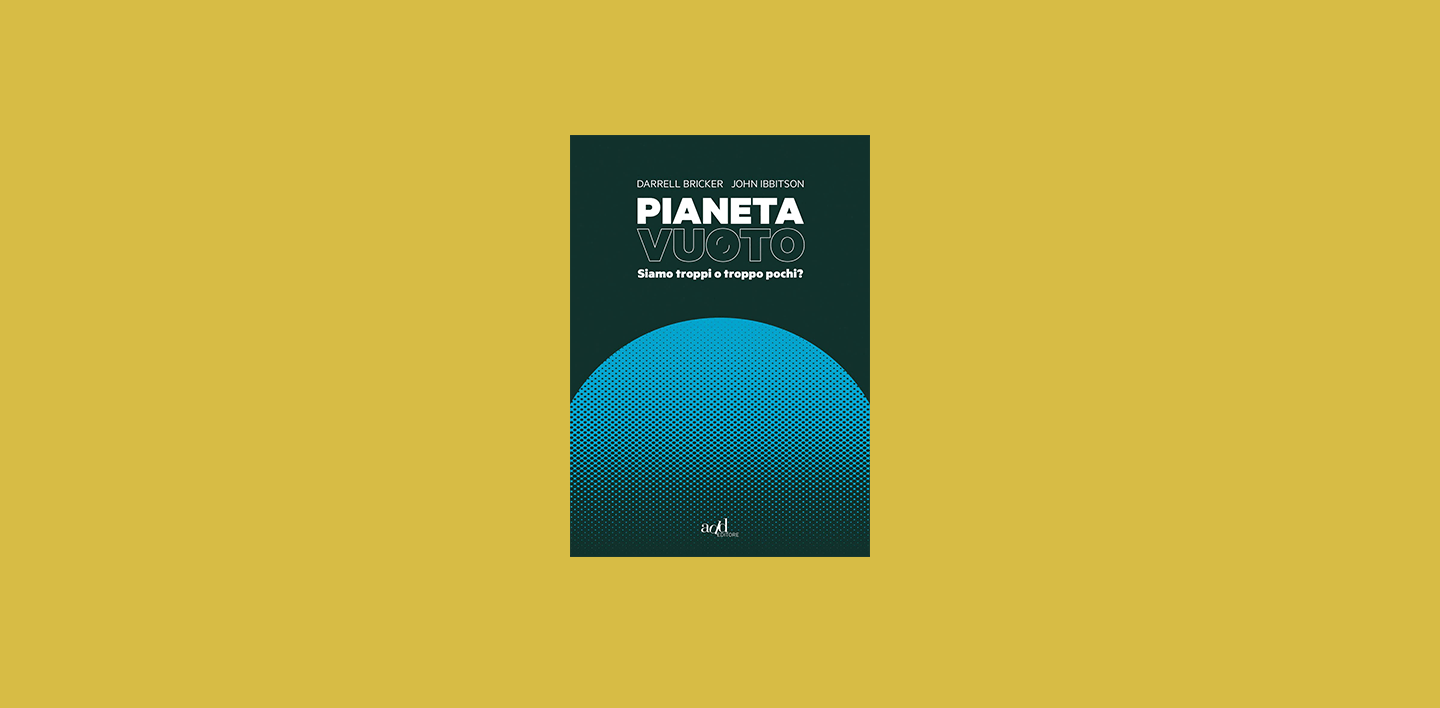
I l futuro è una questione di numeri e quelli dello sviluppo demografico sono uno dei fattori maggiormente destabilizzanti negli equilibri di un pianeta che, messo alle spalle il primo ventennio del Ventunesimo secolo, si trova a dover fare i conti con una globalizzazione energivora e una crisi climatica le cui conseguenze si manifestano con modalità di anno in anno più evidenti. Ogni riflessione su futuri prossimi e remoti non può che partire da un ragionamento sulla popolazione: sia che lo si faccia in un’ottica globale, sia che si voglia pensare in termini di confini nazionali.
Pianeta vuoto. Siamo troppi o troppo pochi? di Darrell Bricker e John Ibbitson, uscito di recente in Italia per i tipi di add editore nella traduzione di Silvia Manzio, confuta le proiezioni della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite (UNDP) secondo le quali il numero di esseri umani aumenterà sino a 8,6 miliardi di persone nel 2030, per raggiungere i 9,8 miliardi nel 2050 e gli 11,2 miliardi nel 2100. Dopo essersi confrontati con professori, esperti di demografia, funzionari di Stato e giovani di mezzo mondo (Bruxelles, Seul, Nairobi, San Paolo, Bombay, Pechino, Palm Springs, Canberra e Vienna), i due autori canadesi delineano uno scenario decisamente anticonvenzionale, nel quale la frenata e il declino della popolazione globale arriveranno ben prima delle previsioni dell’ONU.
Il diagramma della popolazione globale è un “falsopiano” ascendente che diventa un picco repentino dopo la Seconda Guerra Mondiale, in quello che viene chiamato baby boom. Le cifre globali parlano chiaro: dopo avere raggiunto il primo miliardo di persone all’inizio dell’Ottocento, sono stati necessari 125 anni per raddoppiare la cifra, altri trenta per arrivare a tre miliardi e altri quindici per toccare i quattro miliardi.
A partire dalla metà degli anni Settanta il periodo necessario per aggiungere un nuovo miliardo è stato di circa tredici anni e sarà così sino a quando, a metà dell’attuale decennio, si raggiungeranno gli otto miliardi di persone. Secondo la teoria sposata da Bricker e Ibbitson, dopo questa fase di stabilizzazione, l’incremento demografico non solo rallenterà, ma si fermerà per poi fare marcia indietro, e questa frenata, che secondo gli autori avverrà molto prima di quella prevista dall’UNDP per l’inizio del prossimo secolo, avrà un impatto inedito sugli assetti globali.
In alcuni Paesi il declino è già iniziato. Se in passato erano state guerre, carestie ed epidemie a decimare il genere umano, ora la possibilità di non mettere al mondo figli è una scelta sempre più consapevole, a volte persino orientata dalle politiche di Governo, come avvenuto nel recente passato in Cina. Quando si scende sotto la soglia di sostituzione di 2,1 figli per donna (lo 0,1 in più è necessario per compensare la mortalità infantile e la morte prematura di donne in età fertile) inizia un lento e inesorabile declino: l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione delle persone in età lavorativa spingono i Governi verso riforme draconiane in materia di sanità, assistenza e previdenza sociale.
Al di là delle peculiarità dei singoli Paesi, Bricker e Ibbitson individuano le cause del calo della fecondità nell’urbanizzazione, nell’istruzione e nell’emancipazione femminile. Se in campagna il figlio è un investimento, in città diventa una bocca in più da sfamare. Inoltre,
quando si vive in una società rurale poco sviluppata, la sfera sociale tende a ruotare intorno alla famiglia, in cui gli anziani spingono senza sosta i giovani a sposarsi e a riprodursi per soddisfare l’impulso evolutivo a perpetuare la specie. Ma in una società che diventa più urbana e moderna, gli amici e i colleghi sostituiscono i fratelli, i genitori, gli zii e le zie.
Il flusso verso le metropoli innesca una reazione a catena: un maggiore grado d’istruzione spinge le coppie a scelte più consapevoli di fronte alla prospettiva di avere un figlio e determina una maggiore propensione all’utilizzo dei contraccettivi. Inoltre, in città le possibilità di emancipazione femminile sono maggiori e per una donna la maternità diventa una possibilità fra tante e non, come spesso accade nelle aree rurali, l’adesione a un canovaccio scritto dalla comunità.
Ciò a cui abbiamo assistito nei Paesi Sviluppati nel corso del Ventesimo secolo sta avvenendo ora nei Paesi in via di sviluppo che sono stati il “traino” dell’esplosione demografica nell’ultimo mezzo secolo: le persone si spostano nelle città e i tassi di fecondità diminuiscono.
Il caso della Cina è emblematico. Al termine della Guerra civile che diede origine al moderno Stato Cinese, Mao Zedong incoraggiò la popolazione a fare figli, ma la risposta dei suoi connazionali fu tale da condurre a una sovrappopolazione che contribuì a una carestia letale per milioni di abitanti. In seguito a questi traumatici eventi, Pechino creò una Commissione per la pianificazione familiare che nel 1971, all’inizio del quinto Piano Quinquennale, lanciò la campagna Wan Xi Shao (più tardi, più distanti, di meno) pensata per orientare i cinesi a sposarsi più tardi, a fare meno figli e a far trascorrere più tempo fra una gravidanza e l’altra. Grazie a questa campagna e al processo di migrazione dalle campagne alle città il tasso di natalità scese dai 6,2 figli per donna del 1960 ai 2,5 figli del 1979. In quello stesso anno Deng Xiaoping rese obbligatoria la politica del figlio unico. A oltre quarant’anni da quella storica decisione, la Cina fa i conti con una natalità ben al di sotto della soglia di sostituzione: 1,6 figli per donna. Alla politica del figlio unico va aggiunta un’altra tragica conseguenza dell’autoritarismo demografico di Pechino: la diminuzione della popolazione femminile ottenuta attraverso gli aborti selettivi. E così, come accaduto alla fine del secolo scorso in Giappone, la Cina si appresta a diventare un Paese di anziani. Proprio guardando all’evoluzione demografica dell’arcipelago nipponico, i due autori spiegano quello che è uno dei principali effetti economici dell’invecchiamento della popolazione:
Se da quasi trent’anni l’economia giapponese è per lo più stagnante, è anche perché la sua popolazione, vecchia, consuma meno, generando una contrazione della domanda e un numero sempre minore di prestiti erogati delle banche, giustamente preoccupate che la domanda continui a calare.
Bricker e Ibbitson sottolineano un altro aspetto non trascurabile: in una società di anziani non si innova. Sono sempre i giovani a portare idee fresche, a rendere vitali e prolifiche scienza, cultura ed economia. È sufficiente guardare alla parabola compiuta dall’Italia dal Dopoguerra a oggi per trovarne una conferma. Studiare i numeri della demografia significa, dunque, costruire ipotesi verosimili sul mondo che verrà.
Fra i molti ribaltamenti prospettici che Pianeta vuoto cerca di fornire al lettore, forse il più importante è quello dei temi dell’immigrazione, e dell’integrazione, affrontati come soluzioni e non come problemi. Nell’ultima parte del saggio, i due autori raccontano l’esempio virtuoso del Canada, che sembra avere imparato dagli errori del passato o da quelli che altri Paesi si ostinano a compiere chiudendo le frontiere. Il 20% dei canadesi non è nato nel Paese e se ci si concentra sull’area metropolitana di Toronto si scopre come la metà della popolazione sia nata all’estero.
In un secolo in cui quasi tutti i Paesi sviluppati vedranno le proprie popolazioni diminuire, il Canada continuerà a crescere in modo vigoroso, e in un mondo in cui le popolazioni stanno già invecchiando, il Canada lo fa più lentamente, perché l’età media degli immigrati è di sette anni inferiore a quella della popolazione generale. Sì, l’invecchiamento dei baby boomer preoccupa i canadesi; sì, l’assistenza sanitaria è già sotto pressione; e sì, il dibattito sull’aumento dell’età pensionabile, sull’importo delle pensioni pubbliche è molto acceso, ma comunque meno acceso che altrove.