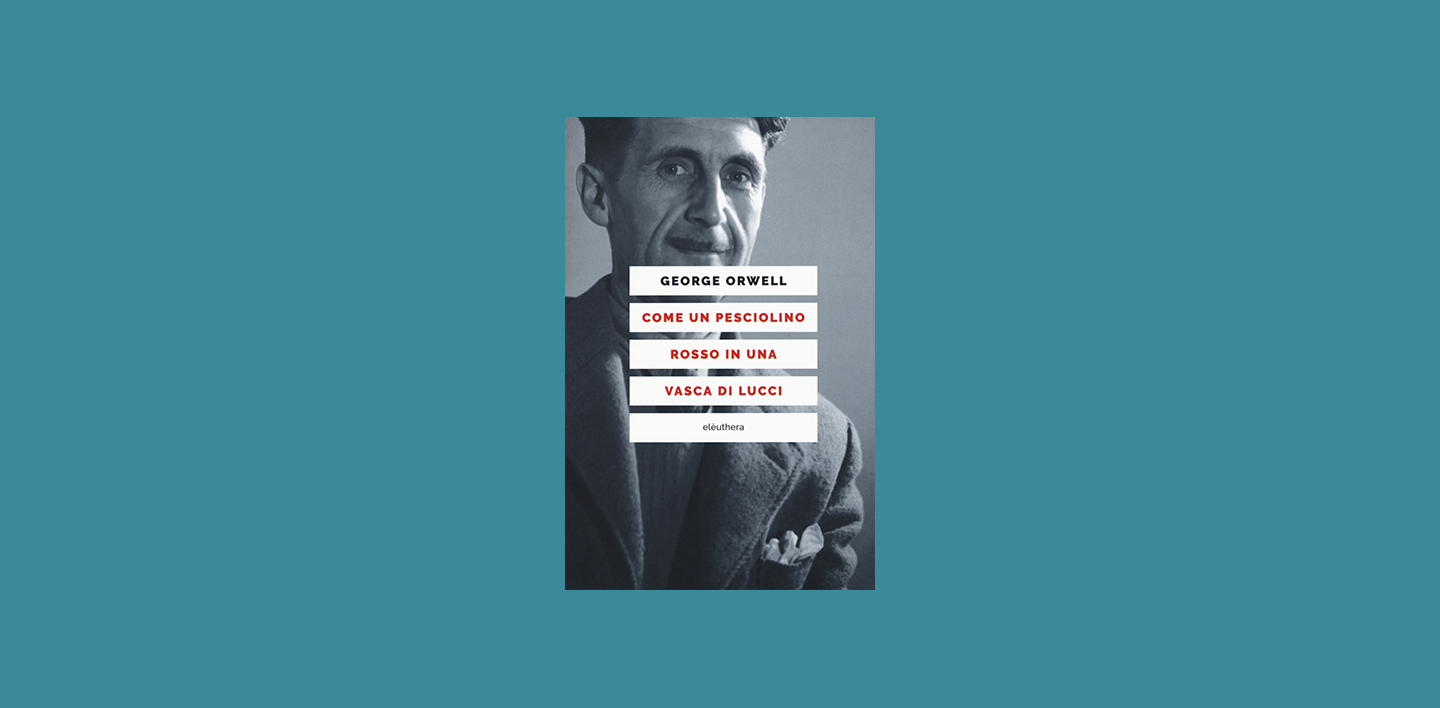
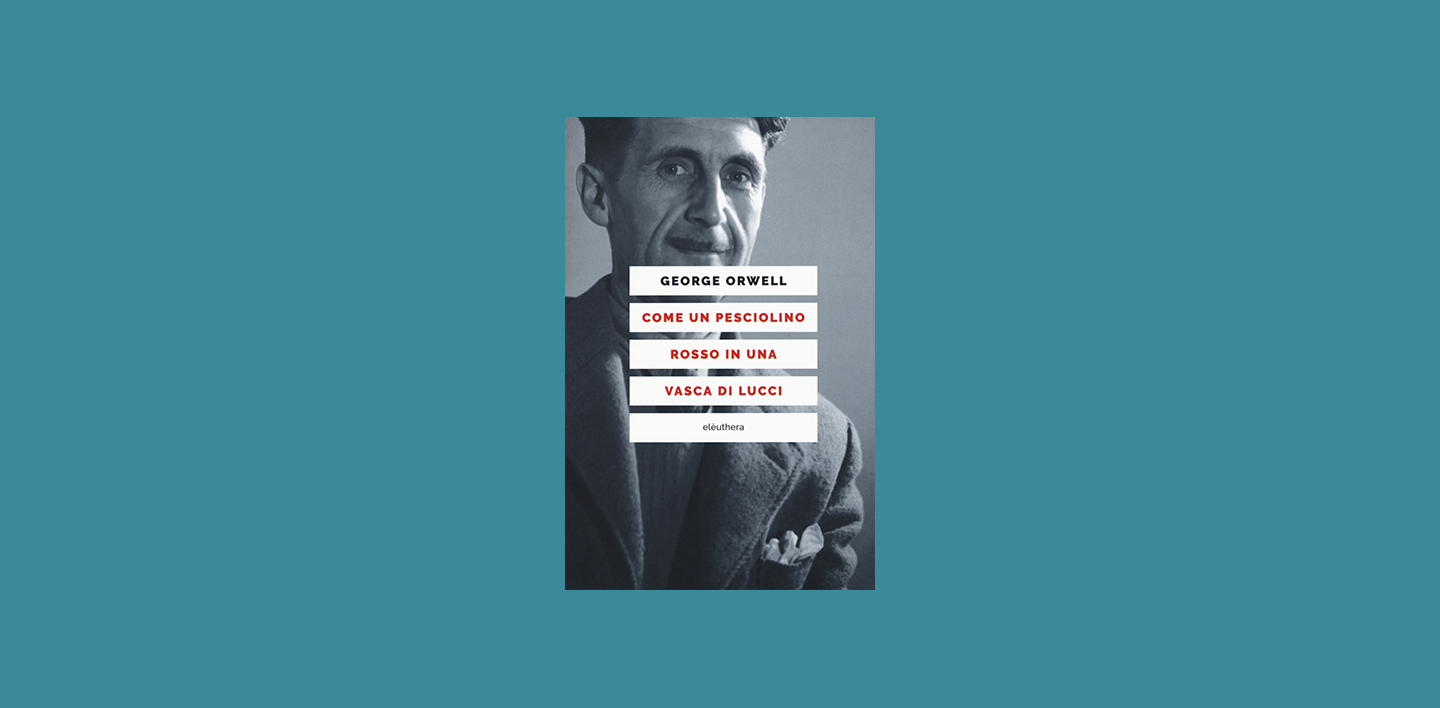
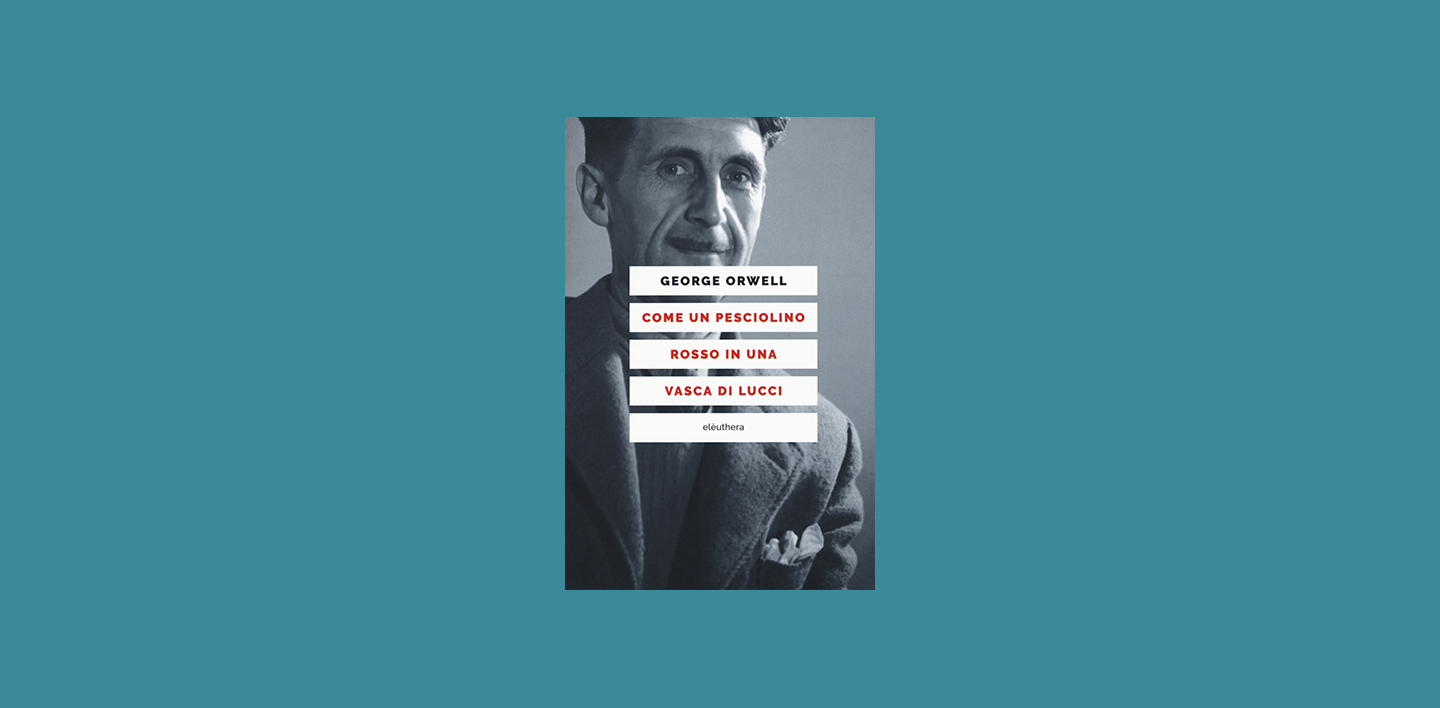
D opo aver dato alle stampe uno dei suoi capolavori nel 1946, La fattoria degli animali, romanzo tanto celebre quanto tristemente profetico, George Orwell pubblica un saggio dal titolo eloquente, Perché scrivo, secondo le sue stesse parole un “contributo alla spiegazione di me stesso”. Si tratta di un documento unico non solo perché, diversamente da quanto forse ci si potrebbe aspettare oggi da qualche più o meno laureato scrittore, esclude la presenza di una qualsiasi vocazione, ma perché in poche pagine libere da “fronzoli e smancerie” inanella la storia della sua vita, intrecciando il racconto delle sue fantasticherie e dei suoi sogni, dei suoi successi e dei suoi fallimenti (pochi in vita i primi rispetto a quello che lo attendeva dopo la morte). Ma soprattutto in queste pagine Orwell racconta con grande semplicità come tutta la sua carriera sia segnata da un unico grande desiderio, quello di rimanere ancorato alla sua natura più intima, alla visione del mondo che si porta dietro sin dall’infanzia, e come quindi ogni pagina tenti di rispecchiare tutto questo (“non posso e non voglio abbandonare completamente la visione del mondo acquisita nell’infanzia. Finché sarò vivo e in buona salute continuerò ad appassionarmi alla prosa, ad amare la superficie della terra e a prender piacere da oggetti solidi”).
Orwell non parla di vocazione, ma comunque si avverte come quello della scrittura sia per lui un destino in grado di soddisfare il desiderio più profondo di lavorare con le parole, oggetti che non possono mai essere neutri poiché si trascinano sempre dietro una forte carica politica. Ed è forse in questo slancio che con maggior certezza si possono incasellare le opere di Orwell, una politica che però è lontana dagli scranni e dai privilegi e si fa invece spaventosamente vicina alla vita di tutti i giorni, all’esistenza degli esseri umani e al loro legame con la comunità. Non è dunque uno scrittore politico nel senso più engagé del termine, ma è invece uno scrittore che sente su di sé una responsabilità verso chi lo legge. Anche in questo senso vanno intesi gli scritti giornalistici di Orwell, impegnato sempre come cronista e reporter, da Parigi nella seconda guerra mondiale o dalla Spagna della guerra civile, come un servizio perpetuo ai suoi lettori, uno strumento, piccolo, per rendere pubbliche le vicende di chi la Storia si trova a subirla e per smascherare le menzogne delle ideologie. In Perché scrivo Orwell insiste molto su questo punto:
quello che ho maggiormente cercato di fare negli ultimi dieci anni è stato di trasformare la scrittura politica in un’arte. Punto di partenza è sempre un sentimento di partigianeria, una sensibilità verso l’ingiustizia.
Per questi motivi, e per mettere in luce un carattere dello scrittore spesso in secondo piano per il grande pubblico, la pubblicazione in italiano dei suoi scritti rappresenta un momento molto importante. I saggi sono pubblicati da Eleuthera, tradotti da Elena Cantoni, sotto il titolo di Come un pesciolino rosso in una vasca di lucci e sono arricchiti da una bella prefazione, che in realtà per estensione e profondità dei contenuti si avvicina più ad una piccola monografia, di Vittorio Giacopini, anche curatore del volume. Nell’Introduzione Giacopini riprende l’altra raccolta di saggi di Orwell Nel ventre della balena, riannoda i fili della sua scrittura saggistica e tratteggia un importante itinerario che lega la sua attività romanzesca a quella di saggista. Ad un certo punto di questo saggio, intitolato felicemente George Orwell o l’indecenza del potere, viene messo in luce uno dei noccioli teorici più importanti per comprendere la scrittura di Orwell, facendo un parallelo assai calzante tra il modo di intendere il potere dello scrittore e quello del filosofo Andrea Caffi, due tra le “menti migliori e più libere degli anni Trenta e Quaranta” perché capaci di vedere i pericoli e i problemi che la politica replicava anziché cancellare.
In Critica della violenza (meritoriamente ripubblicato da Castelvecchi lo scorso anno) infatti Caffi è convinto che la politica non può più salvare l’uomo, ma è anzi lui che deve salvarsi da lei, soprattutto da quando, dopo il 1914, “si è entrati nell’era della violenza totale, indiscriminata e senza tregua”. Così in Orwell si rintraccia sempre, anche nella costruzione narrativa più celebre, 1984, un paradosso evidente: un libro politico scritto da chi dalla politica non si aspetta nulla. È in questo decisivo passaggio che scatta la grandezza dello scrittore, in grado di elevare la propria cifra stilistica sopra il più basso pamphlettismo, con un’unica parola chiave, responsabilità: “non esiste una letteratura genuinamente apolitica e meno che mai in un’epoca come la nostra, in cui paure, odi e convinzioni strettamente politiche sono nella coscienza di tutti”. Scrittura politica suo malgrado verrebbe da dire, ma comunque tale se la si intende come una scelta decisa tra il bene e il male, tra sporcarsi le mani e stare a guardare, tra compromettersi o non schierarsi. Suo bersaglio, come emerge chiaramente da queste pagine, è il demone della teoria con le sua rigidità.
Da questo particolare punto di vista, riveste un ruolo particolare il saggio Riflessioni su Gandhi. Come è noto, Orwell nacque in India e dopo essere cresciuto nel Regno Unito si trasferì molto giovane in Birmania per lavorare nella Polizia Imperiale, esperienza che abbandonò presto e che lo portò a criticare in maniera forte e decisa l’imperialismo britannico – e pungenti sono ancora le pagine in cui si dice disgustato da ciò che lì avveniva. La situazione indiana costituiva allora per lui un aspetto caro e conosciuto e le pagine dedicata a Gandhi sono per questo ancor più significative. Il testo si apre con una frase folgorante che dà già la misura della difficoltà di Orwell ad allinearsi all’opinione comune: “i santi andrebbero sempre considerati colpevoli fino a prova contraria”, frase a cui Orwell affida la sua preoccupazione circa la possibilità che questi personaggi portino a far sentire gli uomini comuni colpevoli per un grado di esposizione, che si trasforma spesso in un’esposizione “mediatica”, minore nelle lotte in nome della libertà e della verità, un dubbio che lo porta a chiedersi provocatoriamente “fino a che punto [Gandhi] era mosso dalla vanità”.
In questo saggio, seppure l’ammirazione per Gandhi non sia assolutamente scalfita e le tappe della sua vita siano raccontate con trasporto e vicinanza, resta però sempre un punto di domanda a cui regolarmente torna Orwell, ovvero sul “tipo di disciplina che Gandhi impose a se stesso”, una disciplina che corre il rischio di portarsi dietro la ricerca di una perfezione che di umano ha ben poco visto che l’essere umano “non spinge l’ascetismo al punto da rendere impossibile il rapporto con gli amici”. Si intravede qui uno dei sentimenti più profondi della scrittura e dell’animo di Orwell, ovvero quel bisogno di vicinanza assoluta verso gli uomini comuni e deboli e verso le loro difficoltà, con un pensiero sempre teso ad immaginare un miglioramento concreto e mai pendente invece verso difficili e vacui eroismi.
Nella sua introduzione Giacopini scrive che se si dovesse pensare a una possibile risposta al drammatico interrogativo di Sisifo per come formulato da Camus (“vi è un solo problema filosofico veramente serio, quello del suicidio”), questa la si potrebbe trovare proprio tra le pagine di Orwell e, viene da aggiungere, in alcuni decisivi passaggi di questo libro. Travolto dalle disgrazie della storia e dalla violenza raggelante degli uomini, fattori che certamente avrebbero potuto dare materiale per la risposta all’interrogativo di Sisifo, Orwell risponde sempre con la vita e il bisogno, continuo e imperituro, di viverla. In un testo dal titolo disorientante, Elogio del rospo, scritto nella primavera del 1946, sta uno dei nuclei più profondi e importanti della poetica orwelliana, che individua, attraverso la metafora della rigenerazione primaverile, la forza del desiderio di vivere, unica e originaria urgenza umana:
Poco prima delle rondini, prima delle giunchiglie, e non molto più tardi dei bucaneve, il rospo saluta l’arrivo della primavera a modo suo… qualcosa – un fremito della terra o forse il semplice aumento di pochi gradi della temperatura – l’ha informato che è tempo di svegliarsi… In quanto alla primavera, neppure le strette e meste vie che circondano la Banca d’Inghilterra sono in grado di escluderla… La primavera è comunemente definita un miracolo e, durante gli ultimi cinque o sei anni, questa frusta immagine ha acquistato nuova vita. A partire dal 1940, ogni febbraio mi sono trovato a pensare che, questa volta, l’inverno sarebbe durato per sempre. Ma Persefone, come i rospi, risorge puntale… È forse un peccato rallegrarsi per la primavera o, per esser più precisi, è politicamente riprovevole, mentre tutti soffriamo, o a ogni modo dovremmo soffrire, sotto il giogo del sistema capitalista, far presente che la vita sovente merita d’esser meglio vissuta per il canto di un merlo, le foglie gialle di un olmo in ottobre, o qualche altro fenomeno naturale che non costa un soldo? […] A ogni modo la primavera è arrivata anche a Londra N.1 e nessuno può impedirvi di goderne… finché non siete veramente malato o soffrite la fame o avete paura o vi ritrovate rinchiuso in una prigione o in un villaggio turistico, la primavera è sempre primavera. Le bombe atomiche si ammassano nelle fabbriche, le polizie si aggirano minacciose nelle città, le menzogne piovono dagli altoparlanti, ma la terra continua a girare intorno al sole e né i dittatori né i burocrati, per quanto profondamente ostili alla cosa, sono in grado di impedirglielo.