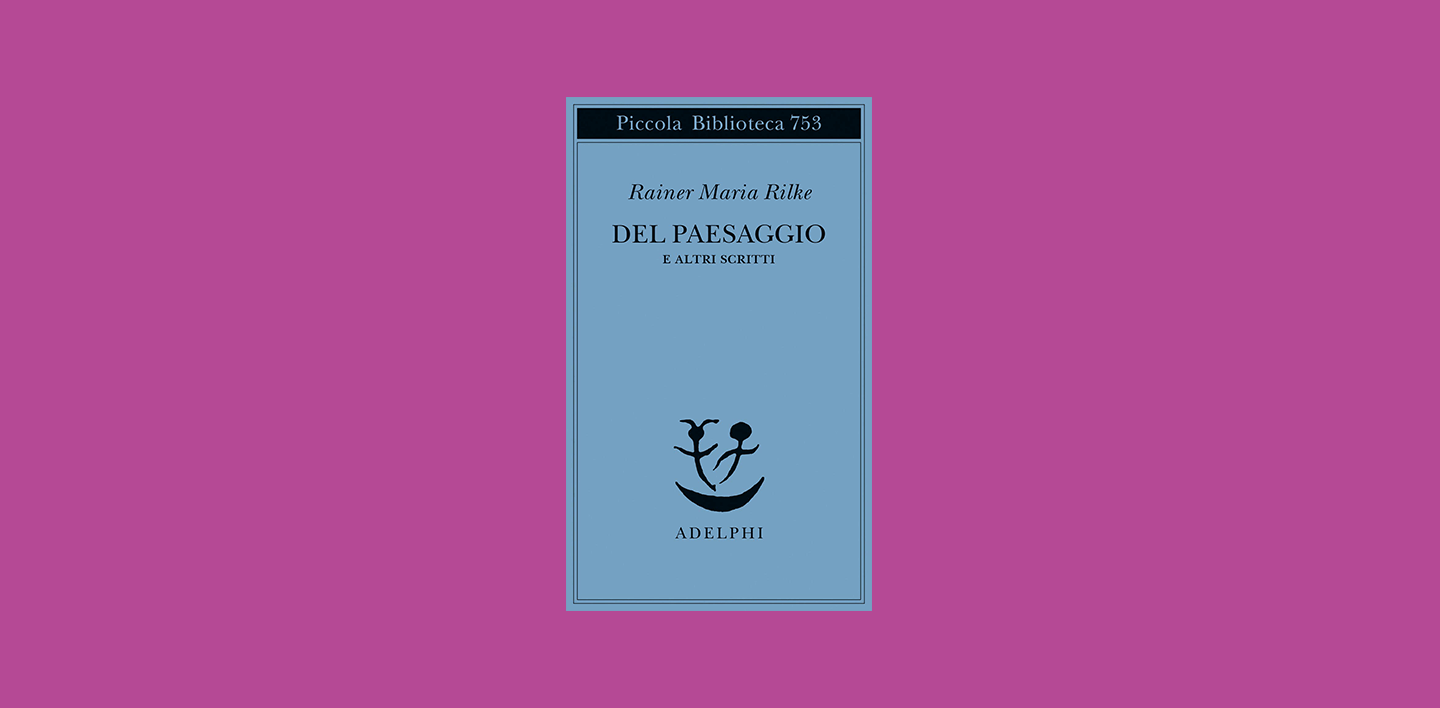
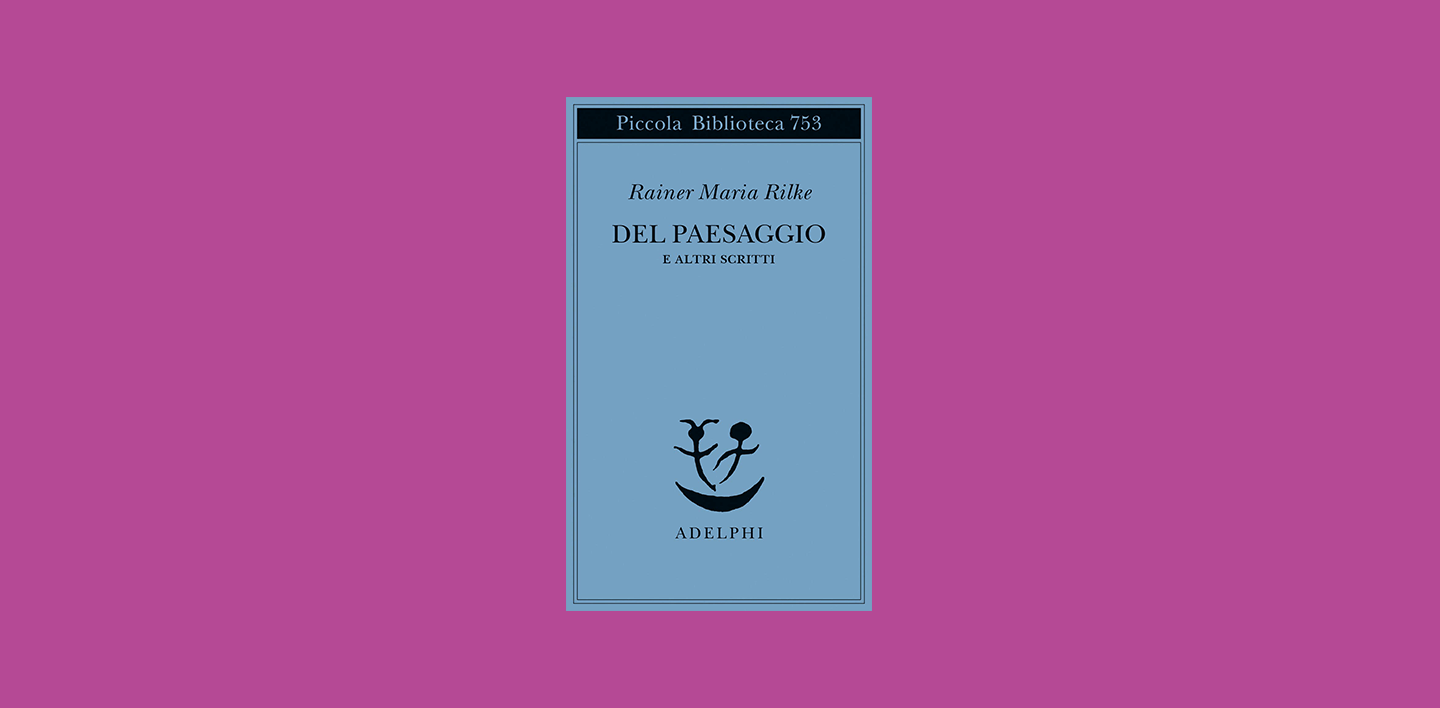
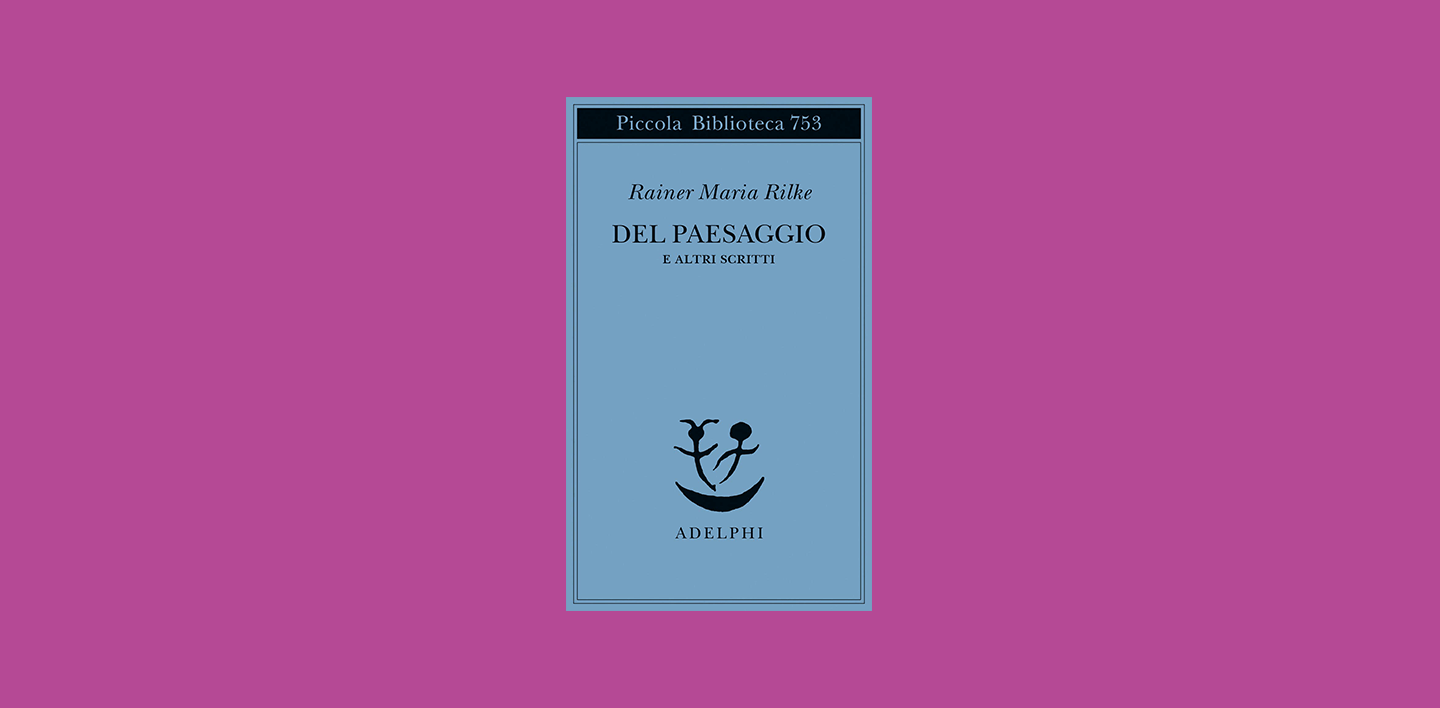
U na notte del 1902 una fanciulla – una Ninfa – apparve in sogno a Rainer Maria Rilke. “La gioia” gli sussurrò “è uno spavento che non si teme”. “Andare attraverso uno spavento sino alla fine: ecco la gioia. Uno spavento di cui si conosce più della lettera iniziale”. Dieci anni dopo, a Duino, ospite nel castello dei Thurn-und-Taxis, il nevrastenico Rilke, sporgendosi dalla falesia carsica sul golfo di Trieste, da Grado all’Istria, fu sopraffatto dalla vertigine, si svuotò di sé e svuotandosi si riempì. E scrisse: “Perché il bello non è | che il principio del terrore, che appena sopportiamo”. Così Rilke attraversò la porta di quello spavento.
Quei due versi fanno parte della prima delle Elegie duinesi, vertice della produzione rilkiana e della poesia del Novecento, completate però solo nel 1922, vent’anni dopo quel sogno. D’altronde, sui grandi eventi Nietzsche aveva avvertito che sono in realtà i più silenziosi. Di cosa accadde durante quel ‘silenzio’, lo apprendiamo dalle prose raccolte da Giorgio Zampa col titolo Del paesaggio e altri scritti, miscellanea che offre gli studi preparatori e le prove generali delle Elegie. In questo florilegio, si può esplorare un laboratorio intimo fatto di costellazioni di ricordi e meditazioni, impressioni d’infanzia e visioni, autobiografia e contraffazione letteraria, corrispondenze reali o a destinatari immaginari, la cui parola chiave è essenzialmente una: rinnovamento.
Rinnovamento di sé, innanzitutto. Sul filo di lama tra gli angeli e l’abisso, in fondo la medesima cosa, la voce di Rilke chiede disperata: “come è possibile vivere se gli elementi della vita ci sono totalmente incomprensibili? Se siamo sempre insufficienti nell’amore, incerti nel decidere e incapaci di fronte alla morte, come è possibile esistere?”. I nervi in fiamme, l’ipersensibilità del corpo, dei sensi e dello spirito, il divino che trema in ogni cosa senza lasciare tregua, lo struggimento costante, umanamente insostenibile – ossia, nel senso più acuto, l’attenzione costante al Tutto, in Rilke, porta a un’oscillazione tra l’ebrezza angosciosa e senza appiglio (come nei Quaderni di Malte Laurids Brigge) e l’anelito estatico, amoroso e panteistico. Perciò il poeta è sempre in cerca di nuovi percorsi e spazi interiori per contenere quel Tutto che travolge, là dove forse angoscia e amore possono darsi entrambi, senza aut-aut.
Rinnovamento dell’essere umano, dunque, perché ciò è possibile solo muovendo dal particolare all’universale. E questo passa mettendo in discussione quanto l’essere umano è stato finora, ossia qualcosa che era possibile unicamente perché Dio e la morte erano stati estromessi, proiettati fuori e lontano “come qualche cosa di non terrestre, ma di successivo, che esiste in altro luogo e diverso”. Solo così la vita “a prezzo di tale distacco parve divenire umana, familiare, possibile, realizzabile, nel senso pieno: nostra”. Eppure, tutto ciò che abbiamo allontanato da noi ritorna, fantasma tremendo, a tormentarci, ignorando le nostre esclusioni, i nostri pallidi tentativi di organizzazione e semplificazione, “e dappertutto intorno a noi la morte è ancora a suo agio e ci guarda dalle fessure delle cose”.
Ma non c’è rinnovamento dell’essere umano, spiega Rilke, senza prima un cambiamento nel nostro rapporto con la natura, già logoro ai tempi in cui scrive. Da qui il tour de force nella storia della pittura di paesaggio che troviamo in alcuni di questi scritti, occasione, per Rilke, di sviluppare una poetica del rapporto tra umano e non-umano.
Non c’è rinnovamento dell’essere umano, senza prima un cambiamento nel nostro rapporto con la natura, già logoro ai tempi in cui Rilke scrive.
“Tutto” spiega “era come un palcoscenico vuoto fino a quando l’uomo non sopravvenne, animando la scena con l’atteggiamento sereno o tragico del suo corpo”. Nell’antichità, giovinezza della specie e dello spirito, il corpo ossia l’umano doveva ancora apparire come una novità tutta da svelare, ergo la predilezione per il nudo. Poi, ormai nell’inoltrata èra cristiana, dopo tanti secoli in cui la terra era ammessa solo come stadio imperfetto teso tra inferno e cielo, gli eterni che garantivano senso e fine all’essere caduco, comparvero, così Rilke, i primi maestri italiani. Costoro, pur volendo ancora, almeno dichiaratamente, “far conoscere il luogo, e nulla più”, misero nella rappresentazione “tanta e così incantevole eloquenza d’innamorati” da offrirci un “inno al creato” in cui stavolta a sembrare nuove erano le cose prima che l’umano (“vedere era continuo stupore, gioia d’infinite scoperte”). Così, la lode del cielo era anche una lode della terra, e viceversa, e si apriva nelle arti una strada nuova.
Si può dire, con Rilke, che fu la stanchezza verso l’umano maturata in seno al cristianesimo a spingere verso il non-umano del paesaggio. E, tuttavia, ancora non si guardava davvero al luogo, ma a se stessi: il paesaggio era mero “pretesto per un sentimento umano”. Con tutta la lentezza delle grandi trasformazioni, per arrivare al non-umano del paesaggio era prima necessario che questo si mostrasse “estraneo all’uomo come la foresta inviolata di un’isola ancora da scoprire”: remoto, inconoscibile, astratto. Perché è solo svelandosi come altro da noi, spiega Rilke, che il non-umano diventa “nei confronti del nostro destino un paragone liberatore”, che nella sua indifferenza e chiusura in sé suggerisce “un nuovo significato alla nostra vita”, il rinnovamento tanto atteso. Ma come?
Più al paesaggio riconosciamo la sua autonomia e lo allontaniamo dall’umano, continua Rilke, più ci avviciniamo al suo cuore. Sembra un paradosso: “Si cominciò infatti a capire la natura quando non la si capì più”. O ancora:
Siamo soliti dedurre molte cose dalle mani delle creature umane, e tutto dal loro viso su cui, come un quadrante, sono visibili le ore che sostengono e cullano la loro anima. Ma il paesaggio è là, privo di mani, e non ha viso; oppure è tutto viso, e l’immensa grandezza dei suoi tratti spaventa e schiaccia l’uomo.
Quando la natura ci appare come “l’altra parte, indifferente, incapace di accoglierci”, quando ci svegliamo in essa “solitari, usciti da un mondo solitario”, solo allora la realtà ci si offre nel “mistero di una vita che non è la nostra vita”. “La Nature a lieu, on n’y ajoutera pas”, scriveva Mallarmé.
Siamo già a Duino, prima elegia:
Chi, se gridassi, mi udrebbe
[…]Ah, e a chi
possiamo rivolgerci? Non agli angeli, non agli uomini,
e gli animali lo fiutano che non ci si affida a noi,
di casa nel mondo interpretato. Ci resta forse
un albero là sul pendio
Solo tra le cose, l’essere umano impara allora a farsi cosa a sua volta, come il resto: senza pathos, in piena osservanza delle leggi eterne che regolano il tutto. E così il mondo si fa paesaggio in senso pieno e l’umano si lascia dire dal non-umano, in cui è assorbito. È questo il Dinggedicht (“poesia delle cose”) con cui Rilke apre la porta per i suoi successori, da W. H. Auden ad Andrea Zanzotto (in riferimento al quale Fernando Bandini ha parlato di un movimento dal “paesaggio paesaggito” al “paesaggio paesaggente”).
Ma a Rilke non basta. Perché l’umano, in seno al non-umano, non si annulla; resta muto, sì, ma ricettivo, in posizione di ascolto. Massimamente allontanatosi da sé, raggiunto l’assolutamente altro da sé del desertico, il non-umano nella forma più assoluta e siderale, è proprio là che si ritrova, con tutta la gloria degli eterni ritorni, nel senso pieno del proprio essere, l’umano in forma parimenti assoluta. Lo stesso fece più tardi il ‘rilkiano’ Edward Weston: le dune desertiche delle sue fotografie antipittorialiste sono forma pura, spogliata di ogni traccia di vita, e tuttavia restituiscono le geometrie del corpo femminile nella piena armonia di un’inattesa Einfühlung universale.
E l’umano è destinato a tornare infatti nelle Elegie duinesi, non solo punto di partenza ma anche approdo o meglio crocevia, aperto al mondo delle cose, a Dio, alla morte. Di questo vertiginoso percorso sono testimoni le prose qui proposte, segnate appunto da una costante volontà di ‘far nuovo’, a partire dalla poesia stessa, e dal poeta in sé.
Perché il poeta – in generale, l’artista – è, per Rilke, vate fra gli ultimi, l’unico in grado di avvicinarsi al mistero della natura, svelarne una sillaba e restituirla all’umanità. In queste pagine, lucide o tortuose, immediate o impervie, Rilke postula un’arte che abbia come argomento e fine “l’equilibrio tra il singolo e l’universo”, quale furono poi gli angeli duinesi a suggerirgli.
Non è solo un tentativo di comprendere chi si è, benché certo il poeta, in quanto tale, non possa farne a meno: Rilke è dopotutto l’autore di Ewald Tragy e del citato Malte Laurids Brigge, esempi di Künstlerroman ossia di ermeneutica della propria esperienza poetica. Per farsi cosa, per sparire nella propria opera come i costruttori di cattedrali, per toccare davvero con mano l’universale e fare da “cassa di risonanza per le cose”, come scrive Marco Rispoli nella postfazione, il poeta deve rinnovarsi, ossia spogliarsi di tutto e farsi nuovo, di nuovo, tornare al proprio grado zero, al nucleo essenziale e sempreverde della propria natura ed esperienza.
Sempreverde, sì, e forse perché mai il poeta ha smesso di lamentare – mai da lì si è spostato – quella cesura originaria tra l’umano e il non-umano, quando termina l’idillio dell’infanzia e “sopraggiunge la primavera, sebbene [siamo] tristi, le rose sbocciano e le notti sono piene d’usignoli, sebbene [noi desideriamo] morire”.
Solo il poeta, in cui si conserva la certezza dell’unità originaria, può reggere il peso di ciò che è stato e ciò che verrà. Ma per cantarlo ha bisogno di percorsi intentati, che qui Rilke ipotizza, saggia, esplora, in uno studio ventennale sulla novità dell’eterno che è, di fatto, anche una dichiarazione di fiducia nella giovinezza dei nuovi (“Dobbiamo diventare bambini, se vogliamo raggiungere il sublime”).
È in questo senso che vanno lette le lettere qui raccolte che Rilke scrisse al giovanissimo Balthasar Klossowski, destinato a essere Balthus, il grande pittore di Ninfe del Novecento. O le pagine – meravigliose – sull’educazione, in cui teorizza scuole immuni dalle leggi di pietra del mondo adulto, che forzano la realtà e uccidono di conformismo la spontaneità della giovinezza (caso dei più curiosi che oggi la foresteria del castello di Duino ospiti uno dei Collegi del Mondo Unito, versione secolare dell’utopia pedagogica di Kurt Hahn).
Dove conduce il percorso qui tracciato?
Forse a quella specie di “amore intransitivo” (Rispoli) che sa accettare e vivere e ringraziare anche della perdita, e che Rilke insegna al piccolo Balthus. Un amore senza possesso e senza appuntamento col dovere, un amore addirittura senza oggetto, che è forza e volontà di potenza più che rapporto, e che è a sua volta cosa in sé, paesaggio.
“Gli amanti” scrive Rilke in una lettera del 1915 “sperperano le immense ricchezze dei loro cuori; di essi si può dire che Dio diventa per loro un cibo e che la morte non li offende: perché sono pieni di morte, in quanto sono pieni di vita”. Piene di morte e piene di vita sono infatti queste prose, spesso perfette, tese verso il compimento di quella visione di una gioia situata oltre lo spavento supremo.
E se Cristo per noi salì in cima all’albero scheletrico della croce, si trattò di “un gesto e non [d’]un soggiorno”, dice il nietzscheano Rilke, perciò “cessate di respingerci in perpetuo nella fatica e nel travaglio che lui ha dovuto durare […] per ‘redimerci’. Fate che per noi si inizi infine tale stato di redenzione”. Così, forse, e solo così, vedremo che anche la morte è “là solo per indicare la direzione del sole”.
Sembra di sentire già l’ultima elegia, per sempre sul bordo del precipizio duinese che si getta nel mare:
E noi, che pensiamo alla felicità
come a cosa che sale, sentiremmo il fremito,
che quasi ci spaventa,
di cosa felice che cade.