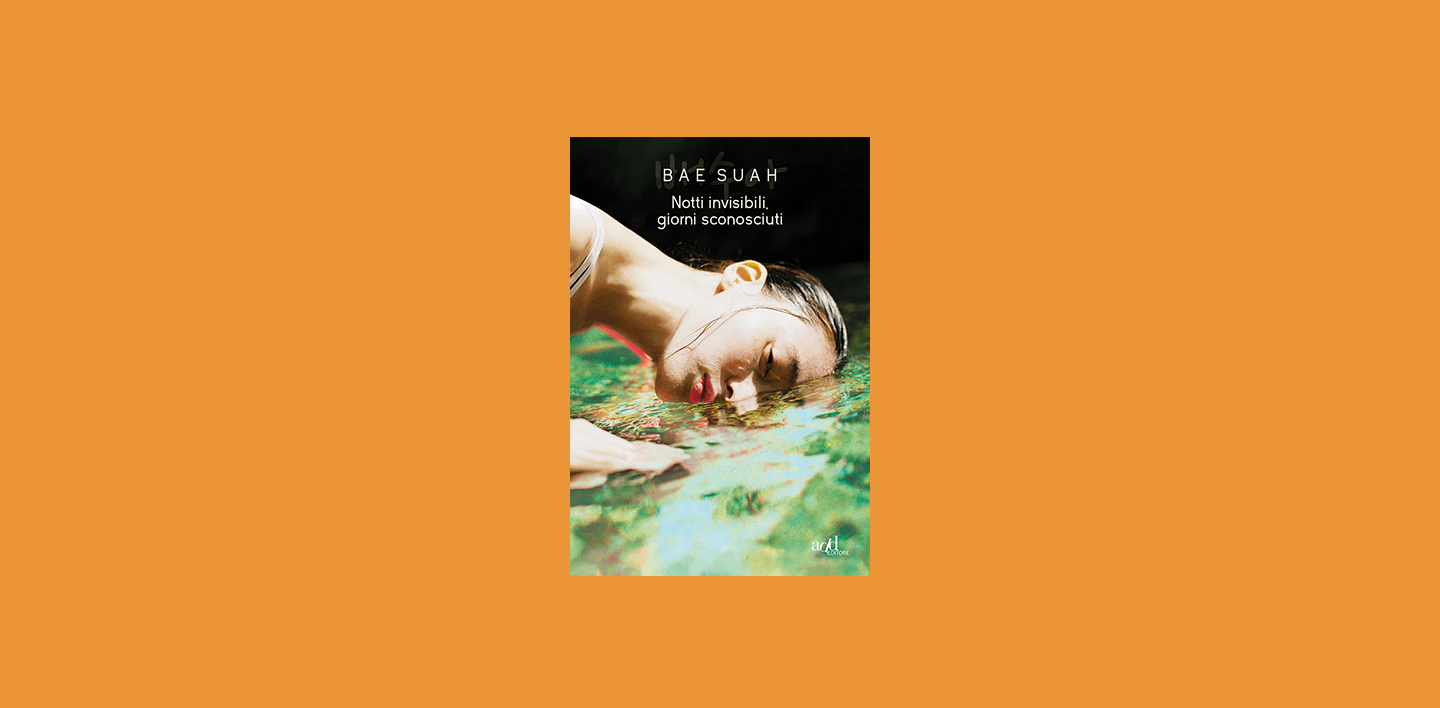
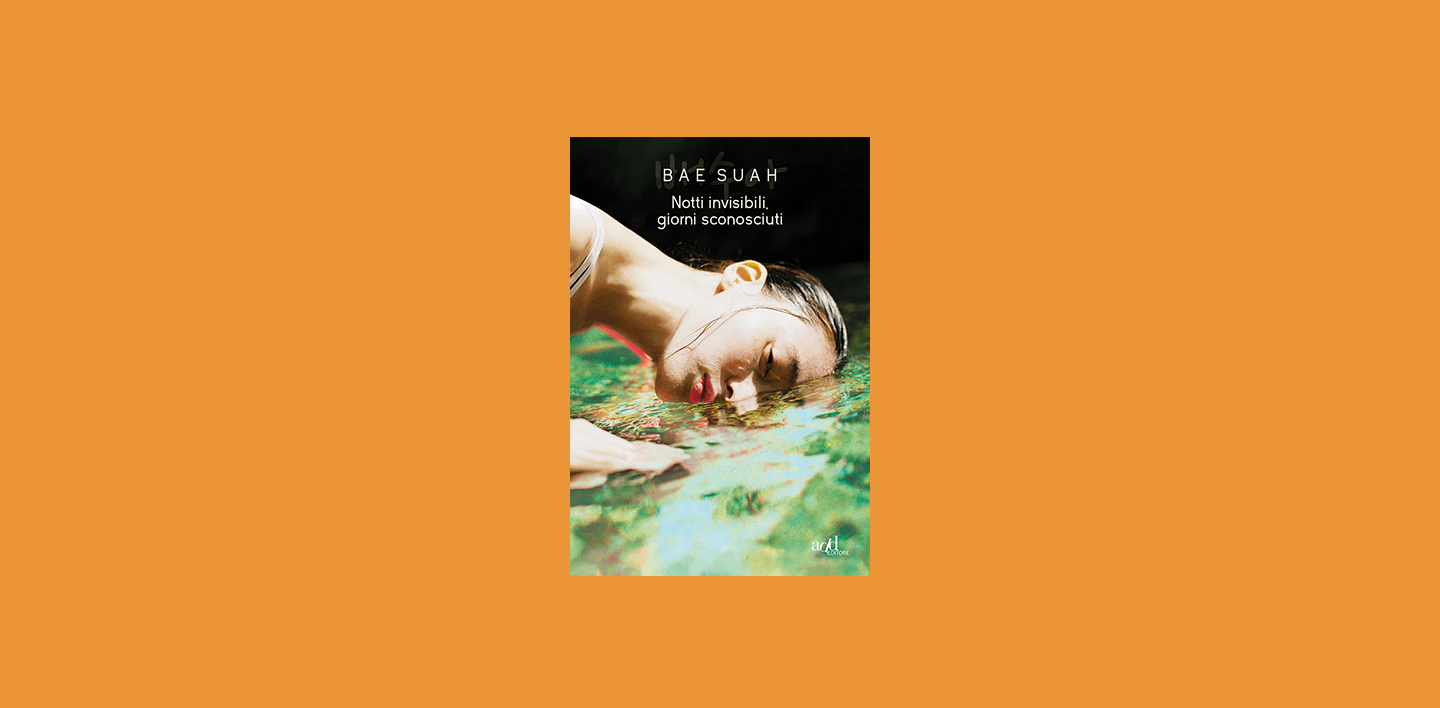
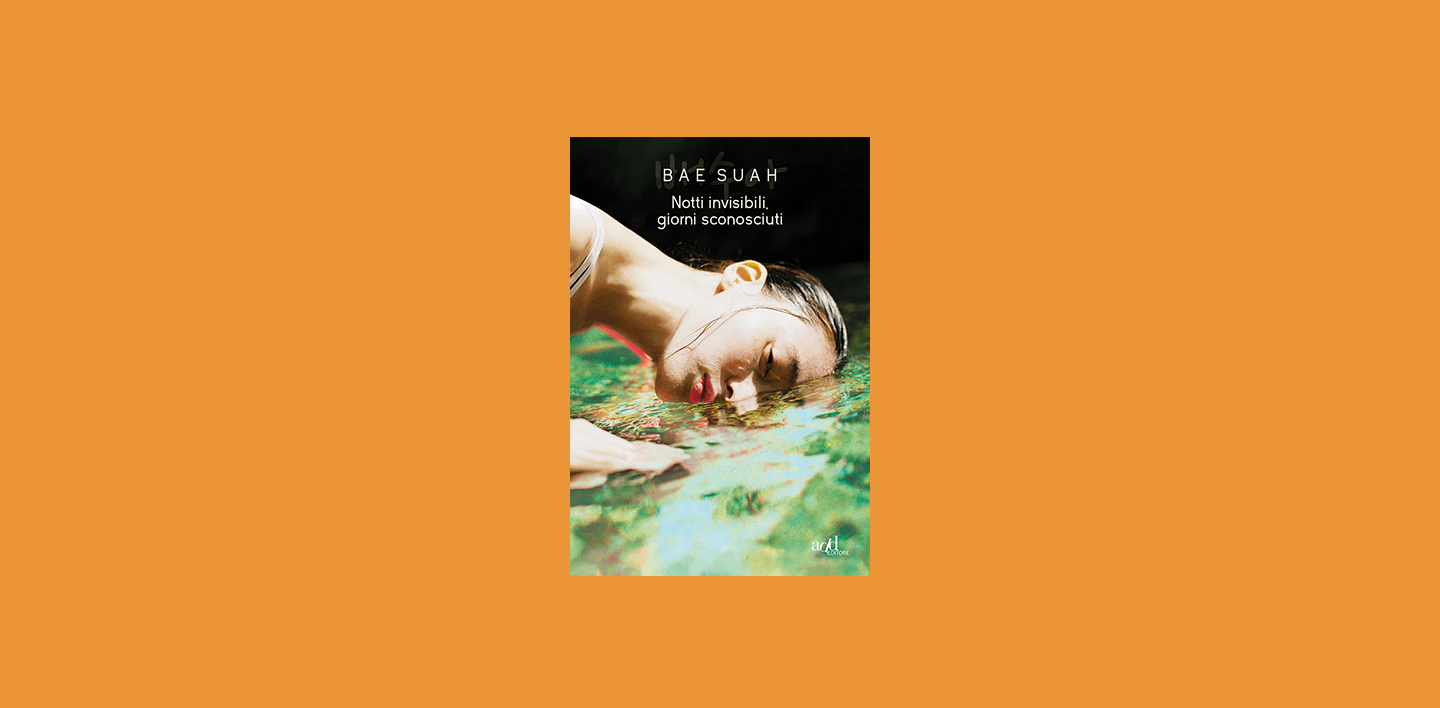
H o immaginato una donna con indosso un vestito bianco, che vaga in una grande città, durante una notte che gronda umidità quasi fino a far girare la testa” racconta Bae Suah in un’intervista a proposito del suo primo romanzo pubblicato in Italia. Da quell’immagine nasce Notti invisibili, giorni sconosciuti (add editore, traduzione dal coreano di Andrea de Benedittis), dove l’autrice sudcoreana – considerata una della scrittrici più audaci del suo paese, per l’uso non convenzionale della lingua e per i suoi personaggi femminili – segue per una notte e un giorno i passi allucinati di Ayami, una ex attrice impiegata in un teatro sonoro di Seul, dove sta per andare in scena l’ultimo spettacolo prima della chiusura definitiva.
Notti invisibili, giorni sconosciuti inizia nel teatro buio, un bozzolo fresco e riparato dal caldo intollerabile di Seul, dove aleggia “una litania sommessa e ininterrotta”, forse il suono di una radio. Dev’essere “un’ombra sonora rimasta in circolazione” nota il direttore del teatro, segnalando fin dalle prime pagine l’atmosfera onirica del romanzo. Quest’ombra sonora sarà uno dei pochi punti fermi che permettono di orientarsi in una storia che si frammenta e poi ricongiunge, in un gioco di specchi e di mondi paralleli. Altri punti fermi sono i personaggi (Ayami, il direttore del teatro, la maestra di tedesco di Ayami), alcuni luoghi (il teatro sonoro, la casa della maestra di tedesco, il piazzale degli autobus), ma soprattutto certe sensazioni ricorrenti – come se fossero queste i veri cardini su cui si innesta la realtà: “una lunga risata che sembrava tanto il belato di una capra”; il nome di un poeta, Kim Ch’ŏlssŏk, che “ricorda il suono di qualcuno che spala la terra sulla sua tomba”; il gesto di lasciar scivolare le dita fino “a pigiare un punto esatto del polso, quasi come se volesse misurare il battito”. E poi una visione così frequente da diventare il punto di sutura dei piani scomposti e intrecciati del racconto:
anche se non soffiava un filo di vento, la gonna della donna prese a gonfiarsi come un vecchio strofinaccio e, nel sollevarsi, scoprì le gambe scarne e percorse dai fasci arrossati dei muscoli, i piedini pateticamente piccoli nelle scarpe che brillavano quasi fossero nuove, ma che apparivano invece di una qualità scadente. Tra i capelli si affacciò un rivolo di sudore che le rigò il viso butterato, mentre da sotto la gonna fuoriusciva un odore simile a quello di un frutto molliccio, misto a quello di tabacco e al puzzo di bucato umido e d’incarto di pesce.
La donna in questione è a volte Ayami, altre una poetessa, forse la madre oppure la maestra di tedesco. L’immagine delle gambe scoperte da un refolo di vento è insistente ed enigmatica come un sortilegio.
La vicenda è ben riassunta nelle parole dell’autrice – “una donna con indosso un vestito bianco, che vaga in una grande città durante una notte che gronda umidità” –, che dice di aver concepito il romanzo come un giallo. Un cadavere c’è, “nascosto nell’intercapedine tra il soffitto e il tetto”, ma mancano gli indizi, i sospettati, il movente, un’indagine e soprattutto la ferrea logica che solitamente conduce alla soluzione del caso. Notti invisibili, giorni sconosciuti assomiglia piuttosto al genere di ricerca che guida una seduta spiritica, affacciata su un’altra dimensione, e in cui l’apparizione è preceduta da segnali arcani, nascosti nel tessuto sensoriale del mondo, da interpretare secondo un senso nuovo.
Il confine tra sogno e realtà è labile, si alternano momenti in cui la percezione dell’ambiente si avvicina a un piano realistico per poi deflagrare all’improvviso. Il calore e l’umidità soffocante dell’estate a Seul diventano un’esplosione nucleare:
in quel forno crematorio, era tutto un crepitio di fiamme che fuoriuscivano dalle spesse pareti degli edifici in cemento, dalle titaniche strutture in ferro massiccio e vetro e dal bollente asfalto che foderava il suolo; tutti gli organismi che uscivano allo scoperto – carne, pelle, occhi, peli – si carbonizzavano insieme in quel calore, colando nelle strade diventate crateri e bracieri ardenti. Dovunque si volgesse lo sguardo, migliaia di frecce infuocate inferivano ustioni mortali a occhi e pelle.
Non è l’unica minaccia evocata; dalla dimensione onirica emergono elementi della storia recente della società sudcoreana: il coprifuoco, i blackout che lasciano la città immersa nel buio, il confine ferito con la Corea del Nord. Per un lettore occidentale il senso di straniamento è accentuato dalla distanza culturale. Nelle prime pagine è fortissimo l’istinto di anticipare il romanzo, provare a prevederne la struttura, l’andamento. Ma Bae Suah è così abile nel gestire il movimento del racconto, a fondere realtà e illusione sul piano lirico – un’abilità che può ricordare Sebald e Pessoa, non a caso due degli autori tradotti da Suah in coreano –, che pian piano il lettore accetta il disorientamento e l’abbandono della progressione razionale. Diventa possibile, così, che un refolo di vento sollevi la cappa di umidità rivelando delle gambe scarne e percorse dai fasci arrossati dei muscoli, una ciocca di capelli che si sposta da un viso butterato, l’eventualità che si tratti tutto di un sogno, o che si stia camminando in bilico tra due mondi paralleli.