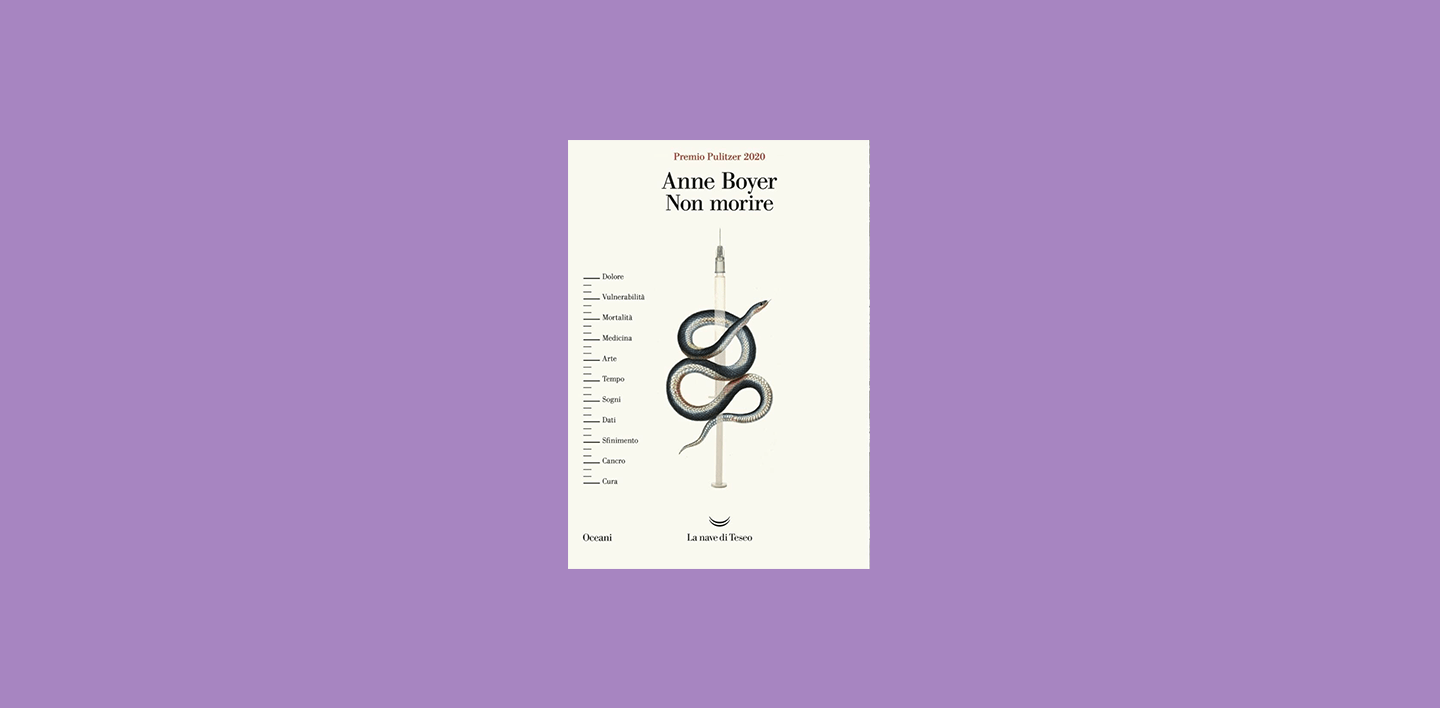
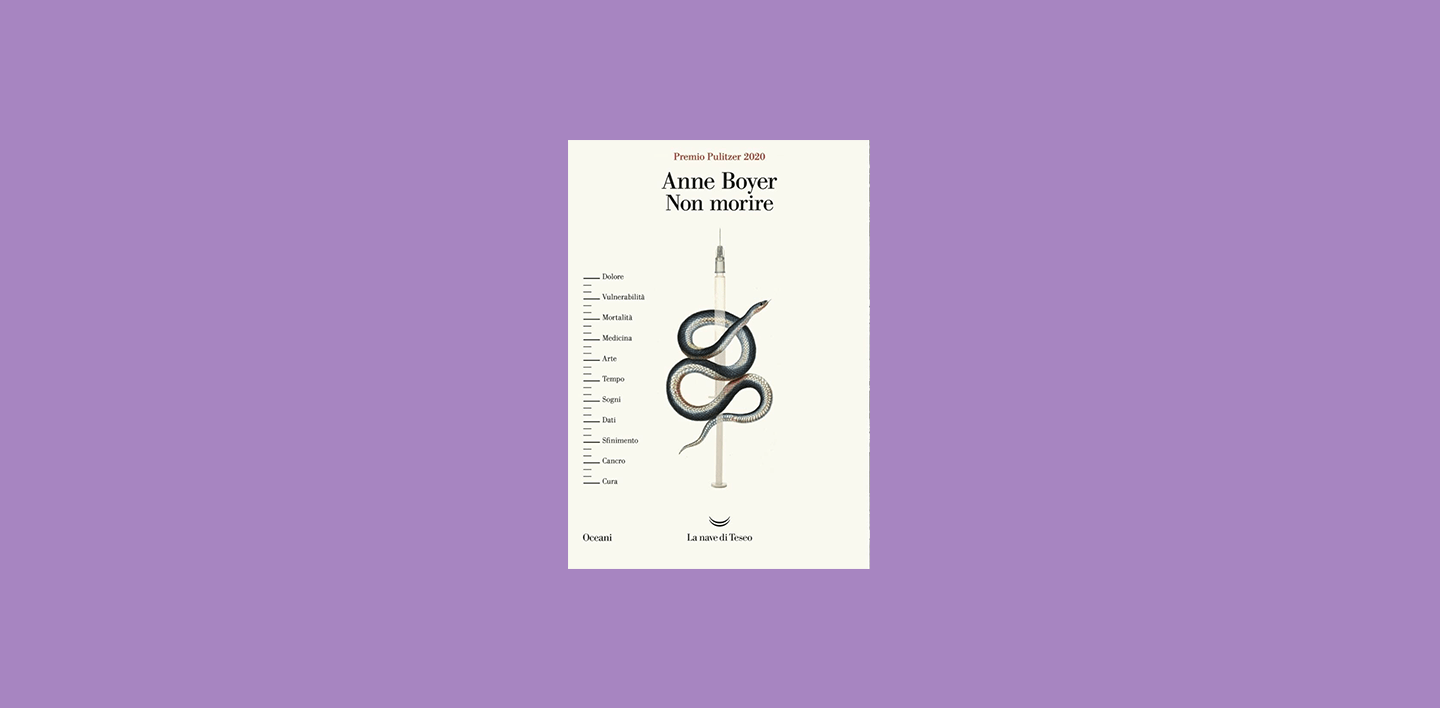
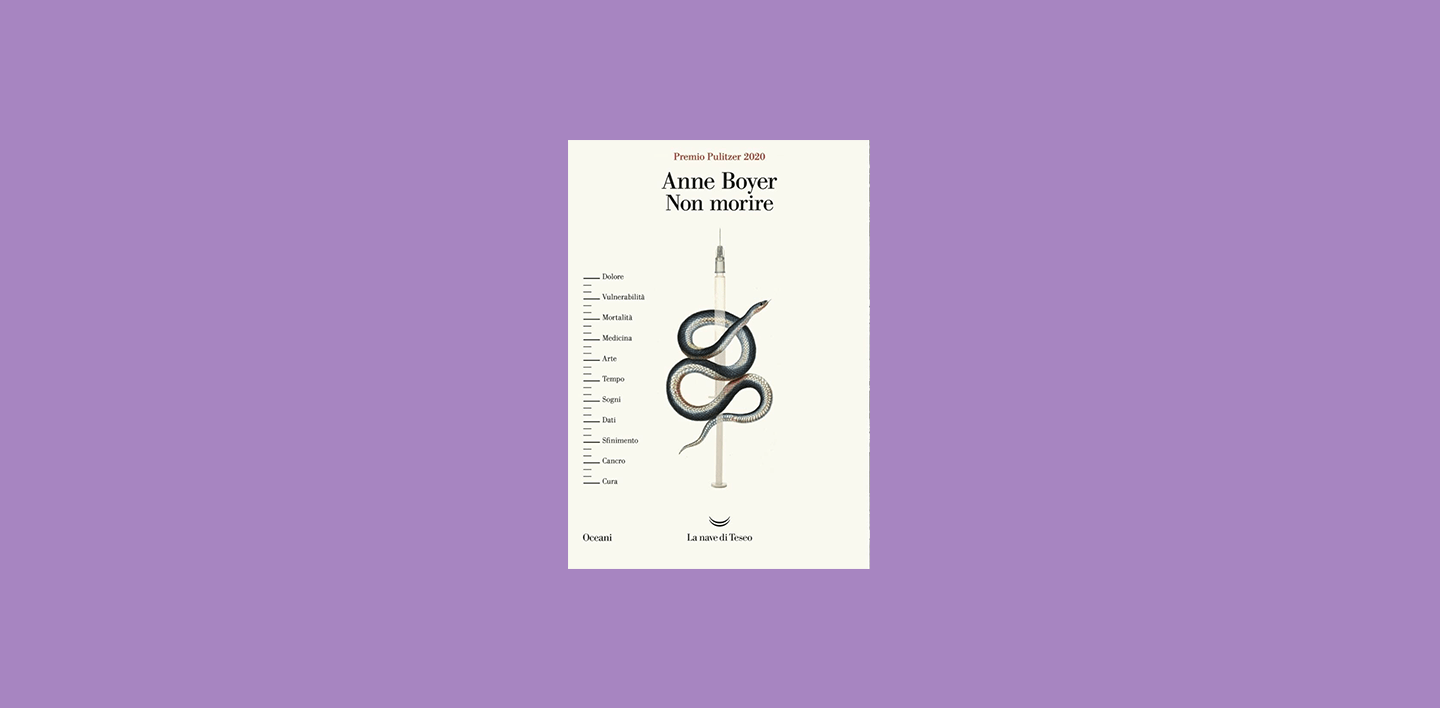
I l cancro alla mammella triplo negativo non ha ucciso la poetessa e saggista americana Anne Boyer, intenta, dalla diagnosi del 2014, a scrivere e ordinare le prose che formano Non morire (edito in Italia da La nave di Teseo), il racconto del suo processo di non-morte. In una sua poesia che rimbalza in rete dal 2015, o anche prima, dal 2013, intitolata What Resembles The Grave But Isn’t, “Ciò che assomiglia alla fossa ma non lo è”, Boyer descrive l’inevitabile caduta dentro buchi che, appunto, assomigliano alla fossa ma non lo sono. Buchi da cui bisogna rialzarsi, uscire, camminare verso la buca finale sapendo che si cadrà dentro un’altra buca, poi un’altra, poi una più profonda, uguale alla fossa salvo che non lo è, da cui uscire dicendo “guardate l’abilità e l’animo con cui emergo da ciò che assomiglia alla fossa ma non lo è!” [traduzione mia]. Non morire è lo svolgimento concreto di questa immagine, e un dispaccio da un luogo preciso: l’industria sanitaria statunitense in larga parte privata – accessibile tramite la stipula di polizze spesso legate all’impiego lavorativo – e perciò suscettibile a interessi economici che deformano il rapporto della persona con la malattia, la cura e il dolore secondo dinamiche debilitanti, idealmente estranee ai beneficiari di un Sistema Sanitario Nazionale. Anche il soggetto di Boyer è preciso, è il paradosso del cancro: una malattia che, sebbene prescriva una terapia distruttiva tanto del tumore quanto del corpo da cui è stato prodotto, si accompagna a una cultura della degenza incentrata (soprattutto quando sono parti “femminili” a essere colpite) sulla cura del proprio aspetto per camuffare i segni della patologia, l’atteggiamento positivo e la responsabilità individuale tanto nelle cause che nella “lotta” per “vincere la battaglia”.
La metastasi, la chemioterapia, la mastectomia, la ricostruzione del seno accomunano Boyer a una costellazione di pensatrici sopravvissute che hanno vissuto e raccontato la malattia – Audre Lorde limpida in The Cancer Journals (“I diari del cancro”, 1980), Susan Sontag di sbieco in Illness as Metaphor (“Malattia come metafora”, 1978), Fanny Burney icastica nel suo epistolario “Account from Paris of a terrible operation — 1812” (“Resoconto da Parigi di un’operazione terribile”) – ed evocano una sororità letteraria pari alla rete di sostegno amicale che ha, di fatto, assicurato la sopravvivenza quotidiana di Boyer. E infatti:
Prima di ammalarmi, il mondo di queste defunte mi aveva fatto compagnia. Avevano immaginato nuove strutture per il mondo e insieme al mondo, le possibilità reali di questo pianeta, e nel mio quarantunesimo anno di vita raggruppai queste scrittrici intorno a me, distaccata anch’io sempre più dalle cose dei vivi.
Non morire è, prima di tutto, un diario della malattia, e l’occasionale immagine cruda conferma il carattere memorialistico del libro – ciocche di capelli per terra, sacche di drenaggio appese ai fianchi, aghi infilzati dentro port-a-cath aperti sopra il cuore – ma le forme scelte da Boyer rispondono anche ad altre urgenze. C’è la dichiarazione politica, a denuncia del capitalismo farmacologico che trae profitto dai corpi ammalati; il bisogno filosofico, a testimonianza della possibilità della mente di speculare senza teoremi, per balzi di fantasia; e un’esigenza logistica, che svela “il lavoro della costruzione del mondo, cioè il mondo bello da vedere, e l’operato discreto della sua manutenzione una volta che è stato creato”.
Ma Anne Boyer scrive poesie, e sebbene il soggetto sia lugubre, c’è sempre una volontà di diletto tra le sue pagine. Il suo poetare risponde euforico alla mancanza di metrica con composizioni linguistiche capricciose, che non intendono sostenere alcunché – sintomo dell’impossibilità che il racconto sia fedele – e perciò pronte a frammentarsi, senza concludersi e senza nemmeno abbozzare una tesi. In un trattato sul dolore “fatto di appunti e di esordi”, ma che occupa lo spazio di un intero saggio, la poesia riemerge nel tono sapienziale, la prosa si fa catalogica e il racconto della scienza viene spogliato di tutto il suo potenziale profetico. L’incedere è solenne eppure precipitoso, spinto da un’urgenza tale per cui è necessario inventare parole nuove, crasi o neologismi che Boyer tiene insieme con trattini, per indicare cose che esistono senza nome. La traduzione elastica di Viola Di Grado tiene in conto tutto ciò, e – oltre a nascondere tante micro-traduzioni delle opere citate – rivela l’inglese multiforme di Boyer in un italiano esatto e conciso, rispettandone i momenti più ermetici senza calcarne l’esplicazione.
Lo sforzo di Boyer è dedicato, principalmente, all’immaginazione di un presente alternativo – da non scambiare per un futuro utopico – in cui cose belle sono visualizzate insieme, e non solo in evidenza del male terreno di cui il corpo di Anne Boyer porta testimonianza. Il dolore non è il contrario della bellezza, insiste Boyer, e subito materializza un candelabro ornato sopra un palo della flebo, disegna un’urna greca caleidoscopica sulle sacche di medicinali chemioterapici, legge sentieri d’irrigazione sulle guance bagnate di una paziente che piange.
così è per attraversare il cancro che ho avuto bisogno di desiderare ogni cosa intorno a me con estremismo estetico. Ho avuto bisogno di sognare occhi aperti bare colme di miele per imbalsamazioni, di inventare religioni speculative, di scrivere polemiche, di vendicarmi, e di concepire una versione nuova di zecca del concetto di funerale, stilando liste di tutti i componenti elettronici che le nostre anime dovrebbero portare con sé nell’aldilà, che è un’altra cosa che ho tentato di reinventare.
Per Boyer, l’impegno dell’immaginazione per ricordarsi come restare attaccata alla vita è tale da rendere necessario il ribaltamento dell’azione creativa, che investe tutto, anche la negazione del proprio desiderio di restare viva, e materializza l’indicibile propria scomparsa:
Immaginavo una nuova struttura per il mondo, come avevo sempre fatto, e poi facevo le prove del mio trapasso, sbucciando il desiderio via da me come togliendomi i vestiti. La mia attività scemò, il mio attaccamento si rimpicciolì: poi le mie ambizioni si fecero tratte – ero in grado di amare a una lunghezza d’onda maggiore e proprio per questo di immaginare una forma più spaziosa di amore.
Da qui nasce il progetto per il tempio delle lacrime di Giulietta Masina, un “luogo di pianto pubblico” in cui ritrovarsi per essere tristi insieme e piangere senza nascondere le smorfie, riparate da “gargoyles fatti di sudori notturni, modanature fatte di minuti interminabili, travi di sostegno fatte di non-riesco-ad-andare-avanti-devo-andare-avanti”. Dalla necessità di far capire quanto faccia male, Boyer immagina “un turismo del corpo o uno scambio somatico in cui possano temporaneamente abitare i sensi di una persona sofferente” in cui l’implorazione che tutto finisca è tanto più violenta quanto più intenso il dolore su una scala da 1 – le unghie che si staccano – a 10 – l’inadeguatezza comunicativa di ogni genere. Ma Boyer è ostinata a impedire che la sua agonia sia svilita perché foriera di pensiero estetico: malattia e degenza non sono una “semplice pena semiotica”, un “problema artistico” che può darle materiale per scrivere, perché la paura di morire lasciando sola sua figlia, con la certezza che il suo lavoro di anni sarà dimenticato, è così gigantesca da dover essere nominata solo una volta, a fine paragrafo. Per dimostrare la fatica della malattia, Boyer riporta un paragrafo di “grammatica nuda del mio dolore”, un passaggio sgrammaticato, l’ortografia a pezzi, estratto grezzo dal quaderno tenuto vicino al capezzale:
come siv a avanti coìs giorni finalmente si inabissano in un modo impossibile ma ho una luce sulla faccia che mi arllegr e ho preso un ibuprofencc poi devo prendere più vitamina d fingere ogni alba il mondo brucia ieri notte mentre dormivo ho dormito in un dolore vrtuoso.
Il cancro non diventa mai una metafora per descrivere l’eziologia delle afflizioni del mondo, né viene nascosto dietro pseudonimi linguistici – il “male incurabile” – che ne mistificano il reale potenziale devastante. È Boyer che lo afferma:
Non voglio raccontare il cancro nel modo in cui mi hanno insegnato a farlo. Quello di una persona che riceve una diagnosi, una terapia, e poi vive o muore. Se vive sarà un’eroina. Se muore sarà uno snodo narrativo.
La narrazione è solo vagamente cronologica, c’è un inizio, la diagnosi, uno svolgimento, la cura chemioterapica e la cura quotidiana, e l’esistenza stessa del libro ne constata il lieto fine, l’autrice è viva, è sopravvissuta. Il nodulo di oltre tre centimetri viene asportato – incenerito insieme a entrambi i seni –la chemioterapia funziona, Boyer viene dichiarata cancer free e può bruciare l’opuscolo informativo Il tuo viaggio oncologico. Ma proprio l’affidarsi alla vita in corso di Anne Boyer, al suo non morire, come perno centrale significa, ancora una volta, privilegiare la narrazione privata, individuale, fatta di crisi acute e scelte passate imputabili della conseguente cattiva salute. Significa ignorare le contingenze di lungo corso, l’invisibile, le forze sistemiche che avvolgono ogni persona senza possibilità di scelta. Libera dalla malattia, infatti, Boyer non guarisce: è debilitata, esausta, sconvolta, ancora dolorante, e nessuna prassi intorno a lei è cambiata per adattarsi alla sua nuova fragilità. La sua storia non ha bisogno di essere raccontata “in ordine”, né si conclude con la fine delle visite e la ricrescita dei capelli: esaurimento e crepacuore si allargano fino ad includere una teoria del dolore e della sua gestione che raccontano, soprattutto, la spossatezza che rovina il resto della vita “salvata”, eppure tuttora a lutto per i nervi cardiaci morti, per le parole dimenticate dal cervello ormai rallentato dai farmaci. La storia di Boyer illustra perfettamente la contraddizione individuata dall’artista Johanna Hedva nel suo testo Teoria della donna malata (2016):
La “malattia”, nel senso in cui la intendiamo oggi, è un costrutto del capitalismo, così come il suo opposto binario, lo stare “bene”. La persona che sta “bene” è la persona che sta bene per lavorare. La persona “malata” è la persona che non può lavorare. L’aspetto più distruttivo del concepire il “benessere” come stato “predefinito”, come modalità standard dell’esistenza, è il fatto che inventa la malattia come temporanea. Se essere malat* è un’aberrazione rispetto alla norma, siamo autorizzat* a pensare che lo siano anche le cure e l’assistenza.(traduzione di feminoska)
In un’intervista concessa al podcast Commonplace, Boyer svela come sia riuscita a creare Non morire scrivendolo come un diario – in piena coscienza della distorsione in atto quando si vive in tempo reale l’esperienza raccontata – invece che come un memoir a posteriori: forzandosi di scribacchiare poche centinaia di parole al giorno contro il consiglio di medici e amici che la volevano immobile a riposo, non certo rannicchiata a rimuginare sulla morte e i guadagni delle industrie farmaceutiche. Le ore di lavoro letterario accumulate nonostante la debolezza smentiscono e confermano il dilemma descritto in un precedente dittico poetico, “Not Writing”/“What Is ‘Not Writing’” (dalla raccolta Garments Against Women, 2015): “non scrivere” perché costrette a letto dalla malattia è un lavoro totalizzante tanto quanto lo “scrivere” vero e proprio. Soprattutto, sono entrambi fonte di profitto per qualcun altro. L’economia mossa da Boyer come corpo malato bisognoso di cure funziona in maniera analoga al mercato editoriale che impacchetta le sue parole in un prodotto smerciabile. Nell’audio-intervista già menzionata Boyer descrive il suo passaggio dai circuiti letterari indipendenti all’editoria “mainstream” come una mossa motivata non (solo) dalla promessa di un anticipo più sostanzioso, o il prestigio necessario per vedersi assegnare un premio importante, quanto dal desiderio di vedere il proprio libro sugli scaffali delle biblioteche pubbliche e delle librerie generaliste, entrando, cioè, in un sistema di distribuzione massiva altrimenti inaccessibile, a malapena imitabile anche dalla sua pratica di rendere disponibili gratuitamente online i pdf dei suoi testi. Arrivare, perciò, alle lettrici che più hanno bisogno, se lo desiderano, di una narrazione alternativa al nastro rosa.
Il senso del privato di Boyer non include la voce in prima persona che descrive la malattia: il contrario del personal essay confessionale, Non Morire non può permettersi di considerare personale quello che, come è accaduto all’io narrante, capita a moltissime altre persone. Boyer è una stronza chiunque – “la stronza giusta” – a cui è toccato il cancro, una di milioni che lo incontrano o lo vedono agire nei corpi vicini tutti i giorni, e non è raro che le recensioni del libro accennino al ricordo di malattie passate o persone decedute: le possibilità per raccontarne l’oscenità sono così sporadiche rispetto alle ubique narrazioni epiche del “farsi coraggio”. Non potrebbe essere altrimenti in un sistema che, approfittando della pudicizia sociale che spaccia per “dignità” l’occultamento della sofferenza può zittire la lamentela pubblica, definendola come ingratitudine, e che negandosi di chiamare il dolore come tale privatizza l’intimità necessaria alla guarigione. Mi piace pensare che Boyer abbia inteso il suo libro come viatico, un approvvigionamento che accompagni chi ne ha necessità durante il viaggio – che sia una sopravvivenza o una morte, propria o altrui – perché io per prima l’ho utilizzato in questo senso, come se fosse la “guida per morire” che Boyer immagina consegnata alla nascita “a ogni persona con un corpo”, per darmi l’illusione di ascoltare l’esperienza di chi, chinato sul catino che gli reggevo, trascorreva i suoi ultimi giorni coscienti scosso dall’ematemesi. Un anno dopo averlo letto per la prima volta, testimone di un ultimo tentativo di chemioterapia, qualche mese dopo averlo letto per una seconda volta, in pieno lutto, alla terza lettura per questa recensione, a mente più lucida o perlomeno illuminata dall’intuizione di Boyer, Non morire continua a commuovermi per la bontà perfettamente espressa che lo anima. La cospirazione che Boyer inaugura mi consola più di ogni condoglianza cortese:
“Fa un sacco di male,” disse un uomo circondato dai suoi figli adulti, e tutti ce ne stavamo nella stanza e poi ci riunivamo a dirci che ciò che a uno sguardo comune sembra far male fa male davvero, così nessuno avrebbe mai più dovuto dire ferendoci che non ci stava ferendo e che ciò che più di tutto fa male (a tutti) non ha mai fatto male a nessuno.