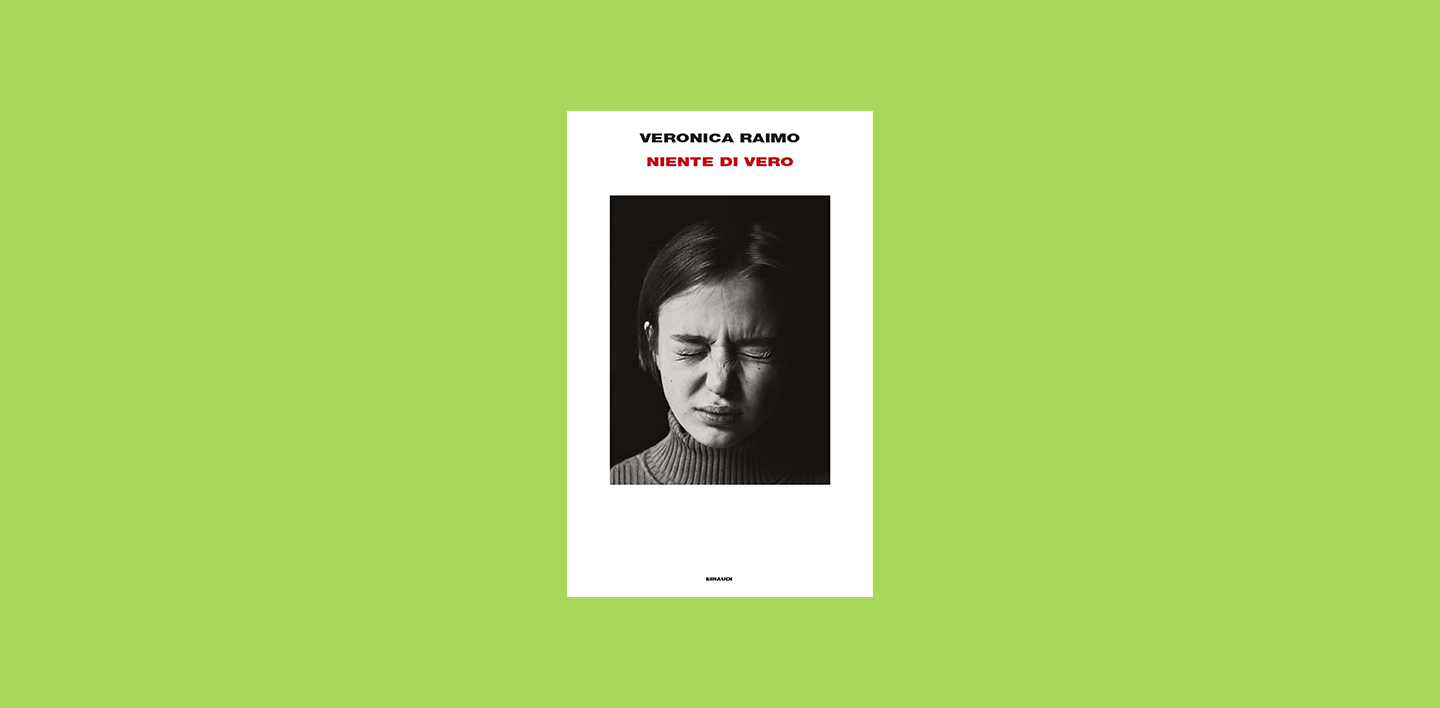A
volte scriviamo non per elaborare un lutto, ma per inventarlo”. In questo paradosso c’è una chiave di lettura dell’ultimo romanzo di Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi, 2022). Per arrivarci, però, diciamo prima dell’intreccio: la voce narrante racconta un’educazione sentimentale e artistica in una famiglia in cui tutto ciò che è vitale e serio si rivela mortale e ridicolo: una verità inaccettabile, che appare al tempo stesso traumatica e comica. C’è l’infanzia con un padre ipocondriaco, divorato dall’etica del lavoro, che parla gridando e si lamenta del mondo. Impedisce passatempi rischiosi come fare sport, nuotare, pattinare andare in bici, considera le vacanze come progetti azzardati che inevitabilmente naufragano nella delusione. Si resta quasi sempre a casa, un appartamento con pareti sottili e senza serrature, dove la televisione è sempre accesa. C’è la vita adulta con una madre che telefona di continuo per lanciare allarmi, pretendere ascolto e chiedere di farle dei nipotini, una madre che apre la posta privata della figlia, la svaluta, la imbarazza in pubblico, ma poi fa la “voce da dodicenne”, per cui “come fai a prendertela con una bambina?” Ci sono poi altri parenti di un Sud ferocemente molesti, parenti crudeli, incapaci di soccorrere gli estranei ma anche i congiunti: nemmeno il familismo amorale li corregge. Solo il nonno paterno sembra comprendere il tormento che si deposita nel corpo della nipote sofferente di stitichezza, e la assiste stringendole le mani; una scena che col tempo diverrà allegorica:
Non ho mai più avuto una persona che mi stringesse le mani mentre pativo sulla tazza del cesso. Chiederlo non è facile. Mi sono restate solo la solitudine e l’inadeguatezza. Ogni volta che vado incontro a quell’afflizione, comincio a rileggere tutta la vita in questi termini: un conflitto costante tra abbandonare qualcosa e cercare di riprenderlo. La maledizione perpetua della terra di mezzo.
I genitori chiamano la protagonista con nomi che non sono il suo – Verika, Oca – lei impara a leggere a quattro anni e condivide pomeriggi di noia infinita con il fratello più grande – genio precoce iperletterato e per questo venerato – a fare giochi di pazienza, a tormentarsi per una questione che nessuno ha il coraggio di formulare: “come facciamo a uscire da questa cameretta? Come facciamo a liberarci?”.
In tutto ciò la voce narrante raramente si commisera, piuttosto invita a ridere. Siamo naturalmente agli antipodi di un mondo narrativo ben radicato nell’immaginario italiano, in cui autobiografia e regionalismo sono spesso combinati a toni elegiaci, le nonne sono buone, le mamme materne, complici, cucinanti, i papà infallibilmente silenziosi, solidi, capaci di ruvide cure. Ma la più autentica originalità di questo romanzo sta nel suo registro, che prosegue una ricerca avviata nelle opere precedenti. Raimo combina lo sguardo astratto di Miden (2018) e la comicità erotica e scanzonata di Bambinacce (libro di filastrocche pubblicato nel 2019, con Marco Rossari). Ci sono espedienti comici classici come iperboli, tormentoni. “C’è Francesca al telefono”, ripetono un po’ tutte le amiche (e gli amici) di Veronica, non più soltanto per riferirsi alle chiamate di Francesca, la madre, a ogni ora e in ogni sede. È una frase in codice per indicare “la sensazione che qualcuna di noi stesse facendo una cazzata”, a conferma che quel controllo anaffettivo materno si annida come un panopticon nelle stesse formule che vorrebbero esorcizzarlo. “Siamo arrivati al paradosso” è invece la frase ricorrente con cui il padre – di fronte a un piccolo incidente – saluta la conferma che vivere è impossibile, gioire impensabile, e conviene chiudersi in casa, bendarsi, mummificarsi.
Si ride, con un po’ di disagio. Non si ha l’impressione di un racconto deformante, che ci permetta di librarci in un’ebbrezza di superiorità insieme all’autrice, ma di un referto letterale su fatti che hanno una loro intrinseca, spaventosa comicità. La risata che la voce apparentemente imperturbabile della narratrice si lascia dietro come una scia non è derisione dei personaggi, ma tentativo di smarcarsi dall’orrore.
Raimo racconta un desiderio di smarcarsi a oltranza, perdersi, rifugiarsi in una metodica non aderenza alla realtà.
È una comicità kafkiana, di figli trattati come insetti, schifati, bersagliati di lanci di mele. È una comicità bernhardiana, di figli rinchiusi in sanatorio, o imprigionati in casa con parenti ostili e chiusi nella paranoia e nel soliloquio. È come se la voce stessa cercasse l’unica fuga possibile dalla realtà, modulando le proprie peripezie grevi con voce e immaginario mitteleuropei. E del resto Veronica, dopo vari tentativi di fuggire e cercare convivenze precarie che precedono i legami affettivi in singolare inversione di causa ed effetto, a un certo punto approda a Berlino. Qui, come tanti suoi coetanei italiani della fine del secolo scorso, cerca almeno un luogo in cui l’assenza di progetti solidi e la solitudine decantino in un freddo bagno linguistico e sensoriale che lava via i ricordi di suoni e sapori italiani: è la città in cui per qualche anno fancazzismo e cosmopolitismo si fusero con un colpo di bacchetta magica. Ma allora i talentuosi fratelli-scrittori che vediamo da bambini diventano dei piccoli nipoti di Wittgenstein, schiacciati da una famiglia disfunzionale, carica di tare – senza più ricchezza, però.
Si snoda così un romanzo di emigrazione incompiuta, della non appartenenza, o almeno del tentativo di non appartenenza, e di sconcerto per il persistere di una mitologia borghese che ha perduto il suo ancoraggio al boom economico. In una versione esistenziale della stitichezza e dell’insonnia che la agitano, Veronica si tormenta tra lasciare andare e rimpiangere anche rispetto alla scelta del suo luogo di residenza: “Ho vissuto a Roma continuando a passare dei mesi a Berlino e rimpiangendo il fatto di non viverci”. Così la vita è un pendolo tra un Meridione morboso che non passa mai, il gorgo di Roma e il Nord Europa come succursale del desiderio. Le cose significative accadono in fuga, se non a Berlino, ad Ascoli, dove la famiglia ha una casa, o comunque in un altrove lontano ma non troppo, dove sempre arriva la telefonata di mamma. Il romanzo viene finito “nei centrotrenta metri quadri dell’appartamento vuoto di una coppia che si [è] appena separata”.
Sul piano dell’intreccio ci sono alcune analogie con un altro romanzo recente, Spatriati di Mario Desiati: quest’ultimo centrato in un Sud altrettanto inospitale, in cui il protagonista gravato dai fallimenti affettivi dei genitori e da una società sessualmente repressiva e violenta, racconta un rapporto amoroso sempre incompiuto, interrotto dall’emigrazione proprio a Berlino. Ma se il protagonista di Desiati conserva una volontà di cercarsi nonostante le circostanze, di fare esperienze e negoziare con la società, Raimo racconta piuttosto un desiderio di smarcarsi a oltranza, perdersi, rifugiarsi in una metodica non aderenza alla realtà. Il processo coinvolge la stessa narratrice, che non si costruisce mai del tutto come identità, che tende a dubitare della propria stessa serietà e riconoscibilità, ma proprio così si caratterizza in modo inconfondibile. La narrazione stessa diventa la trama fragile e discontinua del reale, una messa in gioco evanescente della verità, un passatempo magico imparato durante ore di noia sterminata, come le bolle fatte con la bocca.
In quarta di copertina si parla di modelli come la serie TV Fleabag e il Philip Roth del Lamento di Portnoy. In quest’ultimo si trova certamente una voce imparentata a quella di Veronica, che pure è ossessionato da una madre morbosa. Ma in Niente di vero trovo anche una radice romantica, non nel senso delle retoriche del sentimento di tanto romanticismo di consumo, ma nel senso originario del romanticismo tedesco, quello dell’ironia, disperata e comica. Schlegel diceva che l’ironia è stare con la massima serietà sul palco del teatro e al tempo stesso dubitare della serietà dell’intero spettacolo. “Tutto deve essere scherzo e tutto serietà”. La vita un gioco, perciò crediamo fermamente ai nostri sentimenti, ma al tempo stesso “dobbiamo elevarci al di sopra del nostro stesso amore, ed essere capaci di annientare nel pensiero ciò che pure veneriamo”.
Verso la fine del romanzo la protagonista – nell’unico punto che nella mia lettura ha rotto l’illusione di verità, come a vederci una dichiarazione di poetica – racconta che la madre spesso non la riconosce, la scambia con altre donne. Noi lettori abbiamo visto la sua mano stretta dal fratello, abbiamo conosciuto i suoi mal di pancia, e ora lei afferma di essere irriconoscibile. Sembra volersi smarcare anche da sé stessa, dall’identità narrativa di cui il racconto ha tratteggiato il torso, voler restare incompiuta, non-identica. Rifiuta la narrazione del ritorno e della riconciliazione, del dolore maturato in arte, in saggezza, è reticente a condividere gli affetti più profondi. Pratica una narrazione come infinita lotta con le macchie del reale. Le amiche care spariscono senza un motivo autentico, gli amori si dimenticano, forse sono inventati. Anche l’ipotesi che il padre avesse un’amante, documentata in lettere rubate, possibile reliquia di passioni ardenti di cui in famiglia non s’è visto granché, era forse un romanzo, o almeno un episodio incerto.
L’autrice recupera una scoperta dell’infanzia, quella del gioco di cui s’inventano le regole per rompere la noia, e che diventa gioco letterario.
In questo stallo avviene il rilancio della narrazione. Raimo recupera una scoperta dell’infanzia, quella del gioco di cui s’inventano le regole per rompere la noia, che diventa gioco letterario. Da giovane scriveva infatti lettere appassionate firmate da Amory Blaine, protagonista di Di qua dal paradiso di Fitzgerald, le sotterrava nel parco, poi le dissotterrava per rileggerle. Quelle lettere sono il prototipo del romanzo che abbiamo tra le mani. Quando da adulta diventa scrittrice, la narratrice diffida dell’appartenenza a un sistema culturale in cui la scrittura possa presentarsi come bilancio dell’esperienza, distillato di senso, perfetta ricomposizione della memoria. La scrittura così intesa intenderebbe sciogliere un enigma che non può mai risolversi in piena verità. “Una storia è un concetto ambiguo”, ripete. Siamo tornati al paradosso.
In fondo a questo voler restare nell’indefinizione senza futuro sembra annidarsi un’estrema aderenza a quello sguardo familiare strabico, come se dal lutto per le tante privazioni passate non si uscisse, e tutto si riducesse a una incoerente fedeltà alla delusione, a un caso di Sindrome di Stoccolma. Credo ci sia anche questo, è il lato serio dello sdoppiamento ironico. Ma allora ecco che la “collera ancestrale” si esprime in una mossa scorretta e vincente: fare del lutto stesso un’invenzione. Così, se Alice giocava a far finta “di essere due” e esplorava il mondo attraverso lo specchio, Veronica si rifiuta di dirci da che parte sta lo specchio: “facciamo che sono io”.