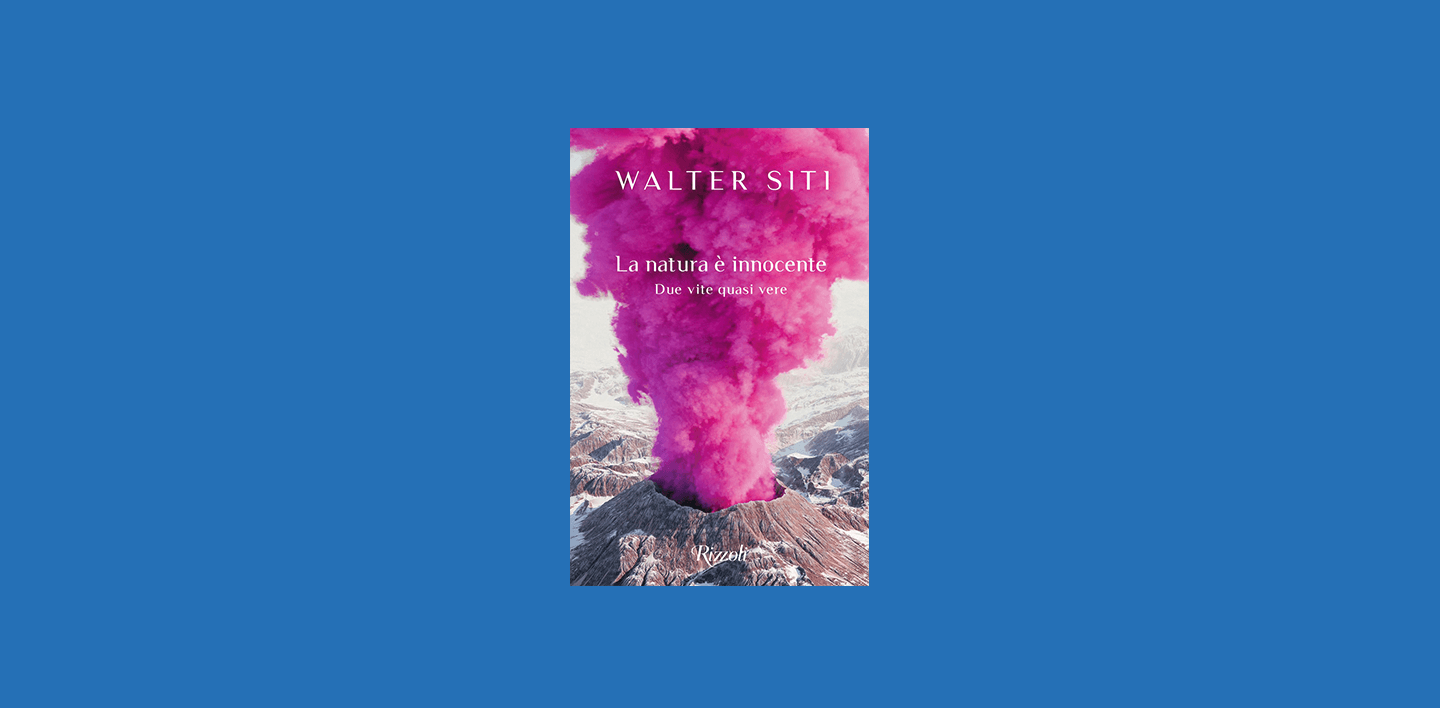
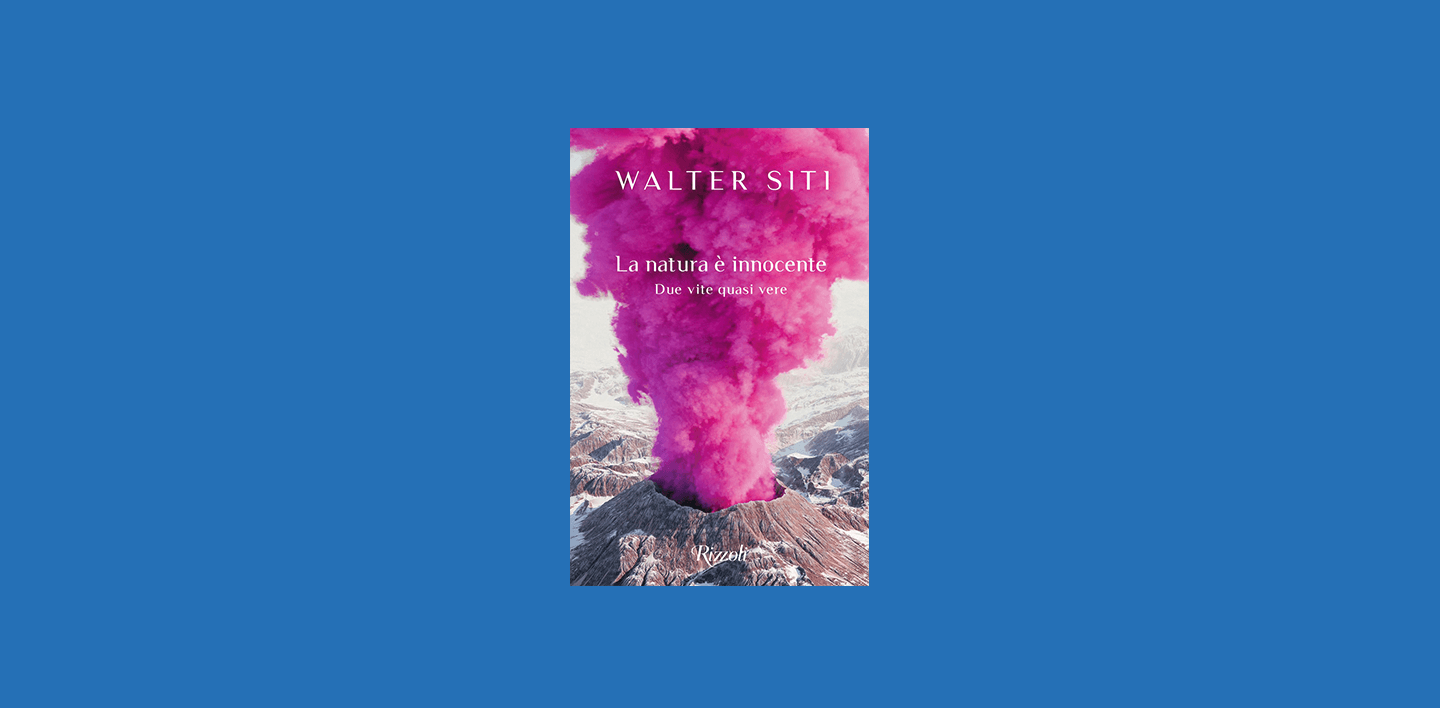
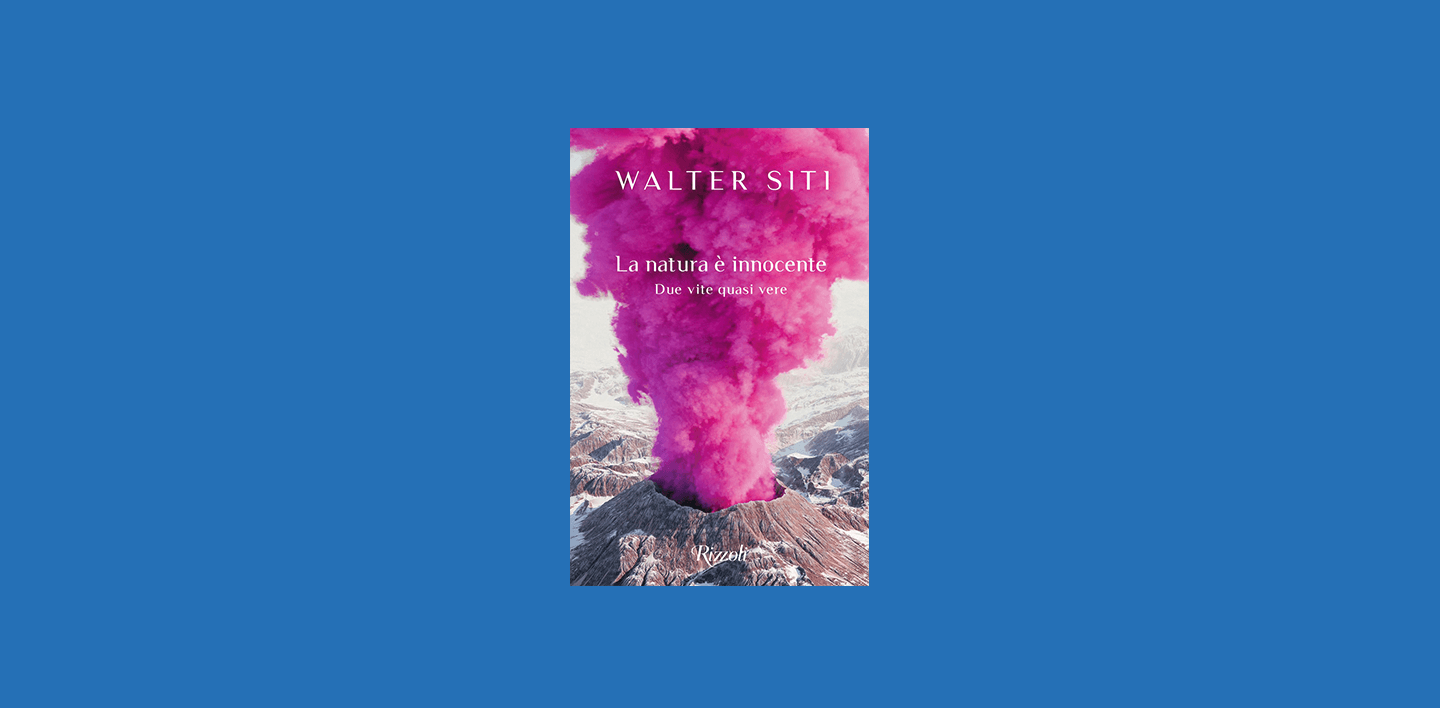
L a natura è riposante ma micidiale per le nostre piccole umanisterie”: verso la metà dell’ultimo romanzo di Walter Siti si apre un “intermezzo vulcanico” ambientato nell’isola dagli echi houellebechiani di Lanzarote. Qui (nell’intermezzo) è questione soprattutto dell’innocenza (come da titolo) della natura. Natura vulcanica, atavica, lunare, favolosa, di fronte a cui si fa strada una “protoumana paura”. Una natura che si mette leopardianamente a parlare e ammonire: “divertitevi pure, consolatevi tra le mie braccia, illudetevi di avermi addomesticato con la vostra “bellezza” e la vostra “cultura”; quando meno ve l’aspetterete, io distrattamente ritornerò e mi riprenderò quello che è mio”. Seguono considerazioni intorno ai vari surrogati della natura stessa (“seconde” e “terze” nature) di cui ci schermiamo pur di non riconoscere questa terribile e altera innocenza che “ubbidisce a delle leggi impermeabili ai fantasmi di armonia che proiettiamo” e che ha la semplice facoltà, in qualsiasi istante, di smantellare la secolare hubris umana (e post- e trans-umana, all’occorrenza): “Se la Natura è innocente possiamo concludere che interpretare l’umanità come errore o come miracolo non cambia un accidente nell’economia dell’universo”, aggiunge infine il narratore nell’“Epilogo”, il secondo innesto saggistico, o meglio lirico-saggistico, del libro.
Difficile ignorare, del motivo naturale che attraversa il romanzo, le sinistre risonanze con la cronaca di questi giorni, e settimane, e forse mesi: alle metafore telluriche che convengono ai temi viscerali di Siti replica il più subdolo pericolo aereo, invisibile e apparentemente immateriale, eppure altrettanto concreto, spietato e innocente; innocente anche davanti alle cause antropiche che possono averlo scatenato:
La Natura è sovranamente indifferente (…) lei che ha l’universo come campo giochi, se ne fa un baffo se in un medio pianeta (…) una specie animale troppo ambiziosa ha reso il proprio habitat una trappola irrespirabile.
Se fosse emersa un po’ prima, la zoonosi come intemerata contro la tracotanza umana avrebbe potuto benissimo fare la sua apparizione in questo testo dove il continuo richiamo al presente (fin nelle note che aggiornano al momento della redazione gli ultimi di sviluppi delle “due vite quasi vere”), si accompagna alla riflessione metaletteraria e ai riferimenti al mito, agli archetipi della tragedia e della commedia. Il cipiglio nichilista o moralista del predicatore apocalittico che addita l’irrilevanza delle cose terrene sarebbe caduto ancora più gravemente tra le vicende narrate.
Non è soltanto lo sfondo incombente di una fin troppo attuale “Natura”, ma il modo stesso in cui viene trattata narrativamente la materia umana del libro a destare l’interesse di un lettore non assuefatto ai codici più scontati della non-fiction (Siti preferisce comunque utilizzare il termine “romanzo”). Sono qui narrate due storie vere ma ampiamente manipolate da un narratore tutt’altro che oggettivo e rigorosamente fattuale, un po’ come ha fatto Capote, o come fa Carrère, per intenderci. A differenza degli altri Siti ammette tuttavia molto candidamente la propria disonestà, facendo di questa ammissione un ulteriore, e significativo, livello della costruzione narrativa. Ai francesi, che amano molto questo genere di scrittura, basta per lo più mettersi al riparo di una pratica etichetta generica: “biofiction”, biofinzione, che lo stesso Siti rilancia alla fine del suo libro. L’autore di Troppi paradisi non fa d’altronde che operare con le vite degli altri come ha fatto in passato con la propria: confondendo le carte, applicando al vero reagenti più o meno fantastici, giocando con la credulità del lettore e modificando in maniera imprevedibile il contratto di lettura. Chissà se riuscirà a divulgare il neologismo in Italia, un po’ come già fece – o contribuì a fare – con quello di “autofiction”.
Un altro elemento specifico di questo “romanzo” è la misura estremamente controllata – quasi avara, verrebbe da dire – del ritmo narrativo. Le due storie, in estrema sintesi, riguardano un giovane matricida catanese, solo da poco in libertà dopo quasi vent’anni di carcere (e già oggetto di una lontana puntata di Storie maledette, la trasmissione di Franca Leosini) e un culturista ex attore porno gay poi diventato ricercatore universitario di matematica, lui pure finito sotto i riflettori televisivi (della D’Urso). L’esposizione mediatica dei personaggi oltre a rivestire di una patina pop l’operazione biografica (biofinzionale) diventa un elemento di riflessione sociologica all’interno della narrazione. Anche per contrasto rispetto allo “storytelling” televisivo, risalta in queste vicende la mancanza di una vera e propria tensione narrativa. Peculiarità che vale per il matricida in particolare, il cui atto criminale è quasi completamente omesso. Nove scrittori su dieci avrebbero premuto con tutta la loro forza il pedale del noir, del thriller, ricamando sugli attimi scottanti prima della violenza e magari spendendo torbide parole sul male imperscrutabile che alberga nell’animo umano, sull’Altro che s’impossessa di noi. Siti al contrario sembra depotenziare l’episodio, lasciando spazio a risvolti più intimi, cercando il ritmo dell’ordinario anche nel dramma e offrendo probabilmente uno spaccato più realistico proprio in questa mancanza di enfasi. Si ammazza, si subiscono le conseguenze di un omicidio, si va in carcere da matricida: tutto senza pathos, in una sorta di freddo automatismo. A quell’attimo tremendo è riconosciuto certo il suo peso e anche, in un certo senso, la sua indicibilità: proprio perciò è lasciato in pace.
Siti sembra lasciare spazio a risvolti più intimi, cercando il ritmo dell’ordinario anche nel dramma e offrendo probabilmente uno spaccato più realistico proprio in questa mancanza di enfasi.
Contano più i contesti (periferie urbane del centro-sud, vite minuscole affamate di senso) nella loro capacità cieca e inesorabile di determinare le azioni umane – l’uccisione della madre fu d’altronde accettata come delitto d’onore da buona parte della comunità del ragazzo – e Siti si spende con lo zelo di un romanziere ottocentesco nella perlustrazioni sistematica di tutto ciò che ha circondato la vita e le gesta dei suoi eroi (impegnandosi molto, in particolare, nella riproduzione della lingua e dei dialetti, con esiti a tratti decisamente ermetici). Il peso degli atti estremi è semmai ricondotto, come si diceva sopra, al mito, a una ripetizione il cui senso sprofonda negli strati più antichi della nostra storia culturale. Oppure, al lato opposto dello spettro di significati evocati dal narratore, il dramma si spegne in una neutralizzazione dell’evento, quale che sia, tipica di una società eccitata e bulimica, dove tutto accade e poi scompare – una moda, un matricidio, un pornoattore (una pandemia?) – dove nulla incide e la memoria, sovraccarica, parifica tutto in un rapido oblio. Siti insiste molto su questo punto sia quando parla di una sociologica “distrazione”, sia nell’Epilogo dove torna sulla medietà fatale che attende forse, al termine della loro parabola, i suoi maledetti o stravaganti personaggi. Anche perciò non resta spazio alla sensazione, anche per questo – oltre che per una precisa scelta estetica – il racconto si sviluppa senza picchi e la trama di queste vite appare più osservata che narrata, più analizzata, modulata, lavorata, che gettata in faccia a un lettore avido di parossismo.
Il realismo di Siti ci parla con lucidità della mondo senza mai scimmiottarlo, al contrario: come ha fatto con l’esibizionismo e il narcisismo nei suoi primi romanzi, mettendo in scena quelle pulsioni sociali ma svelandone i rituali occulti e i significati nascosti, così fa adesso con lo smercio frenetico di emozioni che caratterizza il nostro paesaggio mediatico e in particolare i racconti della cronaca. Togliendo al lettore ogni furbo accompagnamento musicale, offrendo un resoconto asciutto (nonostante la densità dello stile), lo scrittore ci mostra come dietro il sovraccarico emotivo ci sia l’anestesia. Resta pur sempre l’ironia leggera, sovrana, da operetta, tipica della prosa e del tono di questo autore, ma più come un timbro della voce che come un giudizio sulle cose. Un timbro che risalta soprattutto nell’episodio del culturista e in quella specie di ritratto nel ritratto che è la storia del vecchio principe Fieschi del Drago, amante e poi sposo di Ruggero, il culturista pornostar. L’arte di Siti nel raccontare l’umano tocca qui uno dei suoi vertici, forse perché torna a confrontarsi con una materia ben nota: un uomo anziano colto e raffinato che perde la testa per una montagna di muscoli. Nonostante tutta l’estroversione di cui può essere capace, Siti continua a riuscire meglio quanto più si avvicina, in un modo o nell’altro, a parlare di sé. Questione a sua volta affrontata di petto nel bellissimo Epilogo, dove tra versi sciolti, riferimenti al proprio passato letterario, teoria, e autobiografismo confessionale, si chiude magnificamente quello che è a mio avviso il suo migliore romanzo dai tempi de Il contagio.