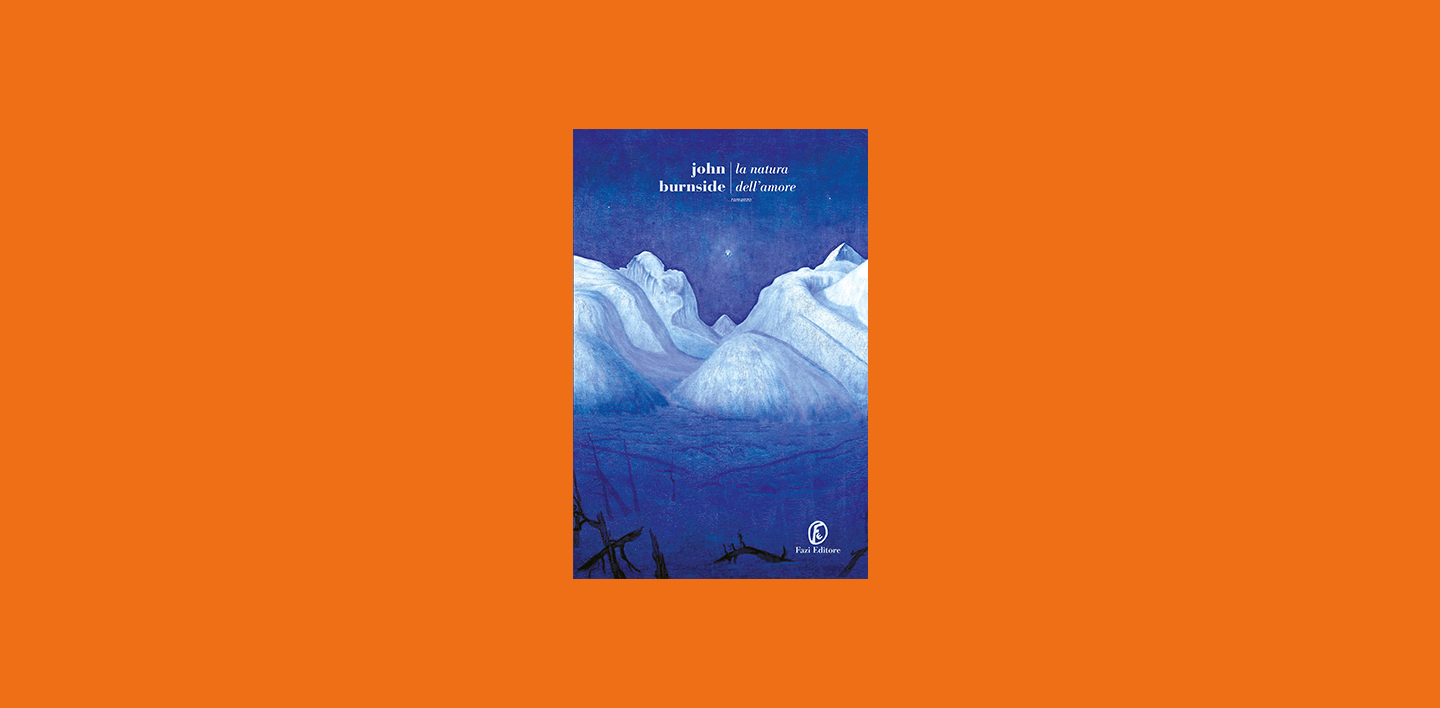
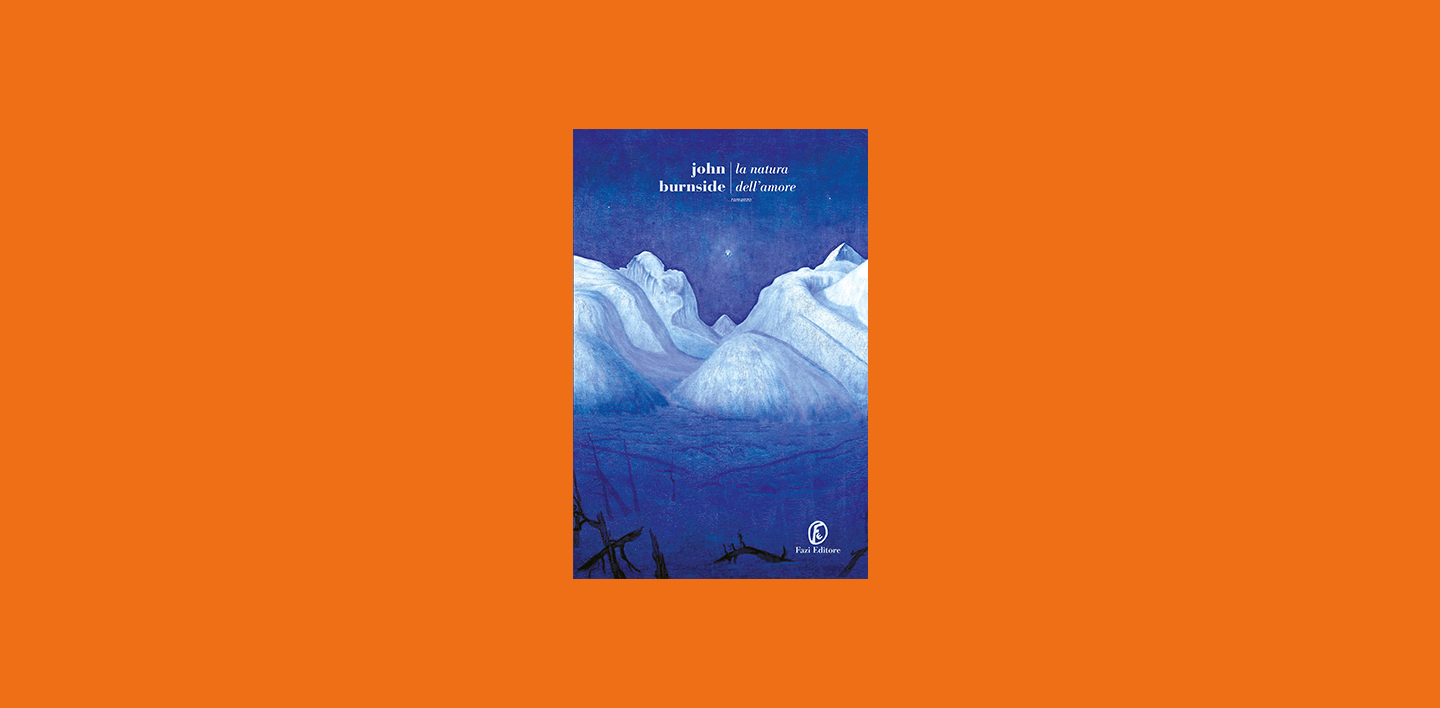
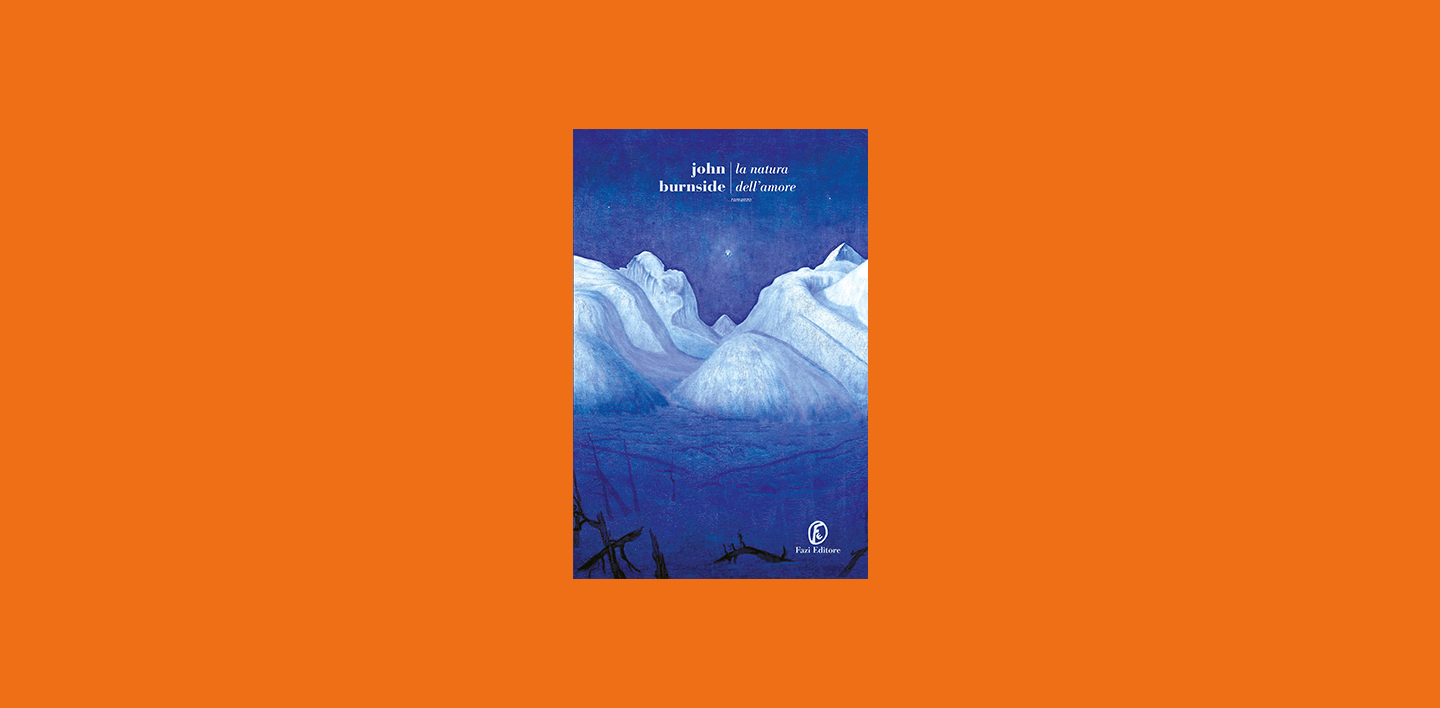
“L eonard la stava baciando. Quando non ne poté più lo afferrò per le orecchie con violenza. Gli allontanò la testa e lo tenne fermo perché vedesse ciò che provava (stava piangendo). Con una voce roca che conteneva una sfumatura di qualcos’altro, forse un senso di pericolo, Madeleine disse ‘Ti amo’.” Questa è la storia di una ragazza che incontra un ragazzo, di come inizino a uscire insieme e del momento in cui, per la prima volta, uno dei due esprime il sentimento con due parole, ti e amo. Di dichiarazioni d’amore di questo tipo son pieni i libri e La trama del matrimonio non fa eccezione: perché iniziare un articolo sulla natura dell’amore proprio con questo tra tutti? Perché subito dopo che Madeleine pronuncia quelle parole, Leonard, il suo Leonard, si alza e va a prendere un libro. Apre Frammenti di un discorso amoroso e glielo porge.
IO TI AMO
Je-t’aime / Io-ti-amo
Madeleine lesse quelle parole e fu immensamente felice. […] Lui le fece cenno di continuare a leggere. “La figura non si riferisce alla dichiarazione d’amore, alla confessione, bensì al reiterato proferimento del grido d’amore.” La felicità di Madeleine si affievolì, il suo posto usurpato dal senso di pericolo […]. “Passato il momento della prima confessione, il ‘ti amo’ non vuol dire più niente”.
Anche a distanza di anni, mi è capitato, di tanto in tanto, di ripensare a questo passo e ogni volta mi sono chiesta perché fosse proprio il meno riuscito tra i romanzi di Eugenides a continuare a ossessionarmi, perché quella frase di Barthes riuscisse ogni volta a mettermi così di cattivo umore: mi svelava che dire l’amore non lo avrebbe reso più comprensibile? Che avrebbe rischiato di sgualcirlo o, forse, che dopo averlo detto non potevo che aspettare il momento in cui sarebbe svanito? Di che cosa parliamo quando parliamo d’amore, insomma?
Se La trama del matrimonio era, oltre al racconto di una relazione nata in un college americano, un gioco metaletterario su come impariamo ad amare la letteratura (o) attraverso la letteratura, se persino le domande che mi ponevo erano la diretta citazione di uno dei miei racconti preferiti di Carver, probabilmente non era nei libri che dovevo cercare una risposta sul sentimento su cui mi interrogavo così di frequente. O forse sì.
Si chiama ambiziosamente La natura dell’amore il nuovo libro di John Burnside che Fazi ha pubblicato quest’anno, con la traduzione di Giuseppina Oneto: una serie di articoli e saggi, del giornalista e poeta scozzese, legati più o meno strettamente tra loro e al tema dell’amore. Se non altro, lo avrei potuto usare come guida nell’esplorazione del sentimento che più di tutti rischiava di descrivermi. Romantica, sentimentale, a un passo dalla sdolcinatezza, la mia educazione emotiva iniziava con le rom-com americane e si infrangeva tra le pagine di Roland Barthes, l’autore che aveva avuto il compito di rivelarmi che love is a language, can’t you read? Nella certezza che tutto quello che avrei mai provato, lo avrei provato filtrato attraverso qualcosa che avevo letto – una volta, durante un’intervista, Michele Mari mi aveva ripetuto l’aforisma di La Rochefoucauld che dice, più o meno, che se gli uomini non avessero mai letto storie d’amore, non si innamorerebbero mai – forse potevo trovare una rassicurazione nel fatto che quel sentimento era più grande di me, che mi avrebbe preceduto e succeduto. Forse, mi dicevo, era stato l’amore a rendere quei libri migliori, più credibili, e non viceversa.
I put a spell on you: il libro di John Burnside inizia con un bel saggio su Nina Simone e su come le canzoni si appiccicano alla vita senza chiedere permesso. Si apre con un bambino che si trasferisce con la famiglia in una casa infestata dai topi a Cowdenbeath e si innamora perdutamente della cugina Madeleine (un’altra Madeleine!):
Aveva dieci anni più di me ed era fidanzata con Jackie, un marinaio della marina mercantile, ma fu grazie a lei se capii che i testi delle canzoni che sentivo a Juke Box Jury o alla radio di mia madre avevano un significato. A me erano sembrate soltanto parole, frasi insulse e iperboli impossibili che nessuno avrebbe preso sul serio; adesso le vedevo in modo diverso perché, adesso, ero innamorato e l’amore sortiva un effetto molto strano, come ascoltare le prime righe di una storia di cui non avrei mai letto la fine perché apparteneva a qualcun altro.
Il grande incantamento, però, era avvenuto più avanti, quando, in un piovoso sabato pomeriggio, Madeleine si era seduta nella sua cucina insieme a John e sua madre: la ragazza aveva messo su una canzone ed era proprio I put a spell on you di Nina Simone, “nell’arco di due minuti e mezzo giunsi alla conclusione che non avevo mai sentito niente di più bello. Smisero tutti di parlare e, quando il pezzo finì, rimanemmo seduti intorno al tavolo ammutoliti finché Jackie non si alzò e lo rimise da capo”. Ti ho fatto un incantesimo: quella canzone, in quella versione, era riuscita a cambiare la consistenza dell’aria a incidersi nello spazio e nella memoria di un bambino, scandendone il resto della vita, come poche altre canzoni sarebbero riuscite a fare.
E, come nella migliore letteratura, la narrativa della vita si ripete: anni dopo, durante l’università, al Charolais, un locale di infimo ordine di Corby che però tutti frequentavano, una ragazza di nome Annie si era sporta dallo schienale della sedia verso John e gli aveva cantato una versione semiprivata di I put a spell on you, una versione che sapeva di caffè, rum bianco e Creedence Clearwater. “Rimasi di sasso”, scrive Burnside, “Annie non la conoscevo granché, anche se spesso l’avevo notata quando entrava perché non la smetteva mai di ridere, di prendere sempre in giro, fra il leggermente isterico e l’esaltato, chiunque avesse intorno, soprattutto se stessa: era un’incurante ragazza ingenua e un po’ spaventata di diciannove anni”: con quella canzone gli aveva regalato un momento perfetto, non importava che Annie non l’avesse cantata espressamente né per lui né per i suoi amici, non importava se in quel momento John avesse una relazione con una donna sposata, Karen, e che questa fosse ormai arrivata al capolinea (quella notte le avrebbe detto, “Non mi interessa nessuna tranne te”, solo per scoprire che, a volte, le parole sono soltanto parole).
Immagino che Annie avesse scoperto da qualche parte, probabilmente a scuola, il potere di una nota sostenuta e che ovviamente avesse già cantato in quel modo, soprattutto per se stessa: senza dubbio per sviare le critiche, ma anche per riaffermare una sua vaga speranza, la speranza che – come tutte le canzoni si pregiano di sapere, malgrado le tante prove contrarie – l’amore sia reale.
Una canzone poteva cambiare un’intera vita? Burnside sembra piuttosto sicuro che la musica sia in grado di cancellare tutto quello che non andava dell’amore così come lo si era conosciuto prima: aveva detto “se una melensa canzone d’amore sopiva un po’ il senso di sconfitta, chi ero io per prenderla in giro?”. “Stars appear and shadows are falling / You can hear my heart a-calling / A little bit of lovin’ makes everything right / I’m gonna see my baby tonight!”: Carl Wilson è un critico musicale canadese, autore di un breve saggio uscito qualche anno col titolo Musica di merda, e quelle parole appartengono alla canzone Oh boy! di Buddy Holly. In quel libro racconta di un pomeriggio in cui, all’inizio della loro relazione, la sua futura ex-moglie, la scrittrice Sheila Heti, si era ribellata alle frecciatine di Wilson sui suoi gusti musicali (poco raffinati a suo avviso) girandosi verso di lui e cantandogli questa canzone. La sua vendetta era stata donargli un ricordo d’amore perfetto, accompagnato da una canzone che lui non avrebbe mai scelto altrimenti: “Non c’era nient’altro, di più stratificato o contraddittorio, da dire. Oh Boy! esprimeva esattamente come si sentiva, proprio lì e in quel momento, verso di me. Non penso di essermi mai commosso di più di fronte a una dichiarazione d’amore, nemmeno durante la cerimonia nuziale. Raramente mi sono sentito così onorato, così umano, così sicuro che essere semplicemente umano fosse abbastanza”.
Ma, dov’è l’incantesimo, lo spell, la stregoneria di cui parlava Nina Simone? La natura dell’amore non è solo la celeste, olimpica sensazione del primo giorno di primavera: il saggio di Burnside parla soprattutto di povertà, di un padre violento e di una madre che fino alla fine non aveva mai osato sperare niente di più di quello che aveva ottenuto, di malattia mentale; parla del lato selvaggio delle cose, della glamourie, che definisce come “la zona scura in fondo al luna park”, il posto dove tutto può accadere, dove si incontrano “i romantici e i depravati, gli esperti di sofferenza e gli asceti più tenebrosi, i poveri d’anima, coloro che vogliono tradurre il sortilegio e il voodoo in moneta sonante”.
Infatti, la versione originale di I put a spell on you non è quella quasi classica di Nina Simone (così definiva la sua musica, non jazz, ma classical black music), ma quella di Screamin’ Jay Hawkins, piena di grazia dissennata, una specie di baracconata eccessiva in ogni sua parte, cantata da un uomo che pareva trasformarsi nella parodia di se stesso. Burnside aveva scoperto la fonte originale dello spell qualche anno dopo la grande rivelazione avvenuta nella cucina di Madeleine: se la canzone si era salvata era perché era stata reinterpretata dalla musicista, ma il segreto della sua bellezza stava proprio in quello oscuro glamour barocco, nel lato selvaggio che Screamin’ Jay era riuscito a cristallizzare. Quell’uomo aveva compiuto un incantesimo: “questo faceva il glamour; letteralmente: e chi compiva l’incantesimo poteva essere brutto, imperfetto, povero, addirittura ributtante in un certo senso, ma dotato di un potere veramente misterioso e del tutto inspiegabile”.
Screamin’ Jay si poneva al di fuori della Versione Autorizzata della cose, come la chiama Burnside: se la bellezza della voce di Nina Simone potevamo provare a descriverla con le parole, il fascino di Screamin’ Jay faceva riferimento a qualcos’altro, all’altro lato dello specchio, al retro della pagina, a quello che Burnside definisce, utilizzando un termine scozzese, thrawn. Le urla del musicista trasformavano l’incantesimo in una magia nera, in una vendetta minacciosa: l’amore era una cosa vischiosa e terribile che mi circondava e Screamin’ Jay lo sapeva e ne rideva, urlando I love you. Altro che Eugenides, altro che Barthes che scandagliava bonario i rituali dell’amore: improvvisamente ci trovavamo in un posto oscuro, dove regnava “l’ordine disordinato, la bellezza dell’inutile, il valore della riottosità, il gioioso progetto del rifiuto”.
“Senza lato selvaggio non c’è ordine, – scrive Burnside – senza perversità non c’è purezza; e senza la bellezza irregolare e la grazia inesplicabile del thrawn è impossibile qualsiasi forma di proporzione”: così parla delle murder ballads, moniti in forma di fiaba, dei freak, da Diane Arbus in giù, di tutti quegli interventi imprevisti di straordinaria e riconoscibile bellezza, della follia e dell’ossessione e del panico. L’amore lasciava in bocca il sapore del sangue, l’amore sapeva di whisky come l’alito di un padre incattivito, l’amore si confondeva con il sapore metallico degli psicofarmaci che gli avevano prescritto quando si era ricoverato al Fulbourn Mental Hospital, nel tentativo di rimettere ordine alla sua vita, dopo una settimana passata in preda alle allucinazioni. Con la clorpromazina in corpo e una diagnosi di psicosi paranoide, Burnside camminava per la clinica, incantandosi di fronte alla fragile Cathy, che volteggiava nel parco col “corpo sospeso in un campo di forze proprie, dolce e selvaggia e inviolabile, tracciando cerchi perfetti nella luce mielata che l’attraversava”.
C’è questa cosa nel libro di Burnside che, per quanto provi a sopportare, trovo intollerabile: un certo e preciso sguardo sulle ragazze, Ifigenie inermi, sacrificatesi a qualsiasi cosa si possa intendere con destino. Di Cathy scrive:
rimasi colpito, col sospetto che si trattasse di un ultimo congedo dallo stato allucinatorio in cui mi pareva di aver versato per mesi, dall’assoluta bellezza del momento e insieme dal pensiero che quella donna che non conoscevo, per raggiungere tale stato di grazia, era stata costretta a lasciarsi scivolare nella pazzia e quindi in una posizione indifendibile,
ma questa non è nient’altro che la fantasia di un uomo che crede che la ragazza perduta sia perduta per sempre. Se Cathy non sopravvive a se stessa, non è per rispondere a una narrativa che fa comodo a tutti, tragica e facilmente spendibile, se Cathy non sopravvive è perché la malattia mentale è un circuito che si avvita su se stesso, perché le medicine sono sbagliate, perché le cure non sono sufficienti, perché la vita spezza gli uomini e le donne ogni secondo.
Mi spingo su un terreno insidioso se dico che questa raccolta racconta una storia di formazione emotiva che potrà dire più a un ragazzo che a me, ma Burnside scrive da un punto di vista che è al di qua di un anelito universale, non so se per incapacità o perché non tutti i libri hanno il dovere di parlare a tutti, anche quando il fatto stesso di essere uomini e bianchi dà il privilegio di essere universali, di trascendere il genere anche in mancanza di reale talento. Forse è la mia formazione a rendere questo racconto lontano e odioso, ma anche il saggio sull’ossessione per la drown girl non depone in suo favore; lo scrivo perché provo a comprendere quello che Burnside scrive: perché l’impressione è che della fine tragica di Cathy, del suo suicidio, tutto sommato a lui non dispiaccia così tanto, se non per quello che quel suicidio significa per lui, come se non prendesse sufficientemente sul serio la malattia mentale della ragazza, almeno non tanto quanto prende la sua, nel tipico delirio di onnipotenza di quegli scrittori che inventano queste figure femminili solo per farle perdere nella notte. Con la differenza che Cathy non è neanche una figura di parole, ma una persona che ha vissuto.
Si chiama Separazioni il saggio di Geoff Dyer – con cui Burnside condivide più di un punto – il testo che più avevo amato de Il sesso nelle camere d’albergo. Raccontava di Dyer a Belgrado: era in Serbia per partecipare a una mostra dal titolo Crimini contro i serbi e là le foto dei corpi con le gole tagliate si sarebbero sovrapposte alla neve e alle immagini che scorrevano sulla televisione della stanza d’albergo dove si consumava la relazione tra lui e una donna che non avrebbe mai più rivisto. Dyer scrive che la vita è fatta di addii, non di ricongiungimenti, “perciò abbiamo le canzoni e le fotografie” e quel passo che avevo evidenziato mi era tornato in mente mentre leggevo di Burnside e del suo amore per Christina, una ragazza che aveva baciato una notte a Cambridge e che poi non aveva mai più richiamato: lo aveva fatto nell’ostinata certezza che la possibilità dell’amore sarebbe stata superiore all’amore stesso, che un momento così perfetto non l’avrebbe più potuto vivere con Christina, che, per dirla con Barthes, “passato il momento della prima confessione, il ‘ti amo’ non vuol dire più niente”. Aveva sacrificato Christina sull’altare dell’idealizzazione, facendo convergere in lei tutte le donne della sua vita: da Madeleine con le sue canzoni, agli amori adulti, fino a sua madre.
Di lei, la persona che era riuscita a ricavare un’oasi di pace in un’infanzia di abusi e violenze, conserva il ricordo di una donna che cantava in cucina, “una versione più giovane di lei (anche per contrastare i ricordi del fantasma vivente che era diventata prima di morire, a quarantasette anni, per un cancro alle ovaie)” in cui risuona il modo in cui Barthes parla della propria madre ne La camera chiara. Continua, “so che se tutti vivessero come lei, le ingiustizie connaturate a un sistema fondato sul classismo non solo continuerebbero, ma si moltiplicherebbero”, che avrebbe voluto morisse
non come un sogno che aveva attraversato la vita degli altri, ma come la persona che era, concedendosi di far emergere la rabbia e il risentimento e il giustificabile disprezzo perché finalmente si dissipassero,
ma anche questa mi pareva la richiesta di un lasciapassare, il bisogno di un perdono per non aver potuto rimediare a tutto il dolore che aveva sopportato la madre per rendere la sua vita di figlio più sopportabile, che persino questo desiderio di ribellione non fosse nient’altro che un modo per fugare i suoi sensi di colpa. Scriverne era fare ammenda, ripensare a Christina era comprendere la perdita che aveva imposto a una ragazza, il cui unico difetto era di essere fatta di carne e di sangue. La natura dell’amore si chiude così, guardandosi indietro, provando a imparare qualcosa dall’amore, da quello che si trova nella parte oscura del luna park, qualcosa che parli di bellezza, senza parlare di perfezione, di cicatrici, di ricordi che continuano ad accadere nel presente, di finali che possiamo cambiare. Finisce con un augurio:
We’ll meet again […] il romantico non resta mai troppo indietro per dire: sì, ci rincontreremo, sì, è inevitabile, la madre e il figlio, l’amato e l’amata, il padre e il bambino. Ci rincontreremo. Ci rincontreremo sempre, e ancora, e ancora e ancora. Ma non come l’idea che avevamo di noi.